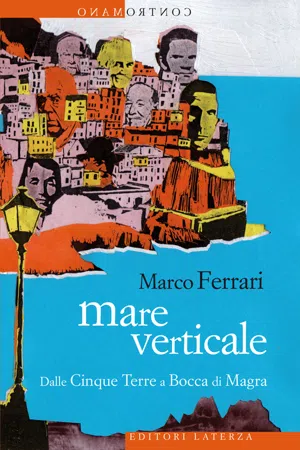Da Lerici a Bocca di Magra
Totò si faceva fotografare in barca, sul molo; François e Nicoletta trasformavano la cala dell’Eco del Mare in un ritrovo del bien vivre; Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello giravano qui Marinai, donne e guai; i motoscafi Riva sfrecciavano davanti al lido; la castellana Madì avviava uno dei primi ostelli della gioventù in Italia: negli anni cinquanta a Lerici si respirava un clima internazionale, come a Saint-Tropez o Portofino. Un clima che contagiava sia i villeggianti che gli stanziali, non separati da barriere sociali, come conferma l’incredibile vicenda che vede uniti Valentino Bompiani (1898-1992) e Mario Spagnol (1930-1999) che finirà per determinare la storia dell’editoria italiana nel secondo Novecento.
Un giorno del ’54 uno scapigliato ragazzo con un forte accento locale si mise a discutere con Fabio Mauri (1926-2009), artista dell’avanguardia, sul valore dell’arte. Era Mario Spagnol, amante della pittura ottocentesca, composto studente dell’Università di Pisa con alle spalle un anno passato a Colonia. Citava Rickert e Heidegger, parlava con competenza dei macchiaioli e dei futuristi, documentava le proprie idee, contestava le installazioni che l’artista romano aveva collocato nel Piasseo lericino assieme a Turcato, Rotella, che era arrivato a strappare i manifesti parrocchiali per comporre la sua opera e altri artisti della famosa galleria La Tartaruga fondata a Roma da Plinio De Martiis.
L’accanimento del confronto non smorzò l’interesse che Mauri provò per quel giovane lericino. Le discussioni continuarono nei giorni a venire quando Spagnol incontrò di nuovo sul molo Fabio assieme ai fratelli Luciano e Achille. Erano i tre nipoti di Valentino Bompiani, figli della sorella Maria Luisa che, dagli anni quaranta, aveva acquistato la Villa della Rupe Canina che sovrasta la cittadina rivierasca. Lerici l’aveva scoperta Silvana Mauri, la maggiore dei nipoti, accompagnando lì un amico che aveva ereditato un rustico alla Caletta. Rimase incantata e convinse lo zio Valentino a comprare la bella residenza e i suoi genitori ad affittare l’ultimo piano della attigua Villa Bardellini, visto che i giardini confinavano.
I fratelli Mauri parlarono con lo zio combinando un incontro.
Anche al cospetto del grande editore, oltre il giardino, Spagnol resse il confronto. Apprezzò ad esempio le opere pittoriche di Valentino Bompiani, che d’estate amava disegnare in giardino con diversi tipi di materiale, compresi i legni lavorati dal mare, individuandone spunti colti ora da Hieronymus Bosch, ora da Giuseppe Arcimboldo. Il ragazzo di Lerici fu dunque ammesso all’ampia corte di Bompiani annidata nella Villa della Rupe Canina, nella vicina Villa Bardellini e nelle antiche case del Poggio. Una tribù intelligente e bislacca, un clan di vacanzieri, circondato da amici, scrittori di passaggio, intellettuali erranti che conquistava la piazza lericina.
Ad Achille Mauri, figlio di Maria Luisa Bompiani, sorella di Valentino, brillano gli occhi di giovanili passioni rammentando l’immagine di un pomeriggio estivo: «A Villa Bardellini, nel campo di pallavolo – racconta – formammo due squadre composte da Valentino Bompiani, Gianni Letta, Mario Tobino, Umberto e Luciano Mauri, Ottiero Ottieri, Giorgio Positano e altri. Io e Mario Soldati, in quanto piccoli, io per età, lui per altezza, eravamo impegnati a prendere le palle basse che Spagnol, il più alto tra noi, schiacciava a terra».
Achille Mauri faceva parte della banda di Maralunga, fissa da Ciccillo a Mare, spiaggia del castello (ora molto ridotta a causa dell’erosione), rocce e juke box, nuotate e cazzottate. Mario Spagnol era uno dei ragazzi di via Roma, socio in affari con Veio Sampiero, l’intellettuale e lo scaltro, il ragazzo erudito e l’eroe. Quando i tedeschi misero una bomba nella chiesetta di San Rocco per farla esplodere, Veio corse sino all’altare, prelevò l’ordigno e percorse 400 metri per gettarlo a mare. Semplice e spavaldo, operaio del Muggiano, veleggiava nelle calette di Lerici portando a spasso le belle americane figlie dei graduati della vicina base Nato. Di sicuro oltre «yes» non sapeva dire perché di solito si esprimeva nel bislacco dialetto lericino, già marcato dalle asprezze della Lunigiana. Le bande spesso si contrappongono, si incitano l’un l’altra, si fregano le donne, occupano le spiagge notturne, fanno delle bravate. In una di queste occasioni Achille Mauri perde il suo migliore amico, Franco, che a soli quattordici anni muore lanciando una bomba a mano nell’acqua per raccogliere pesci.
Fuori delle mura della Rupe Canina i buoni figli di casa Bompiani si trasformano in ragazzacci liberi e arditi. Dentro le mura cercano di ricomporsi ascoltando i discorsi complessi degli adulti. C’è Guido Piovene con famiglia che alloggia al vicino Hotel Doria ma passa le giornate in quel giardino fatato; c’è Alberto Moravia, severo e burbero, anche in tempo d’estate; c’è Italo Calvino, irrequieto per la fine che sta facendo la sua Liguria negli anni della speculazione edilizia; c’è Renato Guttuso che non smette di tenere la sigaretta tra le labbra e che al motivo del fumo sta dedicando una serie di ritratti in cui vuole cogliere la tensione spirituale e il moto delle passioni di quell’atto che sembra solo una valvola di scarico; c’è Cesare Zavattini, esuberante e allegro, ciarliero e bontempone, berretta in testa, anche se continuamente accaldato. Passano qui giorni di riposo e lavoro Dino Buzzati, Elio Vittorini, Pier Paolo Pasolini e Alberto Arbasino. Litigano Alberto Moravia e Guido Piovene perché quest’ultimo si sente tradito a causa della mancata vittoria al Premio Viareggio 1963, assegnato postumo ad Antonio Delfini, nell’anno della sua scomparsa.
Bompiani non vuole perdere il dialogo con i propri autori, con la A maiuscola, neppure nel periodo delle vacanze. Vuole fare squadra anche portando la camicia fuori dai pantaloni, abbronzato e tirato, ammettendo raramente amici in zoccoli e costume da bagno. Per lui il rapporto con gli autori non è quello tipicamente editoriale. Come ha scritto Carlo Bo, Bompiani è amico degli scrittori, consigliere, testimone, soprattutto, «coinvolto nella costruzione di una nuova civiltà letteraria» da quando ha avviato le attività in proprio dal 1929. Perché, come ha sostenuto Orio Vergani, lui intendeva il ruolo di editore «come una regia, e cioè come una costante, sia pure indiretta, collaborazione con i suoi autori». Così ogni uscita contiene «il segno del suo gusto, di una sua personale cultura: e spesso un meritorio desiderio di scoperta». E Umberto Eco, che gli stette accanto vent’anni, ha chiarito perché Bompiani amava quel lavoro: «Per dare vita ai libri che gli sarebbe piaciuto leggere e forse ai molti che gli sarebbe piaciuto scrivere. Amava gli autori perché avevano scritto i libri che lui amava, e l’ho visto rinunciare a libri che avrebbero potuto rendere bene solo perché gli erano antipatici gli autori».
Un editore protagonista, secondo una propria concezione, che ha la certezza di essere un «eroe di buone maniere», come lo definì Raffaele La Capria, a cominciare dall’entusiasmo che precede la pubblicazione di un libro. E in quelle lunghe estati lericine elaborava persino il gusto del successo che presto avrebbe toccato con mano.
La Villa Bompiani, come oramai tutti la chiamano a Lerici, si allarga con numerose appendici: la confinante Villa Bardellini, dove risiede la famiglia Mauri, di proprietà della signora Angelica, una delle donne più belle della cittadina ligure; le case del Poggio, nella cui piazza i ragazzi crescono e dove si sistema Ottiero Ottieri con Silvana Mauri e i figli Maria Pace e Alberto; la torretta sulla cima della collina dove di solito vengono alloggiati gli ospiti stranieri e i traduttori. Da un cancello sul versante di levante si scende direttamente sulla scogliera dietro al castello dove le palafitte di Ciccillo diventano una palestra di vita. Tre cabine, vicino all’uscita della proprietà, permettono agli ospiti di cambiarsi e quindi di correre verso il mare.
La villa, alta sui tetti rossi di Lerici vecchia, sulle erte e le creuze, sopra il ghetto e poco distante dal castello, elegante tassello di un villaggio arroccato che ha perso le proprie mura per l’espansione urbanistica, è una specie di maniero da cui si scruta ogni angolo di cielo, un faro da cui individuare l’inizio del giorno, il termine della notte, l’arrivo delle burrasche e la dolcezza marina della calma piatta. Bompiani la acquistò da un comandante marittimo dopo averla vista per interessamento di un personaggio assai conosciuto a Lerici, Dorino Passalacqua, e affidò la ristrutturazione all’architetto Luigi Vietti.
«All’inizio, praticamente – dice Ginevra – abbiamo vissuto quasi sempre con gli operai in casa, oltre ad una famiglia di sfollati che è rimasta a lungo con noi».
Fuori è tutto un saliscendi con viali e scale sotto i pergolati, terrazze e belvedere, un bunker tedesco ben nascosto nel fogliame. Dentro è composta da un piano terra ricco di saloni, un primo piano con una camera, una stanza grande e un terrazzo che dà sul portico e quindi un secondo piano con le camere da letto.
«La stanza al primo piano – racconta Ginevra Bompiani – ospitava mia madre, poi quando abbiamo capito che stava per morire l’abbiamo spostata nel salone davanti alla vetrata piena di luce». Nini Bompiani Bregoli spirò nell’agosto del 1992 pochi mesi dopo l’addio del marito. Lei non voleva più vivere senza Valentino.
«Non ce la faccio più, aspetto che Valentino mi chiami, ma quand’è che mi chiami?», diceva sino alla fine trafiggendo la distanza del tempo. Tanta era stata l’apprensione per l’estremo viaggio di Valentino, sentendo il tragitto esistenziale oramai concluso, tanto era ora il desiderio di Nini di chiudere la pagina terrena, giudicando i suoi giorni inutili.
Le stanze della casa tipicamente ligure, disposte a varie altezze e con ingressi diversi, sono quasi un incastro che consente incontri casuali e distacchi voluti. Nel porticato d’ingresso Bompiani fece costruire il suo studio, isolandolo dal resto. Era uno stanzone rettangolare con pavimento in maiolica, su cui era impressa la figura di un cavaliere, una libreria ricavata da scalette di battelli ottocenteschi, due sofà, tanti cuscini e un tavolo tondo. Cercava la pace dalle urla dei ragazzi e dei bambini che si inseguivano tra le piante e gli arbusti gridando per farlo arrabbiare: «Zio Val! Zio Val!».
«Volevo giocare tutto il tempo – racconta Ginevra Bompiani – con mio cugino Achille che stava nella Villa Bardellini, confinante nella parte alta del giardino. Ma per stare insieme dovevamo scavalcare un muro rischiando di romperci il collo. Ad un certo punto Angelica Bardellini si stufò e decise di aprire un cancelletto solo per noi».
Nel giardino giravano storie vere e storie inventate, romanzi mai finiti e intrecci lasciati a metà, cassati o da correggere, ma come spesso avviene nessuno ci metteva mai mano. Giravano anche tanti successi da classifica o da premio letterario. Ma anche insuccessi umani e poetici, come quelli di Carol Gaiser, alla quale Maria Pace Ottieri ha dedicato uno struggente ritratto nel libro Promettimi di non morire (2013).
Carol Gaiser ha conosciuto Silvana Mauri a Roma nel 1962 quando era studentessa. Era una ragazza americana che amava scrivere poesie, circondarsi di intellettuali, bere un Cinzano al Caffè Rosati, leggere «Vogue», portando a spasso la sua bella gioventù tra scrittori e sceneggiatori che subito la abbordavano per la sua ingenuità e spontaneità impressa nel volto sincero, labbra pronunciate, naso all’insù, capelli cotonati, un forte accento che segnava il suo scarso italiano. Ha intrattenuto un lungo contatto umano, fatto di incontri, telefonate e lettere sino alla morte di Silvana. Poi Maria Pace Ottieri si è messa sulle sue tracce ricomponendo il puzzle di una esistenza ai margini del grande sogno americano.
Nel suo romanzo mai pubblicato e probabilmente mai finito, Carol rievocava i giorni felici passati con Silvana a Lerici: «Azzurro mediterraneo era il colore che vedevo dalla terrazza della villa di Silvana, consumando una tardiva colazione, mentre la cameriera mi girava attorno, offrendomi marmellate e latte caldo. Ero sempre l’ultima a svegliarmi. Lasciando i figli alla bambinaia, Silvana scendeva la mattina presto al mare per tornare all’ora di pranzo. Era un omaggio alla nostra amicizia il fatto che non si lamentasse mai del mio lento risveglio, e che mi lasciasse libera di adeguarmi ai suoi programmi solo quando fossi stata abbastanza sveglia per decidere».
Il tempo lento della Villa della Rupe Canina favoriva la fantasia dei grandi e dei piccini. Nell’infinito del mare, puntellato di isole, si coglievano storie che nessuno avrebbe carpito alla forza del vento o all’irrequietezza delle onde, figure immaginarie che l’azzurro violento faceva appena trasalire o fantasmi che approdavano sfiniti alle calette per risalire sino alle finestre aperte della villa e insediarsi per sempre su un comodino o dentro un’anta di un armadio rimasta mezza aperta. I bambini, soprattutto loro, alimentavano leggende di mare e vivevano la loro ribellione lontano dalla regolarità milanese a cui erano abituati. Qui vigeva la libertà. Si facevano conquiste di vita. Si avanzava nei gradini della conoscenza umana. Poi c’erano riti consolidati, le cene in terrazza, i cocktail, gli arrivi e le partenze degli ospiti, gli anniversari e i compleanni.
Quello di nonna Nannina coincideva con quello di Achille Mauri e quindi il piccolo si vedeva defraudato dell’atteso evento. E poiché l’anziana signora di casa Bompiani visse 101 anni, per lui restò in vigore un discreto oscuramento, almeno così assicura oggi con un sorriso. Ma un’estate, oramai stanco di essere declassato e addirittura offuscato, Achille tentò la via della fuga, o meglio dell’esilio, con l’immancabile cugina Ginevra. Presero una borsa e la riempirono di latte, biscotti, frutta, lenzuola, asciugamani, costumi. Il loro doveva essere un addio. Guardarono le mura della villa come se fosse l’ultima volta e quindi volsero lo sguardo al mare certi di seguire le orme di Corto Maltese a latitudini estreme. Fecero un viaggio di circa quattro metri e quindi si accamparono dietro un cespuglio che sentivano protettivo. Tirarono fuori le cibarie, stesero una tovaglia e ci misero sopra il pane e il companatico, quindi accesero un fuoco, avendo letto da poco l’ultima puntata delle Avventure di Cino e Franco. Ma non appena il fuoco si estese alle sterpaglie e all’erba secca qualcuno chiamò i vigili che prontamente spensero quel principio d’incendio. I due rifecero la sacca e rientrarono, stanchi e anneriti, oltre il muro del giardino. Nessuno si era accorto della loro fuga. Il compleanno della nonna ebbe luogo con la consueta corte di famiglia.
Poi, quando Valentino Bompiani morì, la villa rosa di Lerici fu venduta. La dipinsero di bianco, cambiarono gli infissi e le finestre, ci infilarono dei finti busti, perse la sua aria luminosa e spaziosa. «È stata una ristrutturazione ridicola che ha violato l’anima della villa», sostiene Ginevra Bompiani. Ma ciò che è fatto, è fatto. E la Villa della Rupe Canina ha seguito il corso del tempo come, del resto, l’intero territorio lericino.
In quella oramai mitica estate del ’54, l’ultimo sabato di agosto, Valentino Bompiani chiamò Fabio Mauri e Mario Spagnol ed esclamò perentoriamente: «Lunedì mattina vi voglio tutt’e due in ufficio a Milano». Achille Mauri, che era presente nello studio, ancora sente risuonare la voce delle zio come un rimbombo. E se per Fabio Mauri quell’invito non modificava molto la sua vita, per Spagnol fu l’inizio della sua avventura nel mondo dei libri.
Prese la valigia che di solito riempiva di testi e cotolette preparate dalla madre per i suoi soggiorni pisani e la riempì alla bell’e meglio di speranze. Non fu facile spiegare a papà Luigi e mamma Isa perché abbandonava gli studi universitari, a loro che avevano fatto tutti i sacrifici possibili per dargli un’istruzione alta. Spagnol non sapeva dove avrebbe dormito quel lunedì a Milano. Ebbe solo il tempo di salutare i suoi amici del cuore, Veio Sampiero, Renzo Bini, mancato recentemente, Alfonso Cavallini ed Enrico Giudici, con i quali condivideva la stanza da universitario a Pisa, e Massimo Lorato, con cui invece spartiva il gusto della battuta, spesso sarcastica, un po’ all’inglese. A Pisa, poi, lasciò un ricordo indelebile in tanti studenti che si affermarono in quell’Italia rampante, da Gian Carlo Ferretti a Carlo Sgorlon, da Silvano Ambrogi a Paolo Taviani.
Lerici era distante da Milano, non tanto in termini chilometrici, anche se non esistevano ancora né l’Autostrada della Cisa né quella di Genova, piuttosto in termini di opportunità, clima e ambiente. Spagnol si trovò senza i tradizionali punti di riferimento della sua gioventù, catapultato in un ambiente di agguati, insidie e invidie. Ma agguantò la carriera dal verso giusto.
Quando la Longanesi era ancora in corso Italia e io lavoravo a Milano, ogni tanto mi affacciavo sulla sala d’aspetto di Spagnol. Accompagnando i suoi ospiti sulla soglia dello studio mi vedeva e mi salutava. Se aveva tempo, mi faceva segno di attendere nella stanza dell’ufficio stampa. Accomodandomi nell’ampio e luminoso studio non sapevo a che ora avrei terminato la conversazione che spaziava da Fusco a Patroni, dal dialetto di Lerici a quello di Spezia, da Francis Chichister a Joshua Slocum. Una volta ci attardammo così tanto, da esuli spezzini che si ritrovano a Milano, che fuori si era formata una calca inattesa di autori, editori, commercialisti e distributori. Lui si accorse di aver perso troppo tempo e allora, vedendomi passare tra due scie di persone abbastanza contrariate, mi disse in maniera convincente: «Se il progetto lo realizzi come ti ho detto andrà in porto, vedrai». In realtà non avevamo discusso di un bel niente.
La sua Lerici era uno scrigno di piacevoli sensazioni, ancora non invasa dal cemento o dalla barriera di barche e y...