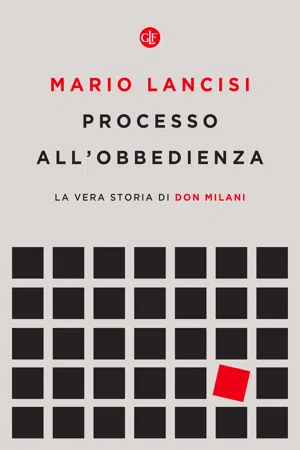1.
Alla sbarra
Tribunale di Roma, 15 febbraio 1966, un martedì. «In piedi, signori, entra la corte». Con voce solenne il cancelliere diede inizio all’ultima udienza di un processo da prima pagina. Alla sbarra si ritrovarono infatti un prete e un giornalista comunista: don Lorenzo Milani e Luca Pavolini. Nell’Italia della contrapposizione tra la Dc e il Pci, immortalata sul piano satirico dagli scontri paesani tra Peppone e don Camillo, i popolari personaggi di Giovanni Guareschi, la circostanza non passò inosservata.
In quello stesso giorno veniva ucciso un ex sacerdote: il colombiano Camilo Torres, nato a Bogotá nel 1929, che aveva lasciato la tonaca per imbracciare il mitra. «Non celebrerò più messa finché non sarà raggiunta giustizia nella mia patria», così l’esponente della teologia della liberazione sudamericana spiegò la sua scelta.
Quasi un segno del destino, un esile filo rosso congiunge il tribunale di Roma e la Colombia: due storie di preti in cui la fede in Dio si intreccia con la miseria e l’ingiustizia sociale. Sulle pareti di Barbiana non a caso era riportata l’esortazione di Che Guevara: «El niño que no estudia no es un buen revolucionario», «il ragazzo che non studia non è un buon rivoluzionario».
La risposta alla miseria si rivelò tuttavia agli opposti: la rivoluzione per don Milani passava infatti dalla scuola, per Torres dal mitra.
Don Milani e Pavolini erano imputati del reato di apologia e incitamento alla diserzione e alla disobbidienza civile. A prima vista venne naturale pensare che il «cattivo» fosse il giornalista comunista e che il prete si trovasse dietro le sbarre per avergli magari espresso una qualche solidarietà cristiana. Invece no, il «cattivo» era il prete, don Milani, priore di Barbiana, autore di una lettera ai cappellani militari toscani in difesa dell’obiezione di coscienza. Ai sacerdoti con l’elmetto quella lettera fece lo stesso effetto di un pugno allo stomaco. Così il giovane priore si ritrovò, mentre veniva divorato da un tumore (morirà sedici mesi dopo), ad un passo dal carcere: «Mi daranno dai tre agli otto anni», confidò ai suoi ragazzi.
Tutto aveva avuto origine da un esposto al procuratore della Repubblica di Firenze presentato da parte di sei ex combattenti, che lo accusarono di «malafede», di «aver offeso e turbato» il clero fiorentino e di aver voluto «gettare manate di fango» contro l’esercito. E soprattutto di aver fatto tabula rasa «di un secolo di storia italiana», salvando soltanto gli anni della Resistenza. Che invece per gli ex combattenti era solo «un breve periodo di meno di due anni con le sue luci e le sue ombre».
Tema caldo, in quegli anni, quello dell’obiezione di coscienza. Chi si rifiutava di indossare la divisa militare finiva in galera. «Dal 1949 ad oggi si sono celebrati in Italia ben 95 processi per 50 casi di obiezione e ogni obiettore ha subìto in media due condanne, cumulando qualcuno fino a 4 anni e 7 mesi di reclusione», riferì Pavolini in un articolo pubblicato su «Rinascita» il 31 luglio del 1965.
Il primo obiettore fu Pietro Pinna, morto a 89 anni il 13 aprile 2016 a Firenze. Nel 1948 fu incarcerato per essersi rifiutato di prestare il servizio militare. Venne denunciato, non per obiezione di coscienza, che a quel tempo non era considerata nel codice penale, ma per rifiuto di obbedienza.
E il tema dell’obbedienza era la ragione profonda per cui don Milani si ritrovò imputato. «Bisogna avere il coraggio di dire ai giovani, che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto», scrisse il priore nella lettera indirizzata ai giudici del processo.
Pacifisti da salotto
All’epoca in cui infuriava la polemica sull’obiezione di coscienza, il «disobbediente» Pinna incontrò due volte don Milani. La prima, nel 1965, per parlare ai ragazzi dell’obiezione di coscienza e della sua vicenda personale.
Rimase colpito dal fatto che l’interesse del priore di Barbiana e dei suoi ragazzi si appuntò non sulle idee della non violenza, ma sulle sue esperienze concrete di vita: i processi subìti, il carcere, l’orientamento dell’opinione pubblica. A Barbiana le idee generali e astratte rimanevano fuori dalla scuola. Gli ospiti venivano «interrogati» sugli aspetti pratici della loro vita.
Questo metodo pedagogico, talora ispido e scomodo, non risparmiò neppure Pietro Ingrao, allora a capo del gruppo comunista alla Camera dei deputati, che proprio durante i mesi del processo fece visita al priore e ai ragazzi. Fu un incontro tempestoso. Così lo ha raccontato Ingrao al giornalista e scrittore Giorgio Pecorini: «Non ci furono convenevoli. Don Milani non concesse nulla – penso deliberatamente – nemmeno alla familiarità che aveva con coloro che mi accompagnavano. La discussione cominciò subito, come un lavoro da svolgere: dinanzi ai ragazzi della scuola, come era consuetudine. In realtà non era una discussione, ma un lungo interrogatorio critico fatto al ‘politico’ che saliva a Barbiana, al ‘politico’ comunista. Il tema non era marginale: riguardava il rapporto del partito con gli operai e i contadini».
Il secondo incontro tra Pinna e don Milani avvenne alla vigilia del processo. Pinna salì a Barbiana assieme al segretario dell’Internazionale dei resistenti alla guerra, che chiese quale solidarietà avrebbe potuto dargli in occasione del processo. Don Milani rispose che, se avesse deciso di andare a Roma, al dibattimento avrebbe voluto al più un pullman di operai. Poi aggiunse: «Altri sostegni non mi interessano. Tantomeno da parte di quei pacifisti che solo adesso mi stanno a fianco, facendosi belli della mia bandiera».
Pinna ci rimase male. «Guarda, don Lorenzo, che stai parlando con il rappresentante di quei pacifisti che non hanno avuto bisogno della tua bandiera per mettersi in mostra. Ben prima di te hanno alzato la loro bandiera pacifista da obiettori e non da parolai al prezzo di anni di carcere e per taluni anche al prezzo della vita», replicò duro.
Pinna ha raccontato di essere rimasto impressionato dai visi esterrefatti dei ragazzi nel vedere il loro priore insolitamente interdetto di fronte a una replica così decisa.
Don Milani accusò il colpo. Tanto che subito si affrettò a precisare che si era riferito non a loro, pacifisti della prima ora, che avevano pagato di persona finendo anche in carcere, ma «ai pacifisti fiorentini da salotto del tè delle cinque».
Si riferiva in particolare, ha riferito Pinna, al gruppo del Cenacolo che faceva capo alla rivista «Testimonianze» fondata nel 1958 dallo scolopio padre Ernesto Balducci (tra i primi abbonati l’allora cardinale di Milano Giovanni Battista Montini, che nel 1963 diverrà papa con il nome di Paolo VI). Pinna rivide don Lorenzo solo alcuni giorni prima della morte, quando cacciò i cattolici fiorentini borghesi e intellettuali, ma accolse i pacifisti come lui.
Barbiana chiama Fontamara
Di tute blu al processo, come aveva sperato il priore, non se ne videro, ma l’aula del tribunale di Roma era comunque gremita. Giovani, giornalisti e anche qualche prete.
Non era il comunista che gli occhi e i flash dei fotografi cercavano, ma lui, il priore di Barbiana. Don Milani, però, non era presente al dibattimento. Aveva inviato un certificato medico perché affetto da un linfogranuloma maligno. Ormai viveva disteso su una brandina o seduto su una poltrona.
Parlando con gli amici del priore, tra i quali il cronista giudiziario della «Nazione» Mario Cartoni, in molti cercarono di capire che tipo di prete fosse don Milani. Sì, qualcuno aveva letto il suo primo libro Esperienze pastorali, e anche la lettera ai cappellani, ma i giudizi erano superficiali. Chi lo detestava, chi lo ammirava. La notorietà del priore esploderà solo dopo la sua morte; in quel febbraio del 1966 era ancora un personaggio da scoprire, che divideva gli animi, tra sospetto, repulsione e ammirazione sconfinata.
Destava curiosità anche il luogo, Barbiana: dove si trovava, quante persone ci abitavano, che parrocchia era. Davvero era una sorta di Siberia ecclesiastica, come la definiva un amico del priore, il magistrato fiorentino Gian Paolo Meucci, per due decenni, dal 1965 al 1985, presidente del Tribunale dei minori di Firenze e assiduo conferenziere alla scuola milaniana di San Donato di Calenzano?
Cartoni e gli altri amici del priore spiegarono ai curiosi che Barbiana era una minuscola parrocchia di una novantina di anime, a metà del monte Giovi, in Mugello, ad una quarantina di chilometri da Firenze. Anime di montanari e contadini. Che vivevano tra mucche e pecore, senza acqua, posta e luce in casa, strade fangose d’inverno e polverose d’estate. Invisi ed estranei allo Stato, come ha raccontato il priore nei suoi scritti.
Per gli abitanti di Barbiana lo Stato era percepito solo nella funzione repressiva di esattore delle tasse e di chiamata alla leva militare. Uno Stato nemico dei barbianesi come lo era dei contadini e montanari meridionali. In questo senso Barbiana evoca Fontamara, il paese del...