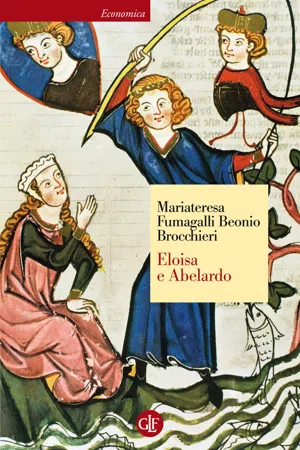Nota bibliografica
Questa nota non pretende di essere completa: vuole indicare, da un lato, le fonti principali per la storia di Eloisa e di Abelardo, dall’altro alcuni strumenti utili per ricostruire il contesto storico soprattutto nei suoi aspetti culturali. Infine, suggerisce dei «percorsi» che possono facilitare la comprensione di alcune vicende o atteggiamenti dei protagonisti ed essere anche interessanti filoni autonomi di lettura.
I libri che cito sono anche le mie letture: a esse sono in parte debitrice per la ricostruzione di ciò che considero essenziale alla comprensione dei due personaggi.
In tutta la letteratura biografica, la forte carica «romantica» della vicenda e il rilievo psicologico delle due figure hanno spesso polarizzato l’attenzione; anche troppo, a mio parere, perché molti degli atteggiamenti e dei pensieri di Eloisa e di Abelardo resteranno per noi incomprensibili, se non faremo riferimento al loro mondo.
Infine, il criterio che mi guida nell’indicazione di alcune edizioni e degli studi è quello, anche, della reperibilità e della diffusione dei testi. Per questo gli studi in lingua straniera vengono senz’altro indicati nelle traduzioni italiane.
Fonti
Le fonti principali per la nostra storia sono l’Historia Calamitatum e le lettere di Eloisa e di Abelardo. Tali fonti sono per noi contenute, oggi, in nove manoscritti. Mi limito a indicare i due più importanti, che hanno anche un rilievo particolare: il manoscritto che oggi è alla Biblioteca di Troyes (ms. 802) contiene già uno spunto di discussione, poiché è l’unico in cui compaia in modo completo la famosa lettera VIII, che ho citato e commentato. Il manoscritto della Biblioteca Nazionale di Parigi (lat. 2923) reca invece gli appunti di Petrarca, che leggendo l’epistolario lo ha di sua mano annotato. Per gli altri manoscritti, si può vedere l’introduzione del Monfrin all’Historia Calamitatum (Parigi 1959). Proprio a Monfrin dobbiamo l’editio princeps, preceduta da un’intelligente se pur breve introduzione.
Ma non possiamo dimenticare qualcuna delle edizioni più interessanti e di rilievo dell’Historia e delle lettere, precedenti a quella del Monfrin.
La prima edizione in senso assoluto è a cura di A. Duchesne, Parigi 1616, in due volumi, e comprende anche altre opere abelardiane. Curiosamente, ne esistono due esemplari: uno, attribuito appunto al Duchesne, e un secondo, che riproduce lo stesso testo (omettendo però la Praefatio ad lectorem di Duchesne, e la Summa Privilegii con la quale si faceva divieto di ripubblicare per dieci anni le opere di Abelardo edite nell’occasione) e che, stando all’iscrizione, è opera di Francesco d’Amboise.
Ricordo poi, per la sua antichità (1718), l’edizione delle lettere a cura di Richard Rawlinson, stampata a Londra e ristampata a Oxford solo dieci anni più tardi; l’edizione dell’Orelli, Torino 1841, che ci interessa soprattutto perché l’Orelli mette per la prima volta in dubbio l’autenticità del carteggio. Va quindi ricordata l’edizione di tutte le opere di Abelardo fino ad allora conosciute (che non erano poi moltissime) compiuta da Victor Cousin (Petri Abaelardi Opera, Parigi 1849-1859, in due volumi). L’edizione del Cousin ha costituito comunque, quale che sia oggi la sua validità, l’unica fonte per la conoscenza del pensiero filosofico di Abelardo fino al 1919, quando Geyer pubblicherà la prima parte della sua edizione delle opere filosofiche del Nostro. La Patrologia Latina del Migne (t. CLXXVIII) riproduce poi, come è noto, il testo dell’edizione parigina del 1616. Comparsa a Parigi nel 1855, anche se ricca di errori e incomprensioni, resta in fondo l’edizione ancora più a portata di mano. La Patrologia è infatti reperibile in quasi tutte le biblioteche.
Dobbiamo infine ricordare J.T. Muckle, che pubblica il carteggio personale dei due (The Personal Letters between Abelard and Heloise, «Medieval Studies», XV [1953], pp. 47-94; XVII [1955], pp. 240-281); e M.M. McLaughlin, che pubblica quella famosa lettera VIII di cui già abbiamo detto (Abelard’s Rule for Religious Women, «Medieval Studies», XVIII [1956], pp. 241-292).
Fra le traduzioni (ce ne sono moltissime) indicherò soltanto quelle che mi sembrano più interessanti.
La prima traduzione in senso assoluto è quella di Jean de Meung, che risale circa a un secolo dopo la vita di Eloisa e Abelardo: fu edita dalla Charrier, a Parigi, nel 1934.
I titoli delle edizioni in lingua italiana sono già qualche volta indicativi del taglio di interesse. Ricorderemo, tra le altre: le Lettere amorose d’Eloisa e Abelardo, con la vita de’ medesimi, edita a Parigi, ma in italiano, nel 1782; l’Epistolario, tradotto da G. Barbieri, Milano 1841 (che fu parecchie volte saccheggiato da edizioni «pirata», anonime, per esempio nella Biblioteca Universale Sonzogno, Milano 1883); le Lettere, tradotte sulla base del testo del Migne da E. Quadrelli (Roma 1927). Sono sei le traduzioni italiane di particolare rilievo: l’Epistolario, tradotto da C. Ottaviano, Palermo 1934; e, in tempi a noi più vicini, la traduzione della Historia Calamitatum di A. Crocco, Napoli 1969, quella di F. Roncoroni (Storia delle mie disgrazie. Lettere d’amore di Abelardo ed Eloisa, Milano 1974) e quella di N. Cappelletti Truci (Lettere, Torino 1979). Ho particolarmente tenuto presenti per le citazioni queste due ultime edizioni, intervenendo però spesso, per rendere più omogenei al mio testo i passi citati. Le traduzioni più recenti, infine, sono quella di Cecilia Scerbanenco (Lettere di Abelardo e Eloisa, Milano 1996), che si segnala per l’attenzione alle particolarità del lessico filosofico di Abelardo, e quella di Ileana Pagani (Abelardo e Eloisa, Epistolario, Torino 2004), preziosa per il ricco apparato di note.
Fra le traduzioni francesi, ricordiamo: Les véritables lettres d’Abélard et d’Héloïse di Dom Gervaise (Parigi 1723), che ha scritto anche una storia della vita dei due innamorati; quella dell’Oddoul, Parigi 1839, che ebbe grande successo, e una nuova edizione nel 1853 (poi ristampata nel 1858 e nel 1876); quindi la traduzione di Gréard (Lettres complètes, Parigi 1869, con testo latino a piè di pagina). Fra le moderne voglio citare, per l’interessantissima e originale presentazione, quella di P. Zumthor (Correspondence, Parigi 1979).
La traduzione forse più famosa, nel Settecento ma anche dopo, è quella di Alexander Pope (The works of A.P., Londra 1751, t. II, pp. 25-38); di essa venne fatta una parafrasi poetica molto diffusa in italiano, dal Conti (Versioni poetiche, a cura di G. Gronda, Bari 1966). Chiaramente più reperibili, quella di B. Radice, del 1974 (The Letters, Londra 1974), e fra le tedesche quella di E. Brost (Die Leidengeschichte und der Briefwechsel mit Heloise, Heidelberg 1979).
Sarebbe impossibile citare tutte le traduzioni infedeli (ma attraenti perché rispecchiano il motivo dell’interesse suscitato in quel momento dal carteggio dei due innamorati). Non si può non citarne qualcuna: quella di Roger de Rabutin, conte di Bussy (Parigi 1697), il quale, come egli stesso dice, «si diverte a tradurre alcune delle lettere per inviarle alla cara cugina», Madame de Sévigné; o l’Essai de traduction littérale et énergique, titolo significativo, del marchese di Saint-Simon, datato 1711 (traduzione della traduzione di Pope); poi, una versione che praticamente è una parafrasi, e che fu molto diffusa: Le Philosophe amoureux du Paraclet, 1696; oppure le due «lettere» dell’Encyclopédie politique, Parigi 1778-1781 (t. VII, nn. 1441 e 1442); o ancora, l’edizione che mescola le lettere di Eloisa e Abelardo – nella traduzione francese – ad altre, come quelle di Ninon de Lenclos, di Jean-Jacques Rousseau e di Napoleone (Lettres d’amour chefs-d’oeuvre de style épistolaire..., a cura di J. Lemar, Parigi 1851).
Oltre alle lettere di cui abbiamo detto, la cosa più importante che ci resta di Eloisa sono i Problemata Heloissae (si trovano nella Patrologia Latina, t. CLXXVIII, 677-730) e l’elegia latina che le viene da alcuni attribuita (cfr. J. Depoin, Une élégie latine d’Héloïse, Pontoise 1897). Completa il quadro delle opere di Eloisa una breve lettera indirizzata a Pietro il Venerabile, breve nella sua drammaticità, che si trova sempre nella Patrologia (t. CLXXVIII).
Le due lettere di Pietro il Venerabile a Eloisa (Patrologia Latina, t. CLXXXIX, IV, 21 e VI, 22) sono, come abbiamo visto, fondamentali. Un po’ a lato, collocherei un altro gruppo di lettere: due lettere di Ugo Metello a Eloisa (edite da C.L. Hugo, Monumenta sacrae Antiquitatis, II, Saint-Dié 1731, nn. XVI e XVII) e una di Folco di Deuil (sempre nel tomo CLXXVIII della Patrologia), un personaggio sconosciuto più o meno come il precedente, ad Abelardo.
L’edizione Duchesne, del 1616, che abbiamo citato, tendeva a un suo piano di completezza che riguardava però soltanto le opere che allora si attribuivano ad Abelardo; fra le altre, il Commento all’Epistola ai Romani e l’Introductio ad Theologiam. Bisogna arrivare sino al 1717 per avere, a cura di E. Martin, l’edizione della Theologia Christiana (in Thesaurus novus anecdotorum, Parigi 1717, t. V, p. 1140). Quivi compariva anche l’Expositio in Hexaemeron, altra importante opera di teologia. Lo Scito te ipsum (Ethica) è stato per la prima volta edito da B. Pez nel 1721; quell’Ethica ha avuto nella nostra storia una parte centrale nella decifrazione della psicologia e del comportamento di Abelardo stesso. Il lettore si può rivolgere alla traduzione italiana (Conosci te stesso o Etica, a cura di M. Dal Pra, Firenze 1976) oppure alla traduzione inglese, a cura di D. Luscombe (Ethics, Oxford 1971), che offre anche la più recente edizione critica del testo (riportata da Dal Pra).
Quanto alla Theologia, della quale esistono più redazioni (come per quasi tutte le opere abelardiane), la Theologia Summi Boni è stata edita da Ostendler, Münster 1939 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Bd. 25). Jean Jolivet l’ha tradotta in francese nel 1978 (Du bien suprême, Montreal-Parigi). Il Commento all’Epistola ai Romani, l’Apologia Contra Bernardum, le redazioni brevi della Theologia Christiana e della Theologia Scholarium sono stati editi da E.M. Buytaert, nei voll. XI e XII del Corpus Christianorum (Turnholt 1970).
Il trattato De unitate et trinitate divina, che fu appunto la base della Theologia, è stato edito da R. Stölze, Friburgo 1891.
Interessante anche un succinto rifacimento della Theologia, a opera di un allievo di Abelardo, intitolato Sententiae Magistri Hermanni, edito ora da S. Buzzetti (Firenze 1983).
La prima edizione del Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum è opera di F.H. Reinwald, Berlino 1831. Più recente l’edizione di R. Thomas, Stoccarda-Bad Cannstatt 1970 (ma si vedano a questo proposito le osservazioni di G. Orlandi, Per una nuova edizione del Dialogus di Abelardo, «Rivista critica di storia della filosofia», XXXIV [1979], pp. 474-494). Vi sono poi due traduzioni, parziali, in lingue moderne: quella italiana di G. Dotto (Bergamo 1976) e quella inglese di P.J. Payer (Toronto 1979).
Il Sic et non di cui Cousin aveva edito solo alcuni passi è stato edito interamente per la prima volta nel 1851 (da Henke e Lindenkohl, Marburgo). Oggi ci si riferisce all’edizione di McKeon e Boyer (Chicago 1975 e 1977).
Le opere logiche (dette anche «filosofiche» dagli editori perché costituiscono proprio il nocciolo della filosofia di Abelardo) erano le grandi assenti nelle edizioni dei secoli scorsi. Bisogna arrivare fino al 1919 per avere l’edizione di Geyer (Philosophische Schriften, Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Bd. 21, t. 1, 1919; t. 2, 1921; t. 3, 1927; t. 4, Münster 1933). L’edizione include le glosse a Porfirio, alle Categorie e al Peri hermeneias della Logica cosiddetta Ingredientibus e la glossa a Porfirio della Logica cosiddetta Nostrorum petitioni sociorum. L’edizione di Dal Pra, significativamente intitolata Scritti Filosofici, Milano 1954 (seconda edizione riveduta, col titolo Scritti di Logica, Firenze 1969), contiene le Glosse letterali e una parte inedita della Logica ingredientibus; segue, nel 1956, l’Abelardiana inedita (in Twelfth Century Logic, Roma) a cura di L. Minio-Paluello. Si arriva infine alla principale opera logica abelardiana, la Dialectica, edita dal De Rijk (Assen 1956, 19702).
L’Epistola contra Bernardum abbatem è una scoperta «fortunata» di Klibansky (Peter Abelard and Bernard of Clairvaux, «Medieval and...