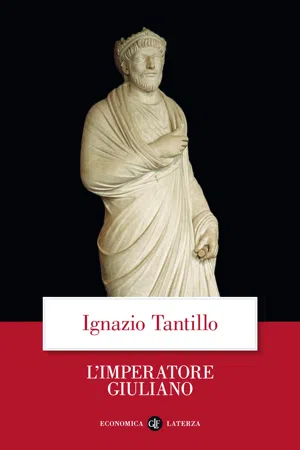Il restauratore
Costanzo era sepolto, restava da fare i conti con la sua eredità di governo. Il compito appariva arduo, ma Giuliano poteva contare sul sostegno dei suoi protettori divini, un sostegno che non gli sarebbe mai mancato se egli avesse perdurato nella sua pia religiosità: «io rabbrividisco davanti agli dèi, e li amo e li riverisco e li temo: insomma provo per loro tutti quei sentimenti che si potrebbe nutrire per dei padroni indulgenti, dei maestri, dei padri, dei tutori» (Orazione VII [«Contro Eraclio cinico»], 212b). Tanto devoto assegnamento accompagnava tutte le sue azioni, più o meno importanti; dagli dèi egli riceveva indicazioni di continuo, li sentiva presenti in ogni momento, e vicinissimi: perfino lo spasmo di un muscolo contratto poteva esser letto da quest’uomo come un ammonimento divino.
Qual era dunque il compito affidato a Giuliano, cosa si aspettavano da lui i suoi dèi? Si può partire da una testimonianza che si trova nel discorso scritto da Giuliano verso la metà di marzo del 362, per replicare alle provocazioni di un certo Eraclio, filosofo appartenente alla scuola cinica, la più diffamata tra le scuole di pensiero antiche. Eraclio aveva attaccato Giuliano (i cinici, da Diogene in poi, si distinguono per la loro sfrontatezza verso le autorità) servendosi di un mythos – un racconto allegorico – dai toni blasfemi. Giuliano, contestando a Eraclio la capacità di costruire miti, gli oppose un altro mito, in cui illustrava la propria vicenda. Nel racconto, Costantino appare come un ricco zotico che divide i suoi beni tra i figli ignoranti. Zeus non approva i misfatti di Costantino e dei suoi figli, si rivolge quindi a Helios, indicandogli Giuliano, che appartiene alla stirpe solare, e glielo affida per prepararlo a uno scopo supremo, quello di purificare il mondo dalle empie malefatte di Costantino. Vane sono le resistenze del giovane, egli non può sfuggire al suo destino:
Perché tu devi partire di qui e purgare tutte le empietà della terra e chiamare in soccorso me e Atena e gli altri dèi (Orazione VII, 231 d [trad. di R. Prati].
Sappi che il corpo mortale ti fu dato perché tu possa compiere questa missione: per riguardo ai tuoi antenati noi desideriamo purgare la casa dei tuoi padri. Ricordati che hai un’anima immortale che da noi discende e che, se tu ci seguirai, sarai un dio e con noi contemplerai il nostro padre (Orazione VII, 234c [trad. di R. Prati]).
Il quadro che si è andato poco a poco delineando nel corso dei capitoli precedenti è finalmente completo. Per Costantino alla base di tutto c’è il patto con Dio: donde l’elezione della propria stirpe secondo il modello biblico (davidico) e la promessa di un regno prolungato in eterno: l’incontro con la nuova religione e il suo Libro aveva condotto Costantino a elaborare un’idea di dinastia per molti aspetti nuova e in contrasto con la tradizione. Giuliano sviluppa, forse gradualmente, una propria visione a partire da quella costantiniana: era un membro della famiglia, nato e cresciuto in quel clima ideologico: non poteva non confrontarsi con essa. Fa sua l’idea di stirpe eletta, quella di «missione» (nell’accezione forte che gli era stata conferita da Costantino), ma ovviamente non riconosce nel dio cristiano l’origine dei fasti familiari, il protettore della propria stirpe. Questi è invece Helios che, attraverso Giuliano, intende riappropriarsi di ciò che gli spetta; è quel Sole di cui Claudio, Costanzo Cloro e, per un certo periodo, lo stesso Costantino erano stati devoti adoratori e servitori: «non disconosco tuttavia la sorte di cui mi ha ritenuto degno il dio Helios, facendomi nascere nella famiglia che ai miei tempi domina e regna sulla terra. [...] È dunque grandissimo privilegio per un uomo essere preceduto, nel servizio di questo dio, da una serie lunga, ininterrotta di antenati, per più di tre generazioni» (Orazione XI [«A Helios re»], 131b-d). Oltre a ciò, tra la visione costantiniana e quella di suo nipote v’è un’altra essenziale differenza. Costantino guarda al futuro, fino a dissolvere nella fine dei tempi l’elezione della propria genia: la fiducia nell’appoggio divino è inscindibile dalla convinzione che questo è, da ora, per sempre. Da cui la novità dell’affermazione di un principio ereditario meccanico, «per legge di natura»: Costantino non doveva preoccuparsi, il suo dio avrebbe provveduto a che i discendenti della famiglia, gli eredi, fossero degni di condurre il suo gregge. Giuliano è invece concentrato sul presente, visto come fatale traguardo di un processo storico in cui la sua famiglia ha avuto un ruolo di primo piano: per lui, il volere degli dèi si esprime unicamente nell’avergli conferito il compito di purificare il mondo di quaggiù, senza promesse per un futuro che, imperscrutabile, resta nelle loro mani.
Recuperare la giusta via, restaurare la cosa pubblica: un dovere verso gli dèi e verso gli uomini, della cui sorte egli, in qualità di imperatore, è responsabile. Politica, religione e vicenda personale (anche dinastica) appaiono più che mai legate. Non dobbiamo stupircene: per comprendere a fondo il problema bisogna considerare le basi del pensiero giulianeo, addentrarsi nell’universo dei suoi punti di riferimento, storici e culturali.
Come uomo e come greco l’ideale di Giuliano è la perfetta conoscenza, il sapere compiuto: l’episteme. Questa è un qualcosa di unitario che riguarda ogni aspetto dell’umano agire e che, solo per comodità, potremmo scindere in tre livelli (seguendo la proposta della studiosa P. Athanassiadi-Fowden): un livello individuale, che concerne la salvezza dell’anima del singolo; un livello filosofico-culturale, che corrisponde al raggiungimento della sapienza genuina, della Verità; un livello collettivo, che concerne il benessere dello Stato. Unica via per giungere alla episteme è la paideia (anch’essa evidentemente scindibile in più livelli). Questa è intimamente integrata alla cultura greco-romana – basterebbe dire «greca», l’unico contributo dato dai Romani è infatti l’arte del governo e della guerra –, cultura che deriva a sua volta da Helios, sorta di educatore dell’umanità: fu Apollo (-Helios) a rivelare agli uomini la «filosofia». Giuliano insiste sempre sulla coerenza di religione e forme culturali o artistiche, non distingue mai tra letteratura profana e letteratura sacra: si potrebbe quasi dire che gli dèi sono solo una parte della sua visione del mondo, nella misura in cui l’elemento divino non può venir separato dall’universo storico-culturale.
Mantenendo l’analisi sul piano politico, quindi, possiamo affermare che il programma di Giuliano consiste nel restaurare la totalità di un’esperienza storica, civile, culturale, giuridica, religiosa. Ciò implica necessariamente anche l’individuazione di modelli e di strumenti. In apertura di una lettera scritta dalla Gallia al grande retore e filosofo Temistio (probabilmente già alla fine del 355, o all’inizio del 356) egli confessa: «già da tempo, al pensiero di dover competere con Alessandro e Marco [Aurelio], o con chiunque altro si sia distinto in virtù, mi coglieva un brivido e un timore terribile di restare troppo lontano dal valore del primo e di non avvicinarmi, neppure in minima parte, alla virtù perfetta (teleia aretè) del secondo» (Orazione VI, 253a-b [trad. di A. Marcone]). Alessandro era il modello per eccellenza del monarca conquistatore: il confronto con Alessandro è un passaggio obbligato in ogni riflessione sulla regalità e non poteva mancare. Meno scontata è la menzione di Marco: Marco Aurelio è l’insigne imperatore filosofo della dinastia degli Antonini (regnò dal 161 al 180), per di più un «greco» d’adozione, colui che Giuliano considera come il miglior sovrano di tutti i tempi. In realtà, nell’età di Costantino, gli imperatori del II secolo (o, come si diceva allora, i «principi civili») furono al centro di un rinnovato interesse: sembra che Costantino e suo figlio Costanzo li prendessero a modello, anche di comportamento. Questi due – pare – preferivano Traiano (per una serie di ragioni che non è il momento di passare in rassegna); Giuliano si volse a Marco (dice di lui lo storico Eutropio: «non dissimile da Marco Antonino, che tentava anche di emulare»), perché Marco gli sembrava incarnare quella virtù perfetta che costituiva la sua massima aspirazione come uomo che opera nel mondo di quaggiù.
L’idea di virtù perfetta ricorre spesso in Giuliano: essa consiste nel raggiungimento di un grado di eccellenza nelle singole virtù (intelligenza, moderazione, saggezza, clemenza, coraggio, con relative sfumature) e nella fusione di ciascuna di esse in una suprema, armonica unità. Giuliano attribuisce questa «perfetta virtù» a suo cugino (nei panegirici), la invoca per se stesso nella preghiera finale del suo «Inno alla Madre degli dèi» («concedi la verità dei dogmi che riguardano gli dèi, la perfezione nella teurgia e la virtù, accompagnata dalla buona fortuna, in tutto quanto stiamo per intraprendere in ambito politico e militare»: Orazione VIII, 180b-c [trad. di A. Marcone]) e di quello a Helios («per la terza volta dunque prego Helios re dell’universo, come ricompensa del mio zelo, di essermi propizio e di accordarmi una vita virtuosa, una più perfetta sapienza e un’intelligenza divina»: Orazione XI, 158b [trad. di A. Marcone]). La perfezione nelle umane qualità avvicina al divino – coincide con l’esaltazione massima della componente divina dell’essere umano –, e Giuliano ha imparato da Platone che l’attività del regnare si addice meglio a una natura superiore, perché trascende le capacità dei mortali (Orazione VI [«Lettera a Temistio»], 260c).
Missione dinastica, conoscenza suprema, paideia, perfetta virtù: è molto difficile, se non impossibile, trattare separatamente questi problemi che costituiscono la base per affrontare qualsiasi discorso sull’opera di Giuliano. Di questa si esamineranno qui solo alcuni aspetti, che corrispondono alle linee portanti del suo progetto di governo.
Giunto a Costantinopoli, Giuliano procedette a un’epurazione del personale di palazzo, riducendolo al minimo indispensabile. Cacciò via i cuochi e i cocchieri addobbati di vesti sontuose; perfino i suoi segretari personali furono portati al numero di quattro. Dispregiando lo sfarzo della corte come vana (e dispendiosa) ostentazione, Giuliano si mostrava in pubblico e si comportava in ogni occasione con una semplicità di modi ispirata ai modelli repubblicani e «civili» (nella tradizione romana si fingeva che il princeps fosse un normale cittadino, civis), o almeno a come egli li immaginava. Così agendo, però, Giuliano finiva per rifiutare non un semplice «ornamento», ma un’idea di regalità, una forma di autorappresentazione ormai indissolubilmente legata all’essenza stessa del potere imperiale. La simbolica e il cerimoniale, lentamente elaborati a partire dall’esempio persiano, fissati già da Diocleziano in linee generali e sviluppati da Costantino e dai suoi figli, servivano a marcare la separazione del monarca d’elezione divina dall’uomo comune. La carica imperiale era vista come ufficio divino, e quindi abbisognava di insegne, linguaggi e liturgie che ne ribadissero e ne enfatizzassero adeguatamente la sacralità. Era previsto anche che, di tanto in tanto, l’imperatore si concedesse agli uomini, si facesse avvicinare. Ma ciò doveva avvenire solo in occasioni particolari, quando l’umanizzazione del potere era richiesta dalla tradizione o dal buon senso. Le sporadiche esibizioni di contegno «civile», accuratamente dosate, assottigliavano la distanza che separava il mondo dalla semidivina figura del monarca, e servivano a ribadirne l’appartenenza alla tradizione romana. L’immagine imperiale era il frutto di una sapiente miscela tra i due modi di presentarsi al pubblico. Proprio questo era quanto si aspettavano i sudditi dal loro dominus (signore, padrone), e che piaceva loro di Costanzo II. La pretesa di mantenere sempre uno stile di condotta «civile» non aveva quindi molto senso, senza contare che mal si conciliava con la convinzione di appartenere a una stirpe eliaca e di essere investito di una missione. Perfino alcuni estimatori di Giuliano ammettevano che simili comportamenti portavano a un intollerabile svilimento della dignità del suo titolo: era sconveniente che il «signore del genere umano» abbandonasse una riunione ufficiale per correre ad abbracciare il suo vecchio maestro; ed era francamente ridicolo che egli si automultasse per essersi reso conto di non aver rispettato le prerogative del suo collega nel consolato (primo gennaio 362). Il pubblico non apprezzava, non capiva, e finì per spiegarsi l’anomalo comportamento di Giuliano come affettazione, come indice di superbia.
Più ambizioso il suo programma di politica municipale. Le città sono le cellule che compongono il tessuto vitale dell’impero. Questo, in effetti, non è uno «Stato», ma il dominio di una città (Roma) su migliaia di altre città – corpi autonomi dotati di una propria identità, politica, giuridica, culturale – che intrattengono col potere imperiale una varietà di rapporti periodicamente ridefiniti. Le città sono organismi complessi che si basano su delicati equilibri interni: il bilanciamento delle componenti sociali (aristocrazie, popolo), l’esercizio responsabile di una serie di pratiche (partecipazione all’attività politica, agli spettacoli, ai culti tradizionali delle divinità tutelari), la gestione delle risorse economiche. Agli occhi di Giuliano, Costantino e i suoi successori avevano incrinato quegli equilibri, aumentando l’ingerenza del potere centrale, permettendo lo svuotamento delle curie, privilegiando i cristiani e le loro proprietà. Fu probabilmente con un’unica grande legge (giunta però mutila e smembrata), recante la data del 13 marzo 361, che l’imperatore tentò di ovviare a questa incresciosa situazione. I provvedimenti contenuti nella legge avrebbero trovato un coerente completamento nelle misure prese in campo religioso, volte al ristabilimento dei culti cittadini.
Le curie, organi direttivi composti dai cittadini più abbienti e rispettabili, erano responsabili dell’amministrazione locale e delle operazioni fiscali. La condizione di curiale (decurione) era ereditaria: ma molti tentavano di sfuggirvi, preferendo una carriera nell’esercito, nell’amministrazione civile o, da quando Costantino aveva concesso grandi privilegi al clero, nella gerarchia ecclesiastica. Giuliano fece richiamare al loro dovere i curiali che a vario titolo avevano abbandonato le curie, cristiani prima di tutto, ma non solo. In alcuni casi i risultati furono notevoli: quasi duecento membri vennero recuperati all’assemblea di Antiochia in Siria. Altrove, in città più isolate, dove meno forte era il controllo imperiale, gli effetti di questa iniziativa furono senz’altro meno incisivi.
Un’altra sezione della normativa riguardava le finanze municipali. Giuliano si era sempre mostrato sensibile per questo tipo di problemi e, una volta imperatore, aveva persino rinunciato a esigere quell’aurum coronarium, sostanziosa tassa in oro, che veniva versata dalle città in occasione dell’avvento di un nuovo principe. Da sempre le città gestivano un patrimonio fatto di terreni e altri beni immobili, di tasse, di dazi, e inoltre amministravano le proprietà templari, in alcuni casi di cospicuo valore economico. I proventi che ne derivavano servivano alle città per le spese municipali, per la costruzione o il restauro di edifici e monumenti, e per altro ancora. A partire soprattutto dal III secolo, gli imperatori avevano cercato di appropriarsi di queste risorse. Una svolta decisiva, sembra, si ebbe proprio con Costantino o con i suoi figli: con una serie di disposizioni, purtroppo non pervenute, si giunse al quasi totale assorbimento dei proventi municipali da parte del governo centrale, proventi che andarono a formare dei capitoli speciali nei registri dei conti finanziari. Teoricamente, persino per i lavori di manutenzione ordinaria, le autorità municipali dovevano ora rivolgersi ai rappresentanti del potere imperiale (i governatori delle province). Ci si rese conto presto che ciò rallentava e appesantiva significativamente il lavoro amministrativo: Costanzo II decise perciò di lasciare un quarto del totale delle entrate alle singole curie. Giuliano fu molto più radicale, e restituì in blocco alle città i proventi delle tasse, dei possessi municipali, nonché naturalmente dei beni templari. Questa disposizione, per quanto utile e benefica, non poteva esser applicata senza mettere in pericolo il mantenimento dell’esercito e dell’apparato amministrativo. Che le casse imperiali non potessero più fare a meno del capitolo costituito dai proventi civici, lo mostra il fatto che alla morte di Giuliano si ritornò al sistema vigente in età costantiniana, presto corretto con l’assegnazione alle città di un terzo delle loro risorse per far fronte ai bisogni immediati.
Ma il problema cruciale era costituito dal cristianesimo: bisognava mettere un freno alla diffusione dell’«ateismo», di questa peste che sotto i suoi predecessori aveva ricevuto, dopo il riconoscimento ufficiale, un numero straordinario di privilegi, tanto da stravolgere gli assetti della struttura sociale e politica tradizionale. Dal raggiungimento di questo obiettivo soprattutto dipendeva il successo del suo programma di governo.
Giuliano aveva tardato a rivelare le sue vere opinioni in materia di religione (solo a Naisso confessò pubblicamente di adorare gli dèi): l’immagine del principe costretto a dissimulare le proprie convinzioni sotto le sembianze di un proselito della Chiesa ricordava a Libanio la favola di Esopo dell’asino vestito da leone: favola in questo caso da leggere al rovescio, giacché Giuliano era un leone vestito della pelle d’asino (Orazione XVIII, 19). Il retore antiocheno non ignorava forse che il «leone» era uno dei gradi dell’iniziazione mitraica (del dio Mitra, di cui Giuliano era divenuto un adepto probabilmente in Gallia), mentre l’asino era popolarmente associato al cristianesimo, per derisione, in quanto essere stupido e stolto: si ricorderà forse un noto graffito di Roma raffigurante il Cristo crocifisso con testa d’asino.
Quando poi «si tolse finalmente la maschera», per un certo periodo Giuliano si mostrò piuttosto tollerante nei riguardi dei suoi ex-corr...