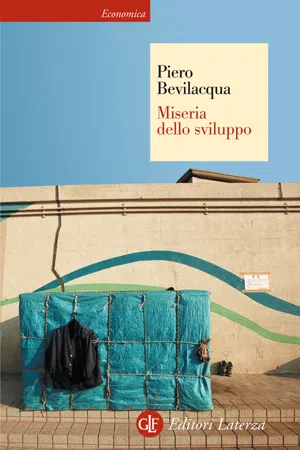
- 264 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Miseria dello sviluppo
Informazioni su questo libro
Evidentemente, non basta la crisi economica globale a mettere in discussione un modello di sviluppo economico-sociale fondato sulla distruzione delle risorse disponibili e sulla loro iniqua distribuzione. Una distruzione che non è più 'creativa' di alcunché, se non di sperequazione, impoverimento e miseria. La Miseria dello sviluppo, appunto, per riprendere il titolo dell'inquietante libro di Piero Bevilacqua.
Giovanni Valentini, "la Repubblica"
«Lo sviluppo – la corsa al conseguimento di sempre più alti standard di vita attraverso sempre più elevati livelli di produzione e di consumo di beni materiali e servizi – è finito.»
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Miseria dello sviluppo di Piero Bevilacqua in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Economia e Politica economica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
EconomiaCategoria
Politica economica1. Fine dello sviluppo
Non c’è bisogno di sperare per intraprendere,
né di riuscire per perseverare
Gugliemo il Taciturno (1533-1584)
Fuori dal tempo e dallo spazio
Lo sviluppo, la corsa al conseguimento di sempre più alti standard di vita attraverso sempre più elevati livelli di produzione e di consumo di beni materiali e servizi, è finito. L’insieme dei processi economici e sociali che nell’ultimo mezzo secolo ha moltiplicato i redditi individuali dei cittadini dell’Occidente, accresciuto il loro benessere materiale, innalzato il loro orizzonte culturale, esteso gli spazi di libertà e rafforzato la loro partecipazione democratica, si è concluso. Una grande pagina della storia recente del mondo è giunta a termine. Certo, il possente motore economico che ha generato e sostenuto la corsa allo sviluppo lavora ancora a pieno ritmo, così come la rutilante campagna ideologica che, sin dall’inizio, ne fiancheggia l’opera. Tuttavia, alcuni meccanismi fondamentali si sono irrimediabilmente inceppati.
Crescita economica e benessere si vanno divaricando. E innanzi tutto si è dissolto, almeno in Occidente, il segreto stesso dell’immenso successo che sta a base dello sviluppo: l’idea che la perenne aspirazione umana a migliorare la propria condizione potesse essere catturata definitivamente nella ricerca senza fine di ricchezza materiale. Il trascinamento di tale aspirazione nel circolo di bisogni artificiali, perennemente insoddisfatti, colpisce al cuore la sua stessa possibilità di realizzarsi.
Questa svolta, rilevata per il momento solo da ristrette avanguardie intellettuali, non riguarda soltanto la percezione soggettiva dei cittadini che vivono nelle società ricche. Alcuni economisti, non completamente asserviti al conformismo dominante della loro disciplina, hanno cominciato a misurare il divario che separa l’incremento del reddito pro capite dal benessere percepito dalle persone. «Com’è possibile – si è chiesto l’economista francese Daniel Cohen – che l’arricchimento spettacolare della nostra società non giunga mai a riassorbire la nostra voglia di consumare e anzi, al contrario, renda il consumo sempre meno soddisfacente?». La perdita di felicità personale, pur in presenza di una crescita di beni materiali che dilagano nella vita quotidiana, ha già avuto una importante disamina negli Usa con il libro di Robert Lane, The Loss of Happiness in Market Democracies. Accade, infatti, che la crescita di ricchezza si accompagni a una progressiva perdita di relazioni umane fondamentali: amicizie, affetti, legami disinteressati. Dalle quali pare, anche, che venga gran parte della nostra felicità. In una recente pubblicazione della Oxford University Press, Economics and Happiness, curata da Bruni e Porta, si può ad esempio scoprire che la percezione del benessere dei giapponesi è oggi ferma allo stesso livello dei primi anni Sessanta. Tutto appare come prima, dopo quasi mezzo secolo di travolgente sviluppo, dopo che il reddito pro capite dei cittadini di quel paese è cresciuto di almeno cinque volte. Certo, la complessità della vita urbana e i crescenti disagi che essa genera frustrano in buona parte le possibilità di umana realizzazione e il benessere offerto dall’elevazione dei redditi. Ma il fatto è che si è spezzato l’antico legame tra «più» e meglio, tra «ricchezza materiale» e «benessere». Come ha scritto André Gorz, «si vive sempre peggio spendendo sempre più soldi, e si crede di aver bisogno di guadagnarne sempre di più».
Non solo. Lo sviluppo, nella sua straordinaria creatività, si è mostrato capace di generare, nelle stesse società ricche, nuove forme di povertà, marginalità, degradazione ambientale, insicurezze, abissi di iniquità. La fine dello sviluppo si viene consumando in una dimensione infinitamente ampia e si irraggia in una straordinaria varietà di fenomeni.
L’intero edificio dell’economia dello sviluppo è stato costruito su una doppia finzione: la pretesa eternità dei fenomeni sociali, la supposta infinità della natura. Tutto è stato pensato e immaginato al di fuori del tempo e dello spazio. Eppure, almeno dall’epoca di Eraclito, sappiamo che i corpi immersi nella corrente non sono mai bagnati dalla stessa acqua. Mentre i nostri contemporanei, sol perché hanno i piedi piantati nel letto del fiume, scambiano la loro fissità con quella del flusso che scorre loro attorno. Ed è perlomeno paradossale che, nell’epoca della rapida obsolescenza di tutte le cose, si debba immaginare come eterna la possibilità della crescita economica e dei suoi vantaggi.
L’affermazione può destare sorpresa, ma è un fatto certo: la gran parte delle scienze sociali contemporanee appare clamorosamente inetta a esaminare i fenomeni entro le due dimensioni fondamentali del mondo fisico, quello nel quale operano tutti i viventi, anche gli economisti dello sviluppo. E tuttavia, chi può negare che i fatti sociali si svolgono nel tempo, posseggono una efficacia che muta, affidata a una durata? A suggerircelo non è solo l’analisi dei costi/benefici che ispira la condotta economica dei ceti dominanti e che bada così poco agli effetti di lunga durata dei successi presenti (e spesso apparenti) dello sviluppo. Pressoché mai la distruzione di risorse, di ricchezze naturali, l’inquinamento ambientale, le malattie e il dolore delle persone vengono intravisti nella loro dimensione futura, nei loro effetti differiti nel tempo. A questo riguardo, almeno di sfuggita, va rammentata la posizione in cui si è posta la nostra generazione: siamo diventati i predoni del tempo degli uomini e delle donne che verranno dopo di noi. Nessuno può oggi prevedere quanto potranno durare i depositi che custodiscono le scorie radioattive delle centrali atomiche, con tempi di degradazione misurabili in millenni, stoccati nell’ultimo mezzo secolo in vari siti del pianeta. Abbiamo nascosto sottoterra i nostri rifiuti di morte e li abbiamo lasciati ai nostri discendenti. In pochi decenni ipotechiamo millenni di avvenire all’umanità che verrà.
Ma restiamo all’oggi, alla presente osservabilità della degradazione temporale dei fatti che abbiamo intorno a noi. Il consumo di beni, che diventa consumismo nel corso di alcuni decenni, cambia nel profondo non solo il senso di soddisfazione dei consumatori. Anche l’originaria liberazione dai bisogni, conquistata con la crescita del reddito, muta la sua natura se si trasforma in una nuova schiavitù verso necessità crescenti e perennemente insoddisfatte. In questa trasmutazione si è silenziosamente esaurita un’intera fase della storia umana. La creazione di nuovi bisogni a mezzo di bisogni – alimentata dall’economia dello sviluppo – somiglia ormai troppo da vicino alla ruota in cui corre inutilmente il criceto, per non generare frustrazione. Simbolicamente e di fatto, è la stessa rapidità con cui i beni si trasformano in rifiuti a mostrare come la qualità originaria del fenomeno si degrada, la sua positività si rovescia.
Al tempo stesso, la riduzione progressiva dei cittadini a puri agenti produttori e consumatori, per tenere in moto la possente macchina economica, corrode il tessuto connettivo della vita sociale, atomizza gli individui e li getta nell’anomia, nella perdita delle identità singole e collettive, nello smarrimento di ogni appartenenza e senso di direzione. Trionfa l’economia e muore la società. È un passaggio storico di incalcolabile portata. Una «inversione dei fini» che si consuma sotto i nostri occhi senza che quasi nessuno abbia capacità di guardare. Con il dissolvimento della società anche i collanti ideali che hanno sinora tenuto insieme i partiti si disfano, lo stesso cemento di partecipazione e controllo, su cui si regge la democrazia, si sgretola. Ma subiamo anche un’altra perdita: l’economia secolare fondata sulla trama invisibile delle relazioni umane va in frantumi. All’interno della società, non dimentichiamolo, è attiva e produce ricchezza l’economia non calcolata – e gratuita come la luce del sole – dell’organizzazione domestica, della cooperazione, della fiducia, della reciprocità, delle mutue informazioni, degli scambi e degli aiuti informali, che operano sotto e al di fuori delle logiche mercantili. Ma nella società pulsa anche il cuore della nostra felicità terrena: vale a dire la fitta rete dei rapporti interpersonali, l’amicizia, la solidarietà, la convivialità, l’amore, il senso stesso della vita e dello stare al mondo. La società, dunque, è un bene inestimabile, un patrimonio storico che ereditiamo quale risultato di una gigantesca opera collettiva. Ed è un bene tecnicamente irriproducibile, che non si compra in un alcun mercato.
D’altro canto, la stessa umana liberazione da antiche superstizioni, da teologie oppressive, dalle varie Chiese che si sono succedute nel tempo, è oggi compromessa dall’avanzare dello sviluppo. Una nuova divinità, sconosciuta sinora a tutte le religioni rivelate, è salita sull’Olimpo e da lì opprime quotidianamente gli umani. Oggi il nume Mercato, officiato da così numerosi sacerdoti, è più temibile del Dio di Abramo. Gli uomini e il loro benessere, che all’origine erano il fine, sono nel frattempo diventati il mezzo, strumenti della crescita economica infinita sacrificati a un Dio vorace.
Non diversamente dai fenomeni naturali, lo sviluppo, dopo la sua piena maturità, degrada e si decompone. Come qualunque organismo, esso nasce, si sviluppa – per l’appunto – e muore. Esiste un’entropia dei fenomeni sociali che lo sviluppo nell’epoca attuale testimonia in forme eloquenti. Essa è visibilissima davanti a noi, purché si abbiano occhi per osservare. Che cosa è diventato lo sviluppo, questo processo materiale e le sue ideologie, se non un vuoto e indeterminato «andare avanti»? L’umana aspirazione al meglio – come già osservava per l’idea di progresso lo storico olandese Johan Huizinga, dal fondo degli anni Trenta del Novecento – è finita in una ingenua credenza, nel «concetto puramente geometrico del procedere innanzi». Mentre, aggiungeva, «può essere che un po’ più avanti, lungo la strada, sia rovinato un ponte o si sia scavato un abisso». Eppure, tutti esortano ancora ad andare avanti, benché nessuno sappia dirci dove stiamo andando e per fare che cosa. E per quali ragioni dovremmo, un po’ più in là, star meglio di come si stia rimanendo qui.
Per la verità, neppure di questo, chi possiede visione storica, ha ragione di stupirsi. Per un lasso di secoli molto più lungo dei pochi che hanno scandito l’epoca del progresso, l’umanità ha creduto di migliorare la propria condizione «andando indietro», tornando all’Eden originario. La ricerca della primitiva «età dell’oro» ha sedotto non poche menti e per una fase che sarà sembrata eterna – non diversamente da oggi – anche ai contemporanei di allora. A quel tempo, i sacerdoti che officiavano nella vita pubblica erano diversi da quelli di oggi, ma non meno convinti. Solo da qualche secolo il capitalismo ha fatto balenare la presenza di un nuovo Eldorado, raggiungibile con il moto meccanico del proseguire. Ma anche tale direzione potrebbe oggi mutare. Può darsi che la prospettiva del riscaldamento globale renda nei prossimi anni poco desiderabile anche l’andare avanti. Così, i fautori dello sviluppo dovranno indicarci sulla rosa dei venti una nuova direzione verso cui marciare... Attendiamo con fiducia, non mancheranno certo nuovi slogan. E tuttavia vorremmo almeno rammentare il carattere relativo delle direzioni di marcia. È un dato imprescindibile, se si vuol dare al presente la fisionomia di una fase transitoria e, tutto sommato, breve della storia umana.
La speranza, dunque, di un futuro migliore che dava slancio alle società occidentali uscite dalle miserie della seconda guerra mondiale – in buona parte, peraltro, realizzata – si è oggi trasformata in una vacua teleologia dell’oltranza. La fiduciosa convinzione di Kant che l’umanità fosse «in costante progresso verso il meglio» è diventata una superstizione di massa. Non a caso una mente appassionata e acuta come quella di Norberto Bobbio – nel saggio Riformismo, socialismo, uguaglianza – si è spinta, anni fa, a chiedersi: «E se fosse invece in costante regresso verso il peggio?». Un dubbio salvifico, forse il solo che può liberare il pensiero dal suo presente grigiore funzionariale. Ma è una domanda che aleggia poco intorno a noi. E poiché fa parte dell’intelligenza di un’epoca comprendere per tempo quando la storia muta il suo corso, gran parte dei problemi presenti derivano dal fatto che la nostra non l’ha ancora compreso.
Ben più ampi e rilevanti sono stati gli esiti e gli effetti della cancellazione dell’altra dimensione in cui è prosperato lo sviluppo: lo spazio. E per spazio intendiamo la natura, la realtà fisica, il mondo vivente. Tale rimozione, anzi, costituisce il cuore di uno dei più giganteschi paradossi dell’età contemporanea. È davvero stupefacente constatare come l’economia, il sapere tecnico-scientifico che ha signoreggiato tutti gli altri saperi, che ha avuto le ricadute più drammatiche su tutto ciò che ci circonda, il motore primo che trasforma ogni cosa, sia fondata su una cultura naturalistica, su una comprensione assolutamente nulla dei legami che governano la Terra. Più precisamente, è fondata sulla cancellazione del mondo fisico.
Certo, non è tutto opera dello sviluppo e delle ideologie recenti che lo accompagnano. Siamo di fronte agli esiti ultimi di una cancellazione culturale che ha avuto bisogno di alcuni secoli per affermarsi. Oggi conosciamo i passaggi, le elaborazioni dottrinali, i percorsi culturali attraverso cui, da Aristotele a Marx, il pensiero teorico ha separato i processi di produzione della ricchezza dal mondo fisico, dalla realtà vivente. Con la sistematicità che rende inimitabili gli studiosi tedeschi, Hans Immler ce ne ha fornito un quadro possente in un’opera del 1985, Natur in der ökonomischen Theorie. Ma, ancora ai tempi di Smith, di Ricardo e di Marx, era pur sempre comprensibile che il pensiero economico tendesse ad assegnare al lavoro tutti i meriti della creazione del valore delle merci. E, per quell’epoca, costituiva un indirizzo di pensiero non poco rivoluzionario. Tanto più che i padri dell’economia politica, e soprattutto il loro maggior critico, non dimenticarono del tutto il ruolo della natura nel processo di produzione della ricchezza. Senza contare che l’opera di distruzione degli equilibri ambientali del pianeta non era ancora così conclamata com’è oggi.
Il paradosso, in realtà, si fa gigantesco negli ultimi decenni: allorché la potenza dei processi economici reali incide così gravemente su tutta la biosfera e il pensiero economico dominante che l’ispira ha, nel frattempo, definitivamente perduto ogni ancoraggio con la Terra. Ed è davvero di grande significato che la teoria economica, dopo averla così gravemente compromessa con la sua radicale rimozione, abbia scoperto la natura e la sua vulnerabilità coniando in tempi recenti il concetto di esternalità negativa. Il mondo vivente – viene finalmente riconosciuto – è danneggiato dalle attività produttive: un fenomeno che costituisce una perdita effettiva, conteggiabile in termini di costi aziendali. Così la natura e il suo valore diventano finalmente visibili e valutabili perché rientrano nella logica e nel calcolo economico. E per questa via, dunque, essa viene considerata, protetta e valorizzata.
Singolare ma rivelatrice simplicitas. Come se la natura fosse l’aiuola che si distende oltre i recinti degli stabilimenti! Come se il mondo fisico si trovasse all’esterno della fabbrica sotto forma di prati verdi, ruscelli, alberi. Ma la natura è, prima di tutto, dentro la fabbrica, la fabbrica stessa, sotto forma di macchinari, di energia, di materie prime. Come se il capitale fisso, prima di diventare tale, non fosse ferro, rame, piombo, idrocarburi sottratti alle viscere della terra nelle varie miniere e nei pozzi sparsi per il mondo. Come se, prima di diventare macchine produttive, esse non fossero natura inorganica per manipolare la quale si abbattono foreste, si distruggono colline, si inquinano fiumi e laghi, si devastano immensi territori. In realtà, la natura è ex ante protagonista e vittima del processo produttivo.
Ma non è tutto. L’economia non solo ha cancellato il ruolo e il valore di ciò che utilizzava a una scala che non aveva uguali in tutte le precedenti fasi della storia umana. Non solo ha considerato il sistema sociale e i suoi processi come indipendenti da ogni fondamento naturale. È andata oltre: non ha avuto alcuna percezione delle connessioni profonde che legano il mondo vivente in equilibri invisibili, fragili e delicati. Essa ha proceduto separandosi dalle altre discipline che si occupano della natura. Non per nulla è stato grazie ad altri saperi – chiamati post factum a un’opera riparatrice – che noi abbiamo scoperto, talora con drammatico ritardo, i nessi che legano fenomeni tra loro lontani e apparentemente incommensurabili. D’altro canto, occorre riconoscerlo, non era facile per nessuna scienza. Chi avrebbe mai immaginato che spruzzarsi la lacca sui capelli con una bomboletta spray avrebbe contribuito alla lacerazione dello strato di ozono atmosferico? Eppure, i gas clorofluorocarburi, largamente impiegati nei processi di refrigerazione e in altre attività industriali, si sono manifestati temibili agenti distruttori di un equilibrio essenziale per la biosfera. Addirittura, la vita sulla Terra ne viene minacciata. Come ha di recente ricordato uno scienziato australiano, Tim Flannery, senza l’elevatissimo fattore di protezione solare dell’ozono, le radiazioni ultraviolette ci ucciderebbero in poco tempo, decomponendo il nostro Dna e spezzando altri legami chimici all’interno delle nostre cellule. Ed è stato solo per caso, e per grande fortuna, che nella composizione di tali gas sia stato utilizzato il cloro e non il bromo – come pure sarebbe stato possibile –, quarantacinque volte più distruttivo dell’ozono. Ce lo ha rivelato Paul Crutzen, premio Nobel per la chimica, che insieme a Frank Sherwood Rowland e Mario Molina scoprì la causa del buco dell’ozono. «Se l’umanità – ha commentato Flannery – avesse trovato il bromo più economico del cloro o più comodo da usare, con ogni probabilità al momento in cui Paul Crutzen e i suoi colleghi fecero la loro scoperta, avremmo tutti subìto incidenze senza precedenti di cancro, cecità e altre malattie, il nostro approvvigionamento di cibo sarebbe entrato in crisi, e la nostra civiltà sarebbe stata sottoposta a una tensione intollerabile. E non avremmo avuto la minima idea della causa finché non fosse stato troppo tardi per agire». È stupefacente! Pochi decenni di sviluppo hanno rischiato di compromettere il rapporto millenario degli uomini con la loro maggiore stella, di annullare il suo ruolo di primo agente della vita sulla Terra, di trasformarlo nel nostro definitivo nemico.
Il drammatico squilibrio tra la potenza pratica dello sviluppo e la rozzezza riduzionistica delle ideologie che lo sorreggono appare oggi finalmente conclamato nella realtà presente e nella minaccia ventura del riscaldamento climatico. Ghiacciai millenari che si sciolgono di anno in anno sotto i nostri occhi, allarmante diminuzione delle piovosità in tante regioni del globo, desertificazione crescente nelle latitudini centrali e meridionali, moltiplicazioni degli uragani e dei fenomeni climatici estremi, ondate di calore estivo che colpiscono la popolazione anziana nelle varie città del mondo. Ecco, questi fenomeni sono la prova provata che l’andare oltre della crescita economica turba equilibri generali a cui quasi nessuno mezzo secolo fa aveva pensato. I nostri consumi e comportamenti privati hanno effetti globali. Così «l’andare avanti» precipita in un paradosso che risulta inaccettabile alla stessa razionalità economica che ne è la causa: lo sviluppo distrugge quantità crescenti di ricchezze, mette in forse le basi stesse per poter continuare a produrne in avvenire.
E non parliamo di lontane prospettive, non evochiamo il futuro: questa dimensione del tempo la lasciamo ai rètori dello sviluppo, che la predicano tutti i giorni come un mantra petulante mentre vivono impaniati in un presente cieco e routinario. Parliamo del presente, la sola dimensione temporale a cui sembrano sensibili i poteri dominanti del nostro tempo.
Per la verità, il fenomeno era in bella vista almeno da qualche decennio. La distruzione delle foreste equatoriali, la riduzione della biodiversità, l’avanzare dei deserti, la perdita crescente di terra fertile, l’inquinamento dei mari, dei laghi e dei fiumi, la scarsità crescente di acqua, le piogge acide, lo smog urbano erano ben visibili almeno dagli anni Settanta del Novecento. Eppure la corsa è proseguita e lo sviluppo ha continuato a svolgersi con una messa in moto di energie e risorse che non ha precedenti in tutta la passata storia del capitalismo. Certo, non sono mancati gli esorcismi. Uomini e donne sinceramente pensosi del nostro avvenire – e di seguito tutti i potenti della Terra – hanno cercato di porre rimedio all’avanzare dello sviluppo con qualche aggettivo, anzi, con un solo aggettivo: sostenibile. Potenza delle parole! Da quando l’espressione sviluppo sostenibile – proposta dal rapporto della Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo nel 1987 – è stata quasi universalmente adottata, al vertice di Rio del 1992, il pianeta Terra non ha cessato un istante di subire i colpi più gravi della sua storia. E come poteva andare diversamente? Se il benessere dell’umanità dev’essere sempre e comunque raggiunto attraverso la crescita economica, la natura dovrà – necessariamente – acconciarsi a sostenerla.
Oggi, tuttavia, dopo la scoperta del buco dell’ozono e dopo che migliaia di scienziati al di sopra di ogni sospetto ci hanno squadernato scenari di sconvolgimenti globali per effetto del riscaldamento climatico, siamo finalmente approdati a una nuova consapevolezza. Non abbiamo più di fronte problemi singoli, «regionali», affrontabili e superabili con nuovi e sperati sussidi della tecnologia. Ciò che appare sempre più evidente è la drammatica inettitudine dei saperi che guidano lo sviluppo a prevedere gli effetti a lungo termine del suo operare, a cogliere e valutare le connessioni che stringono in una maglia ancora in larga parte indecifrabile la complessa indivisibilità del vivente. Se essa si spezza in un punto, più in là, in un’area imprevedibile, si turberanno equilibri vitali.
Tutto ciò non è che l’esito di una situazione inevitabile di cui si tarda a prender coscienza: il mammifero uomo, nel giro di un paio di secoli di sviluppo tecnico, si è posto in c...
Indice dei contenuti
- 1. Fine dello sviluppo
- 2. La grande ritirata
- 3. Quel che può la politica
- Riferimenti bibliografici