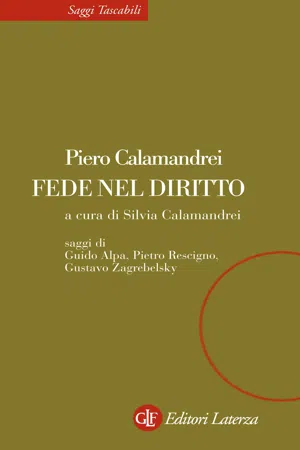
- 148 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Fede nel diritto
Informazioni su questo libro
La certezza del diritto e il culto della legalità sono la trincea presidiata da Piero Calamandrei all'indomani dell'invasione nazista della Polonia. Negli anni oscuri della guerra e della dittatura il giurista si interroga: «il diritto qual è, quello del vincitore o quello del vinto, quello di chi vuol mantenere le proprie leggi, o quello di chi vuol instaurare un ordine nuovo in luogo delle leggi abbattute?». In queste pagine, il testo inedito di una appassionata conferenza di Calamandrei sui confini tra politica e scienza giuridica, 'diritto libero' dei totalitarismi e tradizione giuridica romana.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Filosofia politicaFede nel diritto
Firenze 21 gennaio 1940
1. Mai come in questo tormentato ventennio in cui le nostre generazioni hanno vissuto, dopo finita una guerra, una pace apparente che era in realtà febbrile preparazione e angosciosa attesa della nuova guerra che oggi insanguina il mondo, i problemi teorici che hanno affaticato in tutti i tempi le menti dei filosofi sulla essenza della giustizia e sulla natura razionale del diritto si sono presentati con altrettanta urgenza alle coscienze come vitali e tormentosi problemi di vita pratica.
Questa angoscia, che turba tutte le coscienze oneste, è sopra tutto sofferta dai professionisti del diritto, da coloro che hanno dedicato il meglio della loro vita al servizio delle leggi, in qualità di giudici, di avvocati, di docenti. Anche quelli di loro che non si intendono di filosofia, avvertono nella quotidiana fatica del loro ufficio, che li chiama non a dissertare astrattamente sul fondamento deontologico della giustizia, ma a dar giustizia in concreto agli uomini che ne sono assetati, un profondo turbamento, un senso di disorientamento e di fluttuazione, come se vacillassero quelle premesse su cui un tempo pareva solidamente fondata ogni attività ed ogni scienza giuridica. Questo senso di scetticismo e quasi di diffidenza di fronte al fenomeno giuridico è sopra tutto visibile nei giovani; anche in quelli che per forza di tradizione familiare o per speranza di più agevole approdo professionale continuano ad imbarcarsi nelle facoltà di giurisprudenza, l’ardore per gli studi da loro scelti, la convinta fede nel diritto come missione più che come mestiere, mi pare (se non mi inganno) che si vada sempre più rarefacendo: quelle parole che un tempo, senza bisogno di tanti commenti, ridestavano nei cuori giovanili il fremito delle cose vive, pare che oggi abbiano perduto ogni loro risonanza sentimentale, e quasi ogni loro significazione attuale.
Esaltate dinanzi ai giovani la giustizia e il diritto: vi staranno a sentire distaccati e quasi ostili, domandando a sé stessi quale pratica sostanza si nasconda dietro questa oratoria: col sospetto che queste parole non siano che un tranello retorico invano teso al loro vigile ‘realismo’, non più disposto ormai a lasciarsi incantare dalle vuote parole sonanti del buon tempo antico.
Giustizia? Ma quale sicura realtà si nasconde dietro questa erma dalle molte fronti, che cambia faccia secondo l’angolo visuale da cui si guarda? Due litiganti vanno dinanzi al giudice e tutt’e due, per soverchiare l’avversario, invocano la giustizia; la parola è la stessa, ma per ciascuno di essi vuol dire l’opposto, vuol dire la propria vittoria e la rovina del suo contraddittore. Due popoli si scannano per la conquista di un regno: tutt’e due hanno scritto la parola diritto sulla propria bandiera; ma il diritto qual’è, quello del vincitore o quello del vinto, quello di chi vuol mantenere le proprie leggi, o quello di chi vuol instaurare un ordine nuovo in luogo delle leggi abbattute? Quello di chi difende il proprio focolare o quello di chi saccheggia il focolare altrui?
Troppe conferme sembra avere d’intorno a noi, anche in questa storia contemporanea in mezzo alla quale angosciosamente viviamo, la dottrina, che risale ai Sofisti, secondo la quale, come diceva Trasimaco, «la giustizia è ciò che giova al più forte»: e come si può sul serio continuare a cullarsi nella pia illusione che immagina la forza posta al servizio del diritto, quando tutti i giorni vediamo che proprio dalla forza, nient’altro che dalla bruta forza delle armi esce quell’ordine apparente che i vincitori chiamano diritto?
Né vale, a liberare il giurista da questi dubbi incalzanti, l’insegnamento positivista secondo il quale il diritto è tutto nella legge; onde chi serve fedelmente la legge, può così essere certo di servir la giustizia. Anche qui la coscienza irrequieta gli obietta che non in tutte le leggi il diritto è racchiuso nella stessa misura: egli sente parlare intorno a sé di leggi buone e di leggi cattive; le discussioni dei politici sull’opportunità di modificare con nuovi ordinamenti le istituzioni invecchiate, sono discussioni sulla giustizia delle leggi; le proposte di riforme mirano sempre a porre leggi che si credono più giuste al posto di quelle di cui si afferma il contrario. Anche le leggi, dunque, possono esser discusse e giudicate: e se una legge può esser giudicata ingiusta, vuol dire che il diritto, che si prende come criterio per giudicare la legge, sta fuori di essa. E dove sta dunque questo diritto se non nella forza che abbatte le leggi, se non nel fatto che le rinnuova?
Ecco così che il giurista che un tempo si considerava come la viva voce del giusto, e per il quale si adoperava senza sorridere la qualifica di sacerdote della giustizia, è scaduto nella comune opinione al livello di un equilibrista della dialettica che ingegnosamente si esercita sui trapezi delle pure formule, senza darsi pensiero del contenuto, buono o cattivo, ch’esse ricoprono. E poiché si osserva che anche su leggi invecchiate e ormai condannate dalle nuove correnti politiche che stanno per prevalere, i giuristi continuano a costruire imperturbabili sub specie aeternitatis i loro castelli logici, e che viceversa appena un ordinamento giuridico è precipitato, la loro schiera è sollecita ad accorrere per fare ossequio alle nuove leggi che lo hanno distrutto ed a ricominciar su di esse, servendosi degli stessi strumenti del mestiere, la costruzione delle loro architetture dialettiche, essi rischiano ormai di apparire come dei calcolatori senz’anima e senza preferenze, schiavi del fatto, pronti a servire qualunque padrone, che colla forza abbia saputo imporre e tradurre in leggi la sua volontà. Di qui l’origine di quello scetticismo che c’è oggi tra i giovani, anche tra quelli che si iscrivono a giurisprudenza, sulla forza ideale di quel diritto ch’essi studiano: la scienza giuridica fa un po’ la parte non brillante della grammatica, la quale si adatta a tutti i testi, ma non ha niente a che fare coll’ispirazione artistica. La fede nel diritto, il ‘senso del diritto’ sembrano vuote frasi: il vecchio aforisma cedant arma togis ormai non serve più neanche a far sorridere. C’è nelle nuove generazioni una diffusa anche se inconsapevole tendenza, quasi si direbbe respirata coll’aria, a svalutare la importanza del diritto e a sopravalutare la importanza del fatto compiuto: volontarismo ed attivismo giuridico che, innamorato dei fatti maschi, si lascia indietro con disprezzo l’imbelle razionalismo della vecchia dogmatica.
2. Questa crisi del diritto, che si fa sentire in modo direi quasi spasimante nella nostra pratica individuale, e che si potrebbe chiamare la crisi di incomprensione della importanza del diritto, ha, naturalmente, come tutti i movimenti pratici, la sua preparazione e i suoi precedenti nel campo delle teorie filosofiche. Io non posso qui neppur tentar di riassumere le annose dispute che da secoli si sono dibattute e si dibattono sul fondamento e sul concetto del diritto; né passare in rassegna tutte quelle correnti filosofiche, dette ‘scettiche’ o ‘realistiche’, che, a partire dall’antichità classica ai giorni nostri hanno sostenuto che il diritto altro non è che una espressione d’autorità e di forza, privo di qualsiasi fondamento ideale. Ma non posso esimermi dal ricordare che la odierna crisi delle coscienze intorno al fondamento ed ai confini del diritto, ormai così malcerti e sfumanti che più non si riesce ad intendere quale sia e se vi sia un proprio territorio d’attività riservato ai giuristi, si riannoda direttamente a quella concezione oggi prevalente, secondo la quale, in sede filosofica, la esperienza giuridica coincide e si identifica colla esperienza politica. Tale identificazione (la quale ha come sue necessarie premesse da una parte la celebre tesi crociana della riduzione del diritto all’economia, e dall’altra la riduzione di tutte le leggi al concreto atto volitivo, considerato come la sola realtà che esiste nella vita del diritto) pone sullo stesso piano l’attività di chi crea il diritto e l’attività di chi lo esegue e lo applica: anzi nega che, sotto l’aspetto filosofico, si possa far differenza tra creazione ed applicazione del diritto, e quindi tra un’attività politica volta soltanto alla creazione ed una attività volta alla sola applicazione del diritto, che, in contrapposto con quella, si possa considerare meramente giuridica. La parola ‘politica’ assume dunque, in questa concezione dei filosofi, una portata più vasta di quella che ha nel comune linguaggio: mentre nella terminologia ordinaria la parola politica è riservata a indicare quel complesso di forze che agiscono per arrivare ad esprimersi in leggi e quindi per instaurare nello Stato un certo sistema di norme giuridiche, la filosofia osserva che non meno dell’attività creatrice delle leggi si deve considerare rientrante nella politica l’attività volta ad eseguirle, poiché «la legge non esiste che come volontà di legge, cioè come volontà politica di sostenere colla forza una data legge». Non solo dunque è indirizzata a scopi pratici, ossia politici, l’opera del legislatore che col dettare le leggi mira a imporre alla società un certo ordine corrispondente alla sua volontà, ma è altresì essenzialmente pratica e quindi politica l’attività di chi trasforma in concreti atti di volontà i suggerimenti e le direttive contenute nelle norme astratte poste dal legislatore: sia esso il privato che per la sodisfazione del proprio interesse individuale stimola l’intervento dell’autorità posta a tutela del diritto, o il giudice che colla sua sentenza pone in luogo della inerte ed astratta ipotesi della legge una volontà concreta volta a modificare praticamente la realtà, o più in generale il giurista, la cui indagine non si limita mai ad un processo meramente conoscitivo e teorico, ma costituisce anch’essa un atto pratico col quale egli concorre a creare la legge del caso singolo ed in tal modo alla modificazione ed al progresso del diritto.
Così il diritto è forza, non solo in quanto colla forza delle rivoluzioni o delle conquiste si instaurano i regimi che creano il diritto, ma altresì in quanto ogni atto con cui il diritto concretamente si realizza appare, attraverso la volontà del giudice, dell’avvocato, del giurista, come la prosecuzione e il complemento di quella stessa forza che l’ha creato.
3. Tutto questo potrebbe anche essere esatto in sede filosofica: fino a quando cioè queste proposizioni fossero intese per quello che esse vogliono essere da chi le ha enunciate, cioè come teorie volte a comprendere in che cosa consista l’attività giuridica collocata al suo posto nel quadro dei momenti dialettici dello spirito, e non già come insegnamenti pratici, sui quali gli uomini debbano regolare le loro relazioni quotidiane. Che un filosofo mi dica che la legge è irreale e che solo la concreta volizione individuale crea il diritto, è cosa che può lasciare indifferente me giurista, purché resti ben inteso che se nella pratica qualcuno, con questa scusa della irrealtà delle leggi pretendesse di violarle a piacer suo, andrebbe ugualmente (nella pratica) a finire in mano dei carabinieri.
Ma il male è che certe teorie filosofiche che «non a torto si chiamano verità pericolose» rischiano di avere nella vita pratica, quando siano messe in mano di chi non abbia la serenità speculativa che pone il filosofo in quanto tale al di sopra delle risse, ripercussioni di carattere diciamo così pedagogico, che vanno assai al di là delle intenzioni di chi le ha enunciate: formulate al solo scopo di intendere e interpretare la realtà, esse rischiano di diventare armi micidiali per insegnare a metter lo scompiglio nel mondo e per giustificare le peggiori furfanterie. A forza di sentir dire che il diritto si riduce all’economia, c’è il caso che l’inesperto e il dilettante (che è anche peggiore) di filosofia, si metta a proclamare che il diritto consiste unicamente nel far tutti quanti il comodo proprio; a forza di sentir dire dai filosofi che le leggi sono «irreali» e che ciò che vale è solo il «concreto atto volitivo», c’è il pericolo che il laico si metta a praticare individualmente la violenza senza curarsi dei codici, convinto di aver bene imparato la lezione e di porre in essere così, colla forma del suo pugno, quel concreto atto volitivo nel quale solo, secondo i filosofi, il diritto si concreta e vive. Così queste verità filosofiche, le quali erano nate come spassionati riconoscimenti e interpretazioni della realtà, si trovano ad essere, quando siano adoprate da mani inesperte, come le forze cieche scatenate dall’apprenti sorcier, ignaro della formula, per ricacciarle nell’abisso. Solo chi vive come noi la vita pratica del diritto, così faticosa e dura, può misurare quanto la diffusione di queste ‘verità pericolose’ sul fondamento del diritto abbia contribuito ad ingenerare e ad aggravare questo discredito del diritto nella vita pratica di cui tanto soffriamo.
Proprio su una consimile trasposizione sofistica di una proposizione dal campo della speculazione filosofica a quello dell’operare pratico, si fonda l’accusa di insensibilità politica periodicamente rivolta ai giuristi. La filosofia, come si è veduto, prende i giuristi quali essi sono, col loro attaccamento alla legge, col loro dogmatismo, colla loro tecnica: e dimostra che, comportandosi così come si comportano, e servendosi di tutti quegli strumenti logici e metodologici di cui essi si valgono per interpretare le leggi e per applicarle ai casi pratici, essi fanno senza accorgersene della politica, al modo stesso con cui monsieur Jourdain parlando faceva senza accorgersene della prosa. Questo la filosofia dice ai giuristi; ma non dice che essi facciano male a fare così come sempre hanno fatto, né si propone, con questa enunciazione di una verità teorica, di negare la utilità pratica del loro metodo, o di atteggiarsi a maestra della loro arte. Viceversa in questi ultimi anni questa verità filosofica della identificazione del diritto colla politica è stata invocata come argomento polemico contro i giuristi, ai quali si è rimproverato di rimanere attaccati ai loro studi, alla loro dogmatica, alla loro tecnica, a tutti quegli strumenti metodologici insomma l’uso dei quali costituisce per definizione l’attività e la scienza giuridica; e di non decidersi finalmente a cambiar mestiere, mettendosi a fare, invece che i professionisti del diritto, i professionisti della politica.
Ma nella vita pratica la attività giuridica non esiste come categoria filosofica; nel mondo empirico esistono i giuristi (cioè quegli uomini che fanno i giudici, gli avvocati, i docenti e così via) come professionisti, la cui attività professionale è necessariamente ristretta entro certi confini, per quel bisogno della divisione del lavoro e della specializzazione al quale naturalmente obbedisce ogni tecnica. Proprio per questa divisione del lavoro, che è supremo canone di ogni operare umano, l’attività dei giuristi, come tecnici dell’applicazione delle leggi, si distingue, per metodo, per studi, per forma mentis, dall’attività di coloro che, invece che ad applicare ai casi della vita il diritto già formulato nelle leggi vigenti, si adoprano a creare il diritto nuovo, cioè a dare impulso agli organi ai quali nello Stato è demandata la formulazione del diritto e ad ottenere che da essi, al posto delle leggi vigenti altre siano formulate più giuste di quelle vigenti. Quest’ultima attività, volta a creare il nuovo diritto, è quella che nel linguaggio ordinario si chiama, stricto sensu, la politica: e in questo senso, nel senso cioè di una necessaria divisione di lavoro corrispondente a due diversi momenti della vita del diritto, la formulazione delle leggi e la loro applicazione, si intende perfettamente, nella terminologia dei laici, la distinzione tra politici e giuristi. Non sarà questo un modo di esprimersi filosofico, perché per i filosofi tanto l’attività di chi prepara le nuove leggi, quanto l’attività di chi le applica è allo stesso modo attività politica, ma insomma con questo modo di esprimersi alla buona, è certo che tra noi gente modesta ci intendiamo e ci siamo sempre intesi: quando si dice che la giustizia dev’esser al sicuro dalle inframettenze politiche, o si contrappone il ius conditum al ius condendum, o nell’esaminare un problema si dice che altro è l’aspetto giuridico altro è l’aspetto politico sotto il quale può essere considerato, adopriamo espressioni che sappiamo corrispondere a una reale divisione di competenze tecniche, che si trova attuata in realtà nella vita empirica dello Stato.
Ora il sofisma di chi attacca i giuristi per non essere abbastanza politici è appunto questo: poiché sul piano speculativo (si dice) una stessa categoria filosofica, quella della politica, comprende tanto la attività di coloro che nella vita pratica operano per creare le leggi (i politici stricto sensu) quanto la attività di coloro che nella vita pratica operano per applicarle (i giuristi), è bene che anche nella pratica tecnica scompaia ogni distinzione tra queste due attività, nel senso che anche i giuristi debbano d’ora in avanti cessare di essere i servitori delle leggi vigenti, per diventare invece i promotori delle leggi dell’avvenire. Sarebbe come chi dicesse, insomma che, poiché sotto l’aspetto speculativo il lavoro del calzolaio è una attività pratica, che filosoficamente, nella classificazione dei momenti dialettici dello spirito, non si distingue dal lavoro del muratore, sarà bene che d’ora innanzi i calzolai si mettano a tirar su i muri ed i muratori a risolare le scarpe!
4. In realtà questa polemica contro i giuristi, accusati oggi di essere troppo ligi alla lettera delle leggi costituite e di non sentire il vento che irrompe dalle finestre a squassare le loro bilancine, è sopra tutto una polemica contro le leggi, ossia contro quella formulazione generale ed astratta che tipicamente distingue le leggi dalle altre manifestazioni di volontà dello Stato. Questo è stato infatti, in tutti i tempi, il singolare ed alterno destino dei giuristi: che tutti i dissidi polemici suscitati dalla astrattezza delle leggi, talvolta esaltate per la loro completezza comprensiva d’ogni possibile caso futuro, talvolta vituperate per la loro rigidezza che non si plasma sulla variabile multiformità della vita, sono sempre andati a scaricarsi sui giuristi, presi come comodi bersagli di urti di idee che in realtà non concernevano loro, ma le istituzioni di cui essi erano i visibili strumenti. Nei momenti storici prevalentemente statici, in cui l’autorità della legge era fortemente sentita e prevaleva la superstizione della sua onnipotenza, i legislatori hanno additato nei giuristi i più pericolosi nemici della integrità del diritto, ed hanno visto in ogni commento ed in ogni interpretazione dei testi legislativi una minaccia di infiltrazioni politiche che doveva essere rigorosamente repressa. Viceversa, in periodi più dinamici, il rimprovero fatto ai giuristi si è capovolto: sono accusati non più di insidiare la integrità della legge, ma di prestarle ossequio.
Così i giuristi, rimproverati in certi momenti di esser troppo politici, in altri di non esserlo abbastanza, si trovano, secondo il vario ritmo dei tempi, tra l’incudine di chi li rappresenta come rivoluzionari cupidi dell’avvenire, e il martello di chi li raffigura come conservatori grettamente attaccati al passato. Giova dunque approfondire il vero punto del dissidio che si cela sotto ...
Indice dei contenuti
- Una travagliata apologia della legge
- Il rifiuto del sistema normativo dei totalitarismi
- Un atto di «fede nel diritto»
- Fede nel diritto
- Appendice
- Tra Socrate e Antigone
- Il dialogo epistolare tra Calamandrei e Calogero
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Fede nel diritto di Piero Calamandrei,Silvia Clamandrei in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Filosofia politica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.