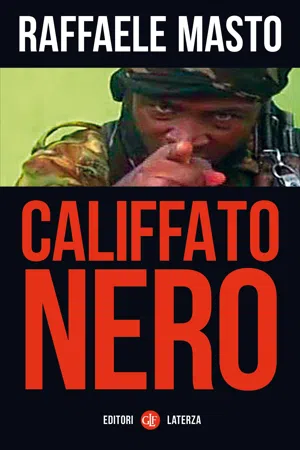1.
Le gesta di Boko Haram
È la notte tra il 14 e il 15 aprile 2014. Due pullman e tre camion percorrono le strade della periferia est della cittadina di Chibok, stato di Borno. Nel silenzio che avvolge il centro abitato, si fermano nei pressi dell’ampio cortile della Government Secondary School, protetto da un muro di cinta sbrecciato, un tempo ricoperto da una vernice marrone scuro. A luci spente sopraggiungono anche tre fuoristrada carichi di uomini armati, che scendono agili e si avviano verso il cancello della scuola.
Il vecchio guardiano viene svegliato, esita ad aprire, ma poi vede le divise dell’esercito – e soprattutto le armi spianate – e si convince. Una volta all’interno, gli uomini in uniforme cominciano a urlare e ad aprire a calci e spallate le porte di camerate e aule dove intere classi di studentesse stanno dormendo in vista dell’esame del giorno successivo. «Uscite, uscite... la scuola è in pericolo! Tra poco ci sarà un attacco dei guerriglieri, siamo qui per portarvi in salvo... Da questa parte, da questa parte!».
In breve il cortile è un brulicare caotico di ragazze che strillano, che si chiamano l’un l’altra, che piangono. Gli uomini le spingono verso l’uscita, dove sono parcheggiati i pullman e i camion. Le giovani non hanno alternative. Qualcuna sospetta, ma i kalashnikov puntati non consentono esitazioni e dissuadono dai tentativi di non salire a bordo. Nel giro di qualche minuto tutti i mezzi sono stipati, si muovono, si incolonnano e puntano verso nord, diretti alla foresta di Sambisa.
Le ragazze, tenute sotto tiro, sono terrorizzate e ora non hanno più dubbi: sono state rapite, e i sequestratori non possono essere altro che i miliziani di Boko Haram. Ne hanno la conferma quando viene loro bruscamente ordinato di smettere di disperarsi e di aggiustarsi il velo che hanno ricevuto: «È il miglior giorno della vostra vita», urla uno dei capi guerriglieri, che indossa una mimetica su misura e ha il busto attraversato da una bandoliera di proiettili. «Vi faremo convertire all’unica vera religione e vi daremo in spose ai santi uomini che compiono il jihad. Siate contente, oggi il vostro unico Dio, il santo e misericordioso, vi ha chiamate a servirlo e ad abbandonare gli infedeli!».
È questa la ricostruzione essenziale, basata su testimonianze locali e sul racconto di una delle ragazze riuscite a fuggire in quelle prime fasi dell’azione che ha fatto conoscere nel mondo Boko Haram. Una storia che fu possibile leggere su tutti i giornali nigeriani nei giorni successivi al sequestro.
Qualche settimana dopo mi trovavo a Calabar, nello stato meridionale di Cross River, e molte persone del luogo mi mostrarono ritagli di quotidiani che parlavano del rapimento e ne ricostruivano le fasi essenziali. Fui colpito dal fatto che, a differenza di altre notizie, questa aveva lasciato un segno anche nell’opinione pubblica del Sud del paese, che di solito considera ciò che accade al Nord come qualcosa di lontano, quasi estraneo alla Nigeria. In quel caso, invece, la gente era rimasta impressionata. Eppure non era il primo sequestro e, a differenza di altre occasioni, quella non fu un’operazione cruenta: non fu necessario sparare nemmeno un colpo, ma la notizia fece immediatamente il giro del mondo.
C’erano tutti gli elementi necessari per solleticare l’immaginario occidentale: 276 adolescenti in mano a miliziani oscurantisti, sessuofobici, abituati alla violenza e ostili all’universo femminile, considerato utile solamente a soddisfare le necessità materiali maschili. E infatti il mondo si mobilitò: uomini e donne dello spettacolo, della politica, dello sport e della scienza lanciarono una campagna internazionale che fu ripresa dai media e diventò virale sui social network: Bring Back Our Girls, riportate a casa le nostre ragazze.
Uno slogan tanto efficace dal punto di vista mediatico quanto inutile a ottenere il rilascio delle liceali, che infatti sparirono nel nulla, anche grazie al fatto che a Chibok i tempi di reazione furono lentissimi: la gente si riversò nelle strade solo dopo che i miliziani furono ripartiti e non ci fu nessun tentativo di opposizione popolare, probabilmente anche perché le ragazze sequestrate provenivano dalle zone circostanti, e la stragrande maggioranza di loro non aveva parenti in città. La guarnigione di polizia era composta da soli sei agenti, che si guardarono bene dall’intervenire e che comunque disponevano di un unico mezzo privo di carburante, ragione per cui non si riuscì nemmeno a organizzare un inseguimento. Vennero chiesti rinforzi, ma fu impossibile ottenerli in tempi utili.
Così Boko Haram mise a segno un’operazione che, dal punto di vista mediatico, fu più efficace di una studiata campagna di propaganda. Ne ebbi la sensazione immediata seguendo quegli avvenimenti dalla redazione di Radio Popolare: agenzie, grandi testate, commentatori e analisti furono costretti a parlarne. Il video diffuso qualche tempo dopo dagli stessi guerriglieri, in cui le ragazze recitavano versetti del Corano avvolte in lunghi, anonimi hijab neri e grigi, e le minacce del leader Abubakar Shekau di «venderle al mercato» impressionarono ulteriormente l’opinione pubblica mondiale.
Il sequestro si rivelò un successo anche dal punto di vista militare e – potremmo dire – delle «relazioni diplomatiche». Il gruppo si era procurato una sorta di «scorta» di potenziali kamikaze da sfruttare in attentati e attacchi, e ora disponeva di «merce» da offrire a notabili, finanziatori e sostenitori, all’interno della Nigeria e anche all’estero. Verosimilmente, infatti, le liceali furono quasi subito divise in gruppi e disperse, in attesa di deportazione in altri luoghi, nelle basi all’interno della foresta di Sambisa, oppure assegnate a combattenti di spicco e comandanti militari, o ancora destinate a divenire omaggi per famiglie facoltose in alcuni paesi della penisola arabica.
Quel rapimento di massa è ancora oggi l’evento più noto della storia di Boko Haram, ma a quell’epoca la formazione di Shekau aveva già alle spalle almeno dieci anni di azioni, sebbene scarsamente registrate dai media internazionali. Anche i servizi e l’intelligence di molti paesi occidentali avevano studiato poco e conoscevano solo parzialmente questo gruppo, la sua matrice, la catena di comando, gli equilibri interni, la geografia dei suoi leader e le influenze esterne finanziarie, ideologiche e religiose.
Chibok si trova nel mezzo di quello che oggi è considerato il territorio di Boko Haram: il gruppo, infatti, nasce e si sviluppa – non per caso, come vedremo – nell’estremo Nordest della Nigeria, un’ampia area all’interno di quella regione settentrionale povera e a prevalenza musulmana che tradizionalmente si oppone a un Sud più ricco e abitato soprattutto da cristiani.
A partire dal 2002, anno della sua nascita, e per circa sette anni, la setta fondata dal predicatore Mohammed Yusuf si rende protagonista di una netta opposizione al potere costituito, inscenando manifestazioni che degenerano in disordini, scontri, violenti attacchi alle forze di polizia e all’esercito. Questa formazione radicale, che assume da subito una forte valenza religiosa, si scaglia contro la corruzione delle autorità e della politica, così come contro il lassismo dei costumi, criticando duramente quella che ritengono un’applicazione troppo blanda dei dettami della religione islamica.
Nel febbraio del 2006, per esempio, ha un ruolo importante in una sommossa scoppiata a Maiduguri, capitale dello stato di Borno e quartier generale del gruppo, in seguito alla pubblicazione delle caricature di Maometto sul giornale danese Jyllands-Posten: una manifestazione inizialmente pacifica da cui però scaturiscono scontri violenti, nei quali restano uccise decine di persone e vengono bruciate una dozzina di chiese. Durante gli anni, a proteste e contestazioni si affiancano sempre più spesso veri e propri assalti a sedi e convogli delle forze dell’ordine. Contemporaneamente si vanno definendo i tratti «settari» del gruppo, che si isola dalla società e istituisce le proprie scuole.
Un punto di svolta fondamentale è costituito dai violenti scontri del luglio 2009, al termine dei quali Mohammed Yusuf viene arrestato e poi ucciso in circostanze poco chiare. Da qui prende corpo la seconda fase della storia di Boko Haram, ed è un vero e proprio cambiamento radicale. Sotto la guida del nuovo leader, Abubakar Shekau, il gruppo muta totalmente strategia: non più semplici sommosse, agguati alla polizia, proteste di strada e contestazioni violente, bensì azioni armate e attacchi sempre più sofisticati e sanguinosi contro obiettivi cristiani ma anche musulmani, fino a coinvolgere semplici cittadini.
L’operazione che per prima testimonia questo cambio di passo è la clamorosa evasione in massa dal carcere di Bauchi, nello stato omonimo. L’attacco portato nel settembre del 2010 da uomini armati di AK-47 aveva come obiettivo iniziale la liberazione dei 150 prigionieri affiliati a Boko Haram rinchiusi nel penitenziario, ma il commando arriva addirittura a far fuggire ben 732 dei 762 detenuti. Anche in questo caso la reazione della polizia e delle autorità è tardiva e confusa: solo dopo un paio di giorni si riesce a predisporre un sistema di posti di blocco con lo scopo di impedire ai fuggiaschi di lasciare lo stato di Bauchi. Polizia ed esercito iniziano a presidiare ingressi e uscite dalle città e dai villaggi quando ormai è troppo tardi, consentendo così di fatto ai militanti fuggiti di andare a ingrossare le file dei combattenti.
La nuova strategia di Boko Haram, che nell’assalto al carcere ha dimostrato la sua accresciuta potenzialità, implica abilità nuove: non solo usare armi automatiche, ma essere in grado di procurare, trasportare e utilizzare materiali esplosivi, approntare autobombe, studiare luoghi e individuare personaggi che possano diventare potenziali obiettivi.
La prova generale è costituita dagli attentati del Natale 2010 che sconvolgono Maiduguri e Jos. Nella capitale dello stato di Plateau vengono piazzate diverse cariche esplosive programmate per detonare la sera del 24 dicembre durante le celebrazioni religiose e tra le bancarelle di mercati affollati da acquirenti in cerca degli ultimi regali. Immediatamente nella città scoppiano scontri tra cristiani e musulmani. A Maiduguri, uomini organizzati in commando assaltano alcune chiese durante le funzioni della vigilia, sparando e lanciando ordigni. Tutto il Nord della Nigeria precipita in un caos generalizzato che le autorità faticano a contenere e il cui effetto sono decine di morti e numerosi edifici di culto cristiani distrutti dagli attentati o dagli attacchi di gruppi armati di bastoni, coltelli, machete.
La situazione va quasi fuori controllo, tanto che alcune ambasciate richiamano il proprio personale e mettono in allerta i propri cittadini residenti negli stati settentrionali. Boko Haram rivendica gli attentati, imponendosi all’attenzione della nazione con la sua nuova strategia: per la prima volta ha colpito al di fuori dell’usuale territorio nordorientale e per la prima volta ha fatto uso di bombe a Jos, città della cosiddetta middle-belt – ossia quella fascia di territorio che fa da cerniera tra Nord e Sud in cui cristiani e musulmani sono sostanzialmente in pari numero –, che pure da tempo conosce gli scontri etnico-religiosi.
Da quel momento in avanti gli ordigni contro le chiese diventano una sorta di firma di Boko Haram. Aumenta la frequenza degli attacchi e soprattutto si fa sempre più massiccio l’uso di esplosivo, che si rivela l’arma preferita del gruppo. Nel 2011 saltano in aria decine di chiese nel Nordest del paese: a Maiduguri, a Damaturu, a Jos, a Bauchi. Ma la violenza comincia a rivolgersi anche verso quella parte di islam che non è sulla stessa linea di Shekau e dei suoi seguaci: nel giugno del 2011, a Biu, Ibrahim Birkuti, un eminente e popolare religioso di una setta rivale che aveva espresso critiche nei confronti di Boko Haram, è freddato da colpi d’arma da fuoco esplosi da due uomini in motocicletta.
Non è il primo, e non sarà l’ultimo. Senza dimenticare la punizione per le pratiche in evidente contrasto con le rigide norme islamiche: il 26 giugno venticinque persone restano uccise nell’attentato a una birreria all’aperto di Maiduguri. Secondo Human Rights Watch, in tutto il 2011 i morti per attentati e attacchi sono poco meno di mille: una vera e propria guerra. Ma è gravissima anche la situazione delle centinaia di feriti, che spesso restano praticamente abbandonati a se stessi, vista l’inconsistenza del sistema sanitario nigeriano. Nel mirino della setta, uomini delle forze dell’ordine, soldati, funzionari pubblici, avvocati, giornalisti, religiosi cristiani e musulmani e anche semplici cittadini.
È sempre nello stesso anno, precisamente il 16 giugno, che Boko Haram mette a segno il primo attacco suicida: un kamikaze alla guida di un’autobomba si fa esplodere nel parcheggio del quartier generale della polizia nella capitale Abuja. Una tecnica che poi diverrà abituale: l’anno seguente gli attentati suicidi messi in atto dalla setta saranno una ventina. I tempi in cui Boko Haram combatteva solo con machete e bastoni sono ormai lontani.
E proprio un kamikaze è protagonista di una delle azioni più eclatanti: intorno alle undici del mattino del 26 agosto 2011 il ventisettenne Mohamed Abul Barra riesce a superare le barriere di sicurezza poste davanti al sorvegliatissimo quartier generale dell’Onu ad Abuja, scagliandosi con la sua autobomba contro l’area in cui si trova la reception, proprio nel punto in cui le tre ali dell’edificio si uniscono. La vettura sfonda le vetrate dell’atrio ed esplode. Nel crollo e nell’incendio che seguono, ventitré persone restano uccise e molte decine ferite. È con questo attacco che Boko Haram entra a pieno titolo nella galassia del terrorismo internazionale.
L’ultimo giorno dell’anno, dopo un nuovo Natale di sangue, il presidente Goodluck Jonathan – uomo del Sud, cristiano, eletto nell’aprile di quell’anno ma di fatto al governo già dal 2010 per la malattia del suo predecessore – dichiara lo stato di emergenza in alcune zone del Nord che interessano gli stati di Borno, Yobe, Niger e Plateau e decreta la chiusura temporanea delle frontiere con Ciad, Niger e Camerun. Così spiega il provvedimento alla popola...