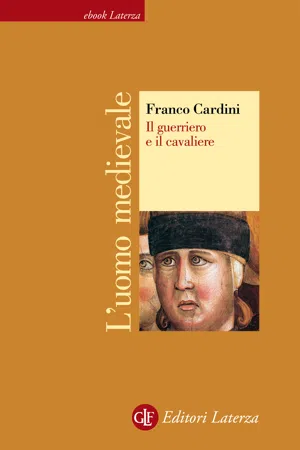Il guerriero e il cavaliere
È stata senza dubbio una grande rivoluzione quella che, nel corso del X secolo, ha praticamente eliminato la vecchia distinzione della società cristiana in liberi e servi per sostituire a tale antica dicotomia – ben più antica, come sappiamo, delle civiltà ebraica, romana e germanica dalle quali l’Occidente traeva la sua origine culturale – quella più pratica e significativa in milites e rustici, che implicava l’individuazione di un confine preciso non già nel campo normativo-istituzionale, bensì in quello delle funzioni sociali e dei generi di vita, tra coloro (i pochi, in fondo) che avevano il privilegio di portare le armi e di combattere ed erano per questo normalmente esenti dal sopportare il carico delle imposizioni bannali e coloro (la stragrande maggioranza dei laici) dai quali ci si aspettava un impegno nel mondo della produzione tale da soddisfare alle loro stesse peraltro limitate esigenze e a quelle, un po’ più pesanti e sofisticate, di quanti dei frutti del loro lavoro avevano il privilegio di poter vivere.
Il mondo del X secolo (e, già da prima, quello della metà del IX) è duro e pericoloso; la pura sopravvivenza vi costituisce da sola una preoccupazione costante e un assillante impegno. Le incursioni vichinghe, magiare, saracene razziano le coste e tormentano l’entroterra della compagine euro-mediterranea orientale; ad esse si accompagnano – e, passate che esse saranno, si sostituiranno – le continue lotte all’interno di aristocrazie rapaci e violente, cristianizzate solo superficialmente anche se fiere delle fondazioni monastiche da loro promosse e superbe del ricco bottino di reliquie radunate un po’ da ogni dove e ostentate, venerate e onorate come oggetti carichi di un magico potere. L’Europa del tempo fiorisce di castelli (alcune regioni, come la Castiglia, ne trarranno addirittura il nome), insediamenti fortificati dove ci si rifugia stretti gli uni agli altri mentre fuori si scatena la furia dei barbari e dei «tiranni»; eppure, sono in gran parte proprio le scomode e precarie condizioni del viver castellano che reinsegnano alle genti d’Europa la pratica dell’autodifesa e dell’autogoverno.
La durezza dei tempi determinò d’altronde il riemergere di costanti e di esigenze profonde: per esempio la scansione della società nei tre livelli funzionali degli oratores, dei bellatores e dei laboratores. Ormai il pregare, il combattere e la fatica dei campi erano considerati, sia pure a un diverso livello di rispettiva dignità, come i tre fondamentali aspetti del vivere civile, i tre pilastri del mondo cristiano. Gli studi di Georges Dumézil hanno splendidamente e definitivamente confermato che questa tripartizione funzionale ha lontane scaturigini nella cultura indoeuropea; ma a noi interessa qui non rintracciare delle costanti, bensì individuare lo specifico medievale di un processo secolare, anzi millenario, di apprezzamento della guerra e del guerriero che, in una lunga fase d’insicurezza, ha consentito tra X e XII secolo alla società cristiana – gli ideali più elevati della quale sono e restano, nonostante tutto, ideali di pace – di elaborare un complesso etico-teologico teso alla sacralizzazione della pratica militare.
Tutto può quindi cominciare di qui: dal fosco periodo delle incursioni barbariche e della cosiddetta «anarchia feudale» compreso tra fine IX e XI secolo; da questa parola, miles, che poco a poco sostituisce tutti gli altri termini indicanti il guerriero (sicarius, buccellarius, gladiator) fino ad allora usate a qualificare gli armati riuniti in comitive strette attorno a un dominus, a un principe. Già il vecchio Tacito aveva descritto il comitatus germanico, che conosce nell’alto Medioevo molteplici varianti dalla trustis franca alla družina russa: all’interno di esso si era elaborata nel tempo un’etica fatta di coraggio, di fedeltà all’amicizia, di affetto verso il principe considerato non tanto il dominus quanto piuttosto il senior, il capobranco, il «vecchio» dal quale ci si aspettano doni e protezione. Era nell’ambito di questi Männerdünde, di queste «società di uomini», che si erano conservati i rituali iniziatici di ammissione alla cerchia di quanti erano ritenuti degni di portare le armi: rudi prove di forza e di sopportazione del dolore, ferite rituali e prove di destrezza ai limiti di quel che la Chiesa cristiana avrebbe potuto considerare lecito. Un tempo – ancora una volta, spetta a Tacito l’avercelo rammentato – tutti i giovani guerrieri delle selve e delle steppe avevano dovuto affrontare prove di quel genere: ma a partire dall’VIII secolo la tendenza alla specializzazione del mestiere delle armi e quindi alla generale demilitarizzazione delle società romano-barbariche (resa necessaria dal crescente uso del cavallo in guerra e dall’appesantirsi nonché dal lievitare sul piano dei costi dell’equipaggiamento offensivo e difensivo richiesto al guerriero, come i Capitularia carolingi dimostrano) aveva fatto sì che soltanto fra quei gruppi ormai d’élite che erano le comitive guerriere strette attorno ai principi aristocratici si mantenessero le antiche tradizioni; e la consegna solenne delle armi era divenuta addirittura patrimonio dei rituali che segnavano l’accesso dei giovani principi al mondo del potere. Queste le basi della cerimonia che noi siamo abituati a definire «addobbamento» e che, insieme con il combattimento a cavallo e i segni esteriori distintivi di tali condizioni e genere di vita, avrebbero, appunto, contribuito al definirsi del cavaliere.
Il professionista della guerra tra X e XI secolo è pertanto, ordinariamente, il membro della comitiva guidata da un grande aristocratico o chiamata a presidiare la sua dimora; può per questo detenere o no dal suo senior dei beni in possesso a titolo vassallatico oppure armi, cavalli e vesti da considerarsi una sorta di stipendio; può vivere solitamente presso il senior oppure condurre la propria esistenza su terre proprie o concessegli; può essere di condizione personale libera o servile, appartenere cioè – in questo secondo caso – al gruppo dei cosiddetti ministeriales.
Sotto il profilo propriamente militare, ormai la critica ha abbandonato le sponde sia dell’evoluzionismo, sia del determinismo. Nessuno crede più alla tesi d’una cavalleria nata «naturalmente» nel corso dell’VIII secolo, dal bisogno di contrastare le rapide incursioni degli Arabi di Spagna; e quasi nessuno si ostina più a sostenere che essa sia il necessario prodotto dell’invenzione di un oggetto, la staffa, che avrebbe consentito una maggiore stabilità in sella e quindi lo sviluppo dell’attacco a fondo del cavaliere lanciato al galoppo e il cui urto possente con la lancia tenuta stretta sotto l’ascella avrebbe travolto qualunque ostacolo. La nostra attenzione è semmai volta, oggi, a cogliere il crescente prestigio del combattente a cavallo attraverso la considerazione del permanere di un complesso sacrale connesso con quell’animale nelle culture delle steppe; e ad approfondire il legame tra i costi sempre più alti della guerra e dell’equipaggiamento militare (cavallo stesso, armi di ferro, giaccone imbottito e rinforzato detto bruina) da una parte, e il definirsi della gerarchia delle dipendenze vassallatiche e al tempo stesso il dilatarsi della distanza socio-economica e socio-giuridica tra armati e inermi dall’altra.
Lo scontro fra i grandi detentori di signorie bannali, ciascuno dotato di seguaci armati, diviene il dato caratteristico della vita del X-XI secolo, cioè del lungo periodo corrispondente al polverizzarsi dei pubblici poteri e alla cosiddetta «anarchia feudale». È questo il tempo nel quale gli armati sono anzitutto tyranni, praedones; e le loro violenze nei confronti degli indifesi e in genere di tutti quelli che la Chiesa definisce pauperes (i chierici stessi, le vedove, gli orfani, in genere gli incapaci di difendersi e gli sprovvisti di qualunque forma di tutela) sono sempre più spesso denunziate, specie nelle fonti vescovili.
Furono appunto i capi di certe diocesi, ben presto affiancati da aristocratici e da milites che essi erano riusciti a convertire al loro programma e da laici di condizione anche subalterna preoccupati per l’endemicità di uno stato di violenza che impediva il decollo o la ripresa dei traffici e della vita economica, ad avviare tra la fine del X e i primi dell’XI secolo il movimento della pax e della tregua Dei: santuari, ospizi, mercati, guadi, strade, furono posti sotto una speciale tutela (la pax, appunto) sulla base della quale chiunque commettesse in quei luoghi atti di violenza era passibile di scomunica; lo stesso provvedimento fu varato a tutela di tutte quelle categorie di persone che per la loro debolezza venivano considerate pauperes (una parola dal senso tutt’altro che esclusivamente economico); e si giunse infine a stabilire che gli atti di guerra, già proibiti dalla pax in certi luoghi e nei confronti di certe categorie, erano altresì vietati in precisi giorni della settimana. Se l’uccidere era sempre e comunque peccato mortale, la tregua Dei faceva sì che il commettere assassinio tra il pomeriggio del giovedì e quello della domenica comportasse addirittura la scomunica. In questo modo, pur senza proibire tout court la guerra (un provvedimento che sarebbe stato impensabile, in una società egemonizzata da guerrieri), la si limitava il più possibile piegandola alle esigenze della generale ripresa della vita sociale ed economica e a quelle della riforma della Chiesa che appunto in quei medesimi anni si andava attuando nel contesto di un vasto movimento avviato dalla congregazione monastica facente capo all’abbazia di Cluny in Borgogna; riforma che puntava alla cosiddetta libertas Ecclesiae, cioè all’eliminazione delle pesanti ipoteche poste da parte dei poteri laici sulle istituzioni ecclesiastiche.
D’altra parte il programma del movimento di pax e tregua Dei, che si sviluppava attraverso una serie di concilii locali ai quali partecipavano, regione per regione, il clero ma anche i laici dell’area interessata, non avrebbe avuto la possibilità di espandersi e di affermarsi (al pari del resto di quanto accadeva ad esempio in Italia con i movimenti che anche a mano armata appoggiavano il programm...