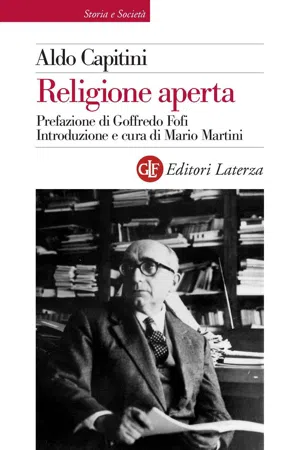XI. L’umanismo
Insufficienza del «sacro» tradizionale e del laicismo. Passaggio dai punti raggiunti dal laicismo a punti religiosi.
Trascendenza, immanenza, trascendimento. Caratteri dello storicismo.
L’atto religioso, intimamente aperto ad altro. L’esistenzialismo.
Il materialismo rivoluzionario e l’aggiunta religiosa post-umanistica.
Il laicismo La religione medioevale distinse nettamente il sacro e il mondo; il primo custodito ed emanante dall’istituzione ecclesiastica (con dogmi, sacramenti, sacerdoti), il secondo consistente nella libera esplicazione della vita terrena da parte dei laici. L’Umanesimo affermò il valore della vita terrena, e la sua capacità di articolarsi e svilupparsi fino ad elevare le proprie forme ad una universalità che trascende il destino della specie umana, ed è valida cosmicamente per tutta la realtà, dove che sia. Il laicismo fu anche atteggiamento polemico della concezione umanistica contro l’istituzionalismo ecclesiastico, affermante la propria autorità assoluta.
Una vita religiosa aperta sorge avendo, da un lato, i religiosi tradizionali, e, dall’altro, i laici umanisti. Riguardo al valevole che c’è in loro, la vita religiosa è piena di rispetto e di riconoscenza. I primi cercano di salvare la differenza tra ciò che è divino, sacro, e il mondo com’è; sanno che la realtà attuale è insufficiente, ed hanno fede nel suo mutamento, nella liberazione, in Dio che è proprio il simbolo, l’autore, la presenza di questa liberazione; i secondi portano la libertà contro ogni dogmatismo e oppressione di uomini su altri, affermano che nessuno ha il privilegio di ciò che è spirituale, perché questo è alla portata di tutti, della loro libera e attiva coscienza realizzante valori; ed hanno fede nel progressivo sviluppo del mondo.
Ma entrambi sono insufficienti: i primi, perché dànno al divino e al sacro forme autoritarie, istituzionali, come se essi consistessero in una chiesa o associazione, con un capo che è «la Santità di Nostro Signore»; e questa associazione impone come verità avvenimenti che sono leggende, princìpi che sono inaccettabili come la differenza delle classi, l’ubbidienza ai potenti, la persecuzione dell’eretico, la dannazione eterna del peccatore. I secondi, perché accettano che la realtà si realizzi così come ora; che nel mondo ci sia il male e la morte; e, pur col programma umanistico e prometeico di umanizzare il mondo, la realizzazione è puramente scientifica e politica, dichiarando che l’uomo non può cercare altro. Riguardo a queste due insufficienze una nuova vita religiosa sorge come un più largo orizzonte, «a guisa d’orizzonte che rischiari».
Per i primi, diceva già Gesù Cristo che corrono il pericolo di chiudere «il regno dei cieli in faccia alla gente: voi non vi entrate e non lasciate che vi entrino quelli che vengono ad esso» (Matteo, XXIII, 13); e noi non possiamo che metterci accanto a loro con la massima amorevolezza, mostrando: 1, che ciò che essi hanno di valevole deve essere portato a nuova vita; 2, che è loro necessaria un’interna autocritica verso alcuni elementi che essi ereditano come si ereditano malattie, ma che debbono guarirsene. C’è un atto religioso che possiamo compiere loro e noi, che ci accomuna, che dà origine ad una nuova vita religiosa: questo atto religioso, comune, aperto, che tutto il passato riassume e supera e a tutto l’avvenire dà inizio, sta nel vivere nello stesso tempo, drammaticamente e serenamente, tre realtà:
A) la realtà attuale e passata, quella che si vede con gli occhi e si tocca con le mani, che dà i colpi, la morte, schiaccia o conduce (sembra) alla fine i singoli esseri, realtà che è potenza ed economicamente sfruttamento;
B) la realtà di tutti gli esseri, che noi viviamo e sentiamo e riconosciamo non accettando la realtà precedente, sottraendo col nostro intimo appassionato ogni essere alla morte, dicendo: «no, non è vero, tu non finisci, non sei finito, siamo insieme»;
C) la realtà liberata dai limiti della prima, dal peccato, dal dolore, dalla morte, realtà a cui ci apriamo dando la disdetta alla prima, riconoscendo che essa non ha nessun diritto di durare in eterno; e appena pensato questo, sentiamo che essa sta per finire, e intanto godiamo la realtà di tutti come preparazione alla realtà liberata; anzi di questa ci vengono preannunci.
Vivere queste tre realtà nel loro nodo è religione; la religione è «apertura ad una realtà liberata per tutti».
Per i secondi: 1, noi accettiamo di vivere in una premessa di libertà, siamo disposti a riconoscerla in altri e grati all’umanismo e al laicismo che l’hanno tanto svolta e fondata e portata a un risalto che le religioni e le società tradizionali, autoritarie, non consentivano; 2, ma facciamo osservare fermamente che, proprio per svolgersi, la libertà guadagna dall’aggiunta di una nuova vita religiosa. La libertà che si accontenta di sé non è più libertà, e finisce con essere rinunciataria: la libertà deve essere inquieta, scontenta del suo stato presente per accrescersi, per entrare là dove non è entrata. Altrimenti nel Risorgimento gl’italiani si sarebbero accontentati delle libertà che avevano sotto il Papa, sotto il Granduca di Toscana (e ne avevano); e nell’Impero romano i cittadini si sarebbero accontentati di quella libertà senza fare un passo avanti per entrare nel Regno di cui Gesù Cristo aveva parlato.
Quindi gli umanisti e laici se non vogliono prendere una posizione di difesa semplicemente di ciò che è raggiunto, difesa a tutti i costi e disperata, e spesso amareggiata perché costretta a tanti compromessi; se non vogliono essere i Marco Aurelio o i Giuliano l’Apostata, o gli stoici che incassano i colpi della sorte, o gli epicurei che cercano di compensarli con le consolazioni dell’amicizia e della tranquillità riparata dai venti; debbono fare almeno queste tre cose:
A) allargare il loro senso di libertà fino a non accettare che la realtà, la società, l’umanità attuale abbia il male sempre accanto e in sé, ammettendo invece la possibilità di un realizzarsi superiore, salendo dal grado della libertà che si attua nel mondo che rimane com’è nelle sue strutture, al grado della liberazione che si attua in un mondo che assume strutture migliori;
B) aprirsi alla solidarietà e compresenza con tutti; infatti se il laico ha sostituito alla concezione del proprio intimo che aveva il religioso tradizionale (la coscienza unita a Dio attraverso la rivelazione custodita da un’istituzione privilegiata) la concezione della coscienza unita allo Spirito che è in tutti nel mondo della Storia, egli deve fare un passo avanti per meglio fondare questa apertura sociale religiosa, perché non gli accada di sentire soltanto la propria coscienza come è nella civiltà individualistica;
C) ritrovare che tutti i princìpi e tutti i termini laici, che l’umanismo aveva liberato dal vecchio significato autoritario e chiuso tradizionale, hanno acquistato un contenuto di nuova vita religiosa. Eccone gli esempi:
a) parrocchia omogenea, liberi gruppi e individui, centro religioso aperto;
b) dogmatismo e inquisizione, tolleranza, apertura con interesse ad accettare elementi dagli altri per la costruzione quotidiana della vita religiosa;
c) imposizione di un credo solo, lasciar vivere e pensare, libera aggiunta della propria persuasione religiosa;
d) chiesa dei salvati unita dalla stessa fede e stessi sacramenti, associazioni e istituzioni come formazioni storiche, realtà intima comprendente tutti anche gli sfiniti e i morti;
e) guerra autorizzata se fatta dall’Impero o dai re o decisa in nome di Dio; pace attraverso rapporti giuridici tra gli Stati come sono attualmente; federalismo universale nonviolento dal basso dopo i blocchi attuali;
f) valore come concesso da Dio; valore come opera ed elevazione umana; valore come indizio di una realtà liberata.
Questi non sono che esempi; ognuno può accrescerli, posto che abbia il pensiero generatore che è: non accettare il dualismo spaziale di cielo e di terra, di istituzione sacra e laici, di autorità e libertà; portarsi dalla parte della libertà dal basso, della terra, del laicismo, della materialità economica, ma consumarne dal di dentro gli elementi mondani e insufficienti in modo da arrivare ad una liberazione.
Non tornare a prima di Gesù Cristo Passare per il laicismo può aver servito ad acquistare il valore della libertà e di tutti, per risalire poi da esso ponendo entro lo stesso laicismo centri superatori di quello che di naturalistico, umanistico, prometeico c’era nella posizione laica, polemica verso il Medioevo, ma col pericolo di tornare a un mondo greco-romano, prima della nascita di Gesù Cristo. Se il laico umanista ha scosso da sé le leggende, i dogmi e l’autorità sacerdotale per riaffermare una vita semplicemente mondana, e chiude gli occhi davanti al problema che ci pongono il male e la morte, torniamo indietro, e quei miti e dogmi restano espressione di un’esigenza che è messa in disparte e ignorata (per lo meno, finché non càpita il dolore e la morte), ma non soddisfatta e in modo migliore che con quei miti e dogmi, come fa una religione aperta. Tra una religione tradizionale vissuta profondamente e un laicismo angusto e superficiale, siamo più avanti qui solo nelle formulazioni, ma non nella sostanza. E siccome non si può tornare alla vecchia posizione, non c’è che da fare un passo in avanti e portarsi ad una posizione post-umanistica. Perciò, come dicevo, il pensiero e il movimento generatore è questo, in tre tempi: 1, trascendenze autoritarie; 2, rivendicazione della libertà e della creatività da parte dell’uomo; 3, apertura religiosa dall’uomo verso la consumazione degli elementi mondani e dei limiti del male e della morte, Dio tutto in tutti. Nel 1° è la trascendenza alle spalle, la Causa, l’Autorità, il Padrone che non spiega, il Proprietario che possiede dall’eternità; nel 2° è l’immanenza, l’accettazione del mondo nel quale è tutto il realizzarsi dell’uomo; nel 3° è il trascendimento di questa realtà insufficiente, il costituirsi di un realizzarsi liberato, l’Unità amore di tutti, nessuno distrutto e tutti liberi e cooperanti nella compresenza. Il laicismo sta in mezzo, e contro l’Autorità ha affermato la libertà, contro la priorità della Proprietà la priorità del lavoro, contro la Causa come valore la novità dell’effetto, contro il Padre che a guisa di antico patriarca dà al figlio beni, dèi, sposa e benedizione, il figlio che si dà, con la sua iniziativa, propri beni, proprie idee e propria sposa, facendo un passo innovatore sulla tradizione. Oggi siamo in questo laicismo, e qualche cosa tutti gli dobbiamo (basti pensare alle libertà civili e alla scuola), ma lo stiamo anche oltrepassando; e questo è il lavoro religioso, che è un oltrepassamento che ne conferma il positivo di apertura e vi aggiunge un modo più profondo. La prova può esserne data in ogni campo, basti prendere queste due: una nel modo di intendere il rapporto tra gli uomini, nella religione tradizionale attraverso il Corpo mistico formato dai battezzati e credenti (e gli altri? non è questa una prepotenza autoritaria?), nel laicismo attraverso la libertà di tutti uniti nella società civile e nello Stato, nella religione aperta attraverso la realtà di tutti che è compresenza aperta e realtà liberata che comprenda tutti. Un’altra prova è nel modo d’intendere il destino dell’uomo: ricevere il giudizio divino secondo la religione tradizionale; dare la propria opera nella storia finché si è vivi, secondo il laicismo; cooperare in eterno alla produzione dei valori.
Lo storicismo Una forma elevata di umanismo è lo storicismo. Per esso la realtà è svolgimento, storia vivente (altra cosa è la storia scritta, la storiografia), e tutti gli esseri, in quanto attività (lo spirito non è una sostanza o materia più sottile, ma semplicemente atto), costituiscono, svolgono, portano avanti questa realtà o storia vivente, che è unica, infinita, l’Uno-Tutto. La riduzione della realtà a storia fu operata massimamente, entro il Romanticismo, dallo Hegel, l’Aristotele moderno; ma io per esaminare alcuni elementi dello. storicismo in rapporto al problema religioso attuale, non mi tratterrò sullo Hegel, bensì su Benedetto Croce, il filosofo italiano dello «storicismo assoluto». Ci troveremo, con grande chiarezza, elementi di quell’operare intermedio che ho detto del laicismo.
Il Croce riassume la civiltà umanistica che uscì dal Medioevo, civiltà greco-europea, tesa alla creazione dei valori, che sono non solo il Bello, il Vero, il Bene, ma anche l’Utile o Vitalità, quel benessere e quella forza di essere nel mondo, che è anch’essa un valore, che noi (con tutta la natura) realizziamo appunto per essere vita e possibilità anche degli altri valori. Questi valori sono le molle della creazione di nuova vita, di nuova storia, cioè di nuove opere; essi sono «potenze del fare», ma ci servono anche per «conoscere», perché quando noi conosciamo un’opera, cioè un atto, lo giudichiamo se è bello o no, se è vero o no, se è utile o no, se è bene o no. Questo è il realizzarsi dello Spirito nella storia vivente, che comprende tutti e tutto, e fuori non c’è nulla. Contano le opere, ciò che si fa, gl’individui non prendono nulla per sé. E la storia vivente ha una ragione in sé, essa realizza, mediante quei valori, la Libertà, la creatività dello Spirito che è «infinita possibilità trapassante in infinita attualità», opera che non è terminata né terminerà mai, infinito progresso in cui sta il mistero, che è appunto l’infinità (con sempre nuovi problemi e oscurità da vincere) di questa evoluzione, su cui il male non può prevalere, perché anzi lo spirito è vittoria sempre rinnovantesi sul male. Qui è il Dio del Croce, il Dio che è in tutti e per tutti: «pensando e operando non pensiamo se non Lui, non speriamo se non in Lui». Dio, dunque, è in rapporto con tutti quando pensano e operano realizzando valori, è il Valore stesso, senza di cui non esiste nulla e non si muove foglia: collocare Dio fuori di questi rapporti intrinseci al pensare e all’operare di tutti, è, per il Croce, farne un mito, una nostra astrazione, una personificazione, una rappresentazione.
Né, secondo il Croce, creda l’individuo di poter fare un’altra astrazione, quella di ritenersi immortale nella sua individualità in sé. Perché se l’individualità è vista nell’avere un corpo vivente, che si assicura la vitalità finché può, è evidente che questa parte di noi è un semplice strumento che serve alle superiori attuazioni e in esse si consuma; e se l’individualità è nel realizzare valori, lì appunto l’individuo si fa atto, opera, opere, e le opere vivono, contributo di tutti, nel Tutto, e lì sono immortali. «La vita eterna non è uno stato da raggiungere in un di là o da vanamente sospirare, ma uno stato che si possiede e si sperimenta in ogni atto con cui pensiamo il vero, diamo forma al bello, operiamo il bene. In ciascuno di questi atti noi sentiamo di staccarci dal perituro e mortale e d’innalzarci verso l’imperituro, verso l’eterno e di unirci a Dio». Questo stato il Croce non l’intende come dualisticamente staccato dalla storia e dal mondo, come un mistico sopramondo: l’immortale vive attraverso il mortale, l’infinito attraverso il finito, la serenità attraverso il dramma dell’operare, del compiere atti di vita, e anche il morire è atto di vita.
Si capisce perciò che quello del Croce è un laicismo, che se nega le pretese dell’ecclesiasticismo, di qualsiasi ecclesiasticismo e autoritarismo istituzionale, salva e assimila ciò che una religione porta a sussidio di un’etica della libertà. Da cui la sua affermazione (già un tempo nella Filosofia della pratica e molto più tardi in un noto saggio) che non possiamo non dirci cristiani, per il risalto che la rivoluzione cristiana conferì a ciò che è intimo proprio della coscienza morale, per l’amore che suscitò verso le creature e verso Dio, Dio d’amore che «non sta distaccato dall’uomo; e verso l’uomo discende, e nel quale tutti siamo, viviamo e ci moviamo». Ma sùbito soggiunge (e si vede chiaro qual è il suo laicismo) che se tale cristianesimo interruppe il suo svolgersi come ricerca e pensiero e si fece fede, azione pratica, istituzione, il corso fu ripreso e portato oltre nell’epoca moderna, finché il Dio cristiano fu chiamato Spirito (ma con problemi simili e simili travagli) e gli uomini possono essere cristiani anche fuori delle chiese, «e tanto più intensamente cristiani perché liberi». Da qui si vede come egli assume il cristianesimo ad un laicismo aperto, dell’operare divino-umano nel mondo, secondo lo storicismo hegeliano.
Quando il Croce ha cercato un posto per la religione tra le varie attività dello spirito, gli è parso che non ve ne fosse uno speciale e distinto, oltre i quattro valori sopra detti: quale valore è peculiare della religione? Ma Dio si realizza nei quattro valori dello Spirito, appunto, ed è la loro unità e la loro distinzione, il loro dinamismo; – del resto, già lo Hegel aveva detto che Dio «è la cosa più reale e la sola veramente reale», e il Croce che non esiste che l’«interno» –: possiamo farne un valore distinto? E gli altri sono fuori di Dio?! Gli è sembrato perciò che la religione, non essendo una forma speciale dello spirito, prenda elementi da tutte; e che in quanto è fede, si ritrovi in ogni nostro agire, quando ci fermiamo e ci fondiamo su ciò che abbiamo pensato per passare all’azione. Così per ciò che la religione è mito, cioè una rappresentazione presa e sostenuta per verità, gli è sembrato che il lavoro della civiltà sia appunto di porre di tali miti, sempre nuovi e sempre più alti, ma anche di sorpassarli e di schiarirli in verità pure, senza più la veste autoritaria e acritica che essi assumono trapassando in dogmi. E quanto più nel Croce si svolgeva il proposito di intervento ed impegno, tanto più egli tendeva a vedere nella religione un altro aspetto, più largo, quello di essere una concezione della realtà e della vita, con conseguenti impegni pratici. La religione che il Croce avvertiva in formazione, non può essere quindi se non quella della libertà creatrice nei valori, sempre travagliantesi e sempre aperta a intendere tutti, anche quelli del campo avverso, perché, dice il Croce, se la Chiesa fa politica (per sostenersi, è la sua logica, ma quella è politica), la religione del pensiero e della libertà, che non fa politica nel campo della verità e della vita morale, saluta come fratelli anche i cattolici in quanto lavorano per un’opera – quella della verità e della vita morale – che è la sola che accomuna veramente gli uomini, toccati tutti, dice il Croce, dalla «Grazia», non quella che prende aspetto di «odiosa preferenza e prepotenza» ma quella «dovuta a tutti gli uomini per il loro carattere stesso di uomini».
Questa la «religione» del Croce, quando egli deve professarne una, impegnarsi ad una nel momento e in contrasto con le altre invocarne una, come egli ha fatto più volte, e per esempio nel 1917 segnalando che certe tendenze artistiche indicavano una malattia, che sarebbe scemata o quasi scomparsa «con l’afforzarsi nell’anima europea di una nuova fede, cogliendo alfine il frutto di tante angosce sostenute, ecc.»; e, per altro esempio, nel 1948: la crisi presente nel mondo è «la crisi di una religione da restaurare o da ravvivare o da riformare, e a soccorrere ad essa non bastano soli politici e guerrieri, ma ci vogliono i geni religiosi e apostolici». Questa è l’affermazione pubblica e impegnata del Croce, per la religione che deve, sia pure con qualche mito (disse una volta) rafforzare il senso che l’uomo, con il pensiero, con la coscienza morale, con la bellezza, vincenti la parte più bassa dello spirito, si congiunge con il principio stesso della realtà e della verità.
Questo senso sereno del possesso positivo del valore è fondamentale nel Croce, tanto che in questo si differenzia dallo Hegel e da quel correre di dialettiche opposizioni verso uno sfocio supremo: serenità perché sempre si realizza un valore, anche se il Croce qui introduce un dislivello, un qualche cosa di più puro: la purificazione nel cogliere il Bello, la purificazione nel cogliere il Vero. Se quella della libertà era la religione pubblica del Croce, per azione di antifascismo e di guida europea, la Poesia e la Storia erano le sue dee private; e da qui la fondazione della loro purezza (così il Croce vive il culto), l’isolarle da ciò che è letteratura per un verso, e per l’altro conoscenza tecnica; e perciò l’augurare una religione che infonda la fede in questa purezza, nel contatto con Dio (che non può essere che contatto attivo) attraverso il Bello, il Vero, il Bene. E questo terzo operare ha, pur nel suo impegno e mossa al...