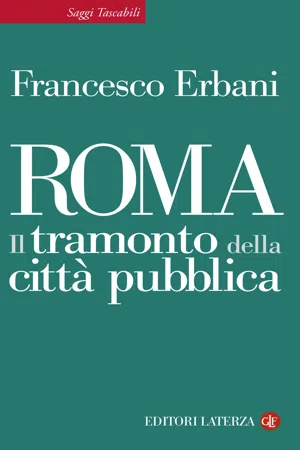1. Le porte di Roma
Un tempo, non molto tempo fa, cinque, sei anni al massimo, la porta di Roma erano i palazzi di Fidene e di Castel Giubileo. Alti parallelepipedi in verticale, lunghi parallelepipedi in orizzontale. Svettavano sulla collina che sovrasta il Grande raccordo anulare, proprio nel punto in cui la bretella dell’autostrada proveniente da Milano s’immette nell’anello circolare che scorre intorno alla città. Dalla cresta di quest’altura, in età imperiale e per tutto il Medioevo, si dominavano le vie commerciali che collegavano l’Etruria, la Sabina e l’Italia meridionale. Senza trasmettere nulla di bellicoso, anche i palazzi di Fidene e di Castel Giubileo sembravano però torri di guardia. Accoglievano chi arrivava in macchina come un simbolico cartello di indicazioni stradali, preannunciandogli che quella in cui stavano entrando non era una città come le altre. Anticipavano un concetto di grandezza. Nella loro proletaria monumentalità racchiudevano l’idea che la storia avesse distribuito magniloquenza pur senza alcuna regolarità. E che questo segno architettonico imponente non era prerogativa del passato, ma anche del moderno. Non solo dei ricchi, ma anche dei poveri.
Chi entrava a Roma, e chi da Roma usciva, almeno fino alla metà del primo decennio del Duemila, vedeva allungarsi sul raccordo l’ombra delle torri di Fidene e di Castel Giubileo. Anzi di Nuova Fidene, perché il toponimo semplice, Fidene, designava una borgata abusiva, cresciuta su una collina e poi diffusasi sistemando a casaccio villette unifamiliari e palazzine di due piani, e quindi di tre e di quattro. Nuova Fidene e Castel Giubileo sono nate di fronte a Fidene, quasi a specchio, esito di uno dei Peep, Piani di edilizia economica e popolare, avviati a metà degli anni Sessanta del Novecento sulla base della legge 167, quella che favoriva, appunto, l’edilizia pubblica, le case popolari, le case per chi non poteva permettersi di acquistarne una a prezzi di mercato. Nuova Fidene e Castel Giubileo sono esemplari di una stagione che ora si è chiusa, emblemi di un welfare generosamente denso di idee, prefigurazione di una città migliore, più disegnata, e poi fonte di cocenti disillusioni. Nuova Fidene e Castel Giubileo ospitano oggi novemila persone. Le torri hanno tredici piani, sono di colore grigio, ma altri palazzi hanno l’intonaco ocra che rimanda alla tinta di molti casali dell’agro romano e persino a quello dei palazzi del centro storico. Se si cerca una raffigurazione plastica dell’edilizia popolare, il pensiero può comodamente ricorrere a queste torri.
Giganti su una collina, segnavano l’inizio della città. O la fine. Ed entrambi questi limiti erano marcati dalla grande dimensione che racchiudeva altri significati: la loro mole, la loro razionale, geometrica volumetria sfidava la città delle casette abusive che brulicava nell’intorno. I palazzoni del proletariato contro le palazzine unifamiliari del sottoproletariato e della microborghesia. Il movimento operaio contro la plebe. Fra le ragioni che supportavano i quartieri di edilizia pubblica figurava anche quella che essi avrebbero portato servizi e qualità urbana fra le palazzine accatastate dall’abusivismo accanto alle quali si disponevano. Una specie di missione rigeneratrice. Erano gli anni Settanta. Non si pensava solo a risolvere o a mitigare il disagio abitativo (nel novembre del 1969 fu indetto uno sciopero generale nazionale per la casa), si lavorava a una città che avesse più forma, che includesse invece di escludere. Il Peep di Roma è il più grande che ci sia in Italia, interessa quasi 4.500 ettari, il 10 per cento di tutta la città allora edificata. 700 mila stanze, questa la previsione, di cui 550 mila realizzate in oltre 40 anni, dal 1964 al 2006. Vi abita il 16 per cento dei romani e vi si trova il 40 per cento delle aree per attrezzature pubbliche della città.
Ora Nuova Fidene e Castel Giubileo non sono più la porta di Roma. Per chi viene da Milano, sulla sinistra della collina c’è un’altra porta di Roma. Porta di Roma, appunto, si chiama il quartiere nato nel 2007 intorno a un grande centro commerciale. Occupa integralmente il campo visivo, spezzettando l’isolata monumentalità di Nuova Fidene e Castel Giubileo, mescolando colori e altezze, profili architettonici, spazi riempiti e spazi vuoti. Inoltre alcuni cartelloni pubblicitari, con scritte blu, gialle e rosse, contendono la cima agli edifici popolari. Sei anni dopo la posa delle prime pietre, il quartiere Porta di Roma è ancora punteggiato da cantieri. Non tutto quel che si poteva costruire è già costruito e fra un lotto e l’altro spiccano i gabbiotti degli uffici vendita che allettano chi passa con vistosi cartelli raffiguranti il quartiere che sarà. Che solo molto vagamente somiglia a quello che è. Porta di Roma è un quartiere di case per lo più a quattro piani, ma anche sei, raggruppate in diversi lotti, ognuno con una sigla diversa, un brand che li identifica come se fosse stato depositato in un fantomatico ufficio brevetti dai tecnici delle imprese che i quartieri li hanno costruiti.
A differenza di Nuova Fidene e di Castel Giubileo, case pubbliche e popolari, Porta di Roma è un quartiere tutto privato, costruito da privati su suoli privati. Gli appartamenti costano dai 4 ai 5 mila euro al metro quadrato. Il taglio che prevale è piccolo, 50, 60 metri quadrati. Destinatari, almeno sulla carta, giovani coppie, single, famiglie con uno, al massimo due bambini. Due milioni di metri cubi la volumetria complessiva. Qui un lungo fascione che abbraccia l’intera facciata e gira intorno all’edificio, cingendolo di balconate bianche, uniformi. Lì un motivo bombato, una specie di conchiglia al centro della ringhiera, una conchiglia dalla superficie liscia, levigata e morbida. Visti in una sera d’estate, quando il tramonto proietta strisce di rosso sull’intonaco, i palazzi prendono una movenza statuaria, sembrano assecondare l’ondulazione di quelle che un tempo erano colline. È un gioco illusionistico, è quel che resta delle colline a dare un senso plastico a questi palazzi.
Nelle intenzioni del Comune di Roma, che fortemente ha sostenuto l’idea di costruire, Porta di Roma è una centralità. Le centralità sono uno degli assi che reggono il Piano regolatore approvato nel 2008, sindaco Walter Veltroni, ultimo atto di un centrosinistra che ha governato Roma dal 1993, un documento duramente osteggiato dal centrodestra, che poi con Gianni Alemanno lo ha ereditato e gestito, incrementando cemento e consumo di suolo. Essendo nel Piano regolatore consegnato il disegno di Roma nel futuro, si può immaginare che le centralità debbano avere lo stesso rilievo che hanno avuto nel passato, tanto per dire, i Lungotevere o via Nazionale. Di centralità il Piano ne prevede 18.
Al centro commerciale lavora Gabriella Di Lorenzo. Mentre l’aspetto, sotto il grande logo che ne domina l’ingresso, una cornice rettangolare con tanti schizzi di pennello, tornano alla mente le parole di Giuseppe Campos Venuti, un maestro dell’urbanistica nel secondo Novecento, partigiano comunista, amministratore comunale a Bologna negli anni Sessanta, fra gli artefici della qualità che tutti riconobbero al capoluogo emiliano. Bubi Campos, così lo chiamano amici e allievi, è stato il consulente del Piano regolatore di Roma. Vedendo disattese alcune sue impostazioni, non tanto sulle centralità, ha ritirato la firma da quel documento. «Si è scelta una centralità diffusa», disse Campos in un’intervista a Repubblica del dicembre 2000, «un’edilizia meno gridata, tante aree di pregio in periferia che accoglieranno uffici e serviranno a rigenerare zone degradate». Queste, nelle intenzioni, sono le centralità. Senza dilungarsi sulla letteratura urbanistica a riguardo, basta solo segnalare che la città policentrica è sperimentata da decenni in Europa e si fonda essenzialmente su un sistema di trasporto pubblico su rotaia che ne è il supporto necessario.
18 centralità. 18 città nella città. Stando ai numeri che compaiono nel Piano regolatore, sono 16 milioni di metri cubi di costruzioni, 11 dei quali già in corso di realizzazione nel momento in cui il Piano viene approvato. Sono disseminate un po’ dovunque: il 20 per cento a nord (Porta di Roma in primis), il 45 a est (Ponte di Nona, per esempio, oppure Anagnina-Romanina o, ancora, Tor Vergata e Torre Spaccata) il 35 a sud (Eur-Castellaccio, Fiumicino-Magliana...). Manca la direttrice ovest, per il resto, i punti cardinali sono tutti occupati. Sulla carta le centralità vengono destinate per quasi la metà (48 per cento) a servizi e direzionale, che, tradotto, vuol dire uffici pubblici come i ministeri e sedi di importanti enti. Appena il 14 per cento è la quota per le abitazioni (il calcolo arriva a ipotizzare 12 mila abitanti). Il 13 per cento viene occupato da università e campus per studenti. Solo una parte minima, l’11 per cento, è commerciale – ipermercati, centri commerciali, grande distribuzione.
Quanto questi numeri corrispondano poi alla realtà, lo si potrà dire solo quando tutte le 18 centralità prenderanno forma definitiva. Se mai la prenderanno. Ma, non appena quei dati vennero resi noti, nel 2007, non mancarono le osservazioni critiche. Perché così tante centralità? Non rischiamo di spruzzare da tutte le parti insediamenti che di una vera centralità rappresentano solo un simulacro? E poi: non c’è il pericolo di aggravare la dispersione in una città già dispersa e anzi frantumata? Un problema risaltava con evidenza e suonava sinistro se fatto rimbalzare nella storia recente di Roma: solo alcune centralità erano già servite da trasporto pubblico su rotaia, Pietralata e Ostiense. Alcune delle più imponenti, come Porta di Roma e Ponte di Nona, non lo erano affatto. Veniva poi sollevata un’altra questione: secondo i detrattori, le centralità coincidevano alla perfezione, o quasi, con alcune grandi proprietà fondiarie, i cui valori in questo modo schizzavano alle stelle: Bufalotta-Porta di Roma era dei fratelli Toti e di Parnasi; Anagnina-Romanina di Sergio Scarpellini; Ponte di Nona di Francesco Gaetano Caltagirone; Acilia-Madonnetta della Pirelli Real Estate; la Fiera di Roma ancora dei Toti... Una storia già vista a Roma e diffusamente raccontata da Berlinguer e Della Seta, che in Borgate di Roma (prima edizione 1960, seconda edizione 1976) notavano come «la coincidenza tra le previsioni del Piano [del 1962] e i confini di questa o quella tenuta è precisa e puntuale lungo tutto l’arco dei 360 gradi del territorio comunale». La replica del Campidoglio è sempre stata netta: alcune centralità sono di proprietà pubblica, Tor Vergata, per esempio, oppure Ponte Mammolo, e poi noi fissiamo regole, il mercato delle aree non ci riguarda, va per conto suo.
Il centro commerciale è il nucleo della centralità Porta di Roma (come di altre centralità: a Ponte di Nona, per esempio). Non è scritto in nessun documento urbanistico e nessuno degli autori del Piano regolatore sarebbe disposto ad ammetterlo. Ma nei fatti è così. Gabriella Di Lorenzo ci lavora da cinque anni e il centro commerciale lo conosce. Nel 2009 ha preso una laurea specialistica in antropologia discutendo una tesi su Porta di Roma. L’edificio principale ha forma di trapezio. Da lontano è grigio, ma non opaco. Ha un aspetto evanescente. È stato progettato dallo studio di Gino Valle, uno dei grandi nomi dell’architettura italiana, scomparso nel 2003. All’interno è luminoso, ma non ha finestre né altre aperture sull’esterno. «Qui sono ospitati circa duecento negozi», racconta Gabriella, «la crisi li ha ridotti. Vengono ricontrattati gli affitti, molti non ce la fanno a sostenerli e vanno via. Restano, appunto, i grandi. Questo risponde a una logica del centro commerciale in tutto il mondo: mutare volto, offrendo di sé un’immagine continuamente rinnovata. Si vuol dare l’impressione di essere un pezzo di città soggetto a cambiamenti».
Il centro commerciale è il cuore del quartiere, ma è un oggetto chiuso, senza contatti. Se ne sta per conto suo. È avvolto in una rete di strade che lo cingono al pari di un antico fortilizio e lo tengono issato, visibile anche da lontano come la cattedrale romanica in vetta a un borgo medievale. Dal quartiere ci si arriva a piedi faticosamente, anzi è proprio sconsigliato arrivarci a piedi se si ha una certa età e si cammina lentamente, perché le strade sono solo per le macchine, che corrono veloci dilettandosi fra curve e incroci senza semafori, sottopassi e percorsi in trincea. La luce interna è abbagliante, si moltiplica e si riflette nei pavimenti lucidi, nelle maniglie e nelle ringhiere. Fra il centro commerciale e i grandi magazzini dell’Ikea e di Leroy Merlin si aprono due piazze, collegate da scale mobili. Sono piazze senza ombra, con poche panchine. Sono pulite e animate. Dicono che non c’è mai entrato un mendicante o un ambulante o un suonatore. Se qualcuno scatta fotografie arrivano i vigilantes. Sono piazze aperte al pubblico, ma sono private. Fino a qualche anno fa non si potevano svolgere iniziative di alcun genere senza l’autorizzazione della direzione.
Adesso che la crisi picchia duro, nel centro commerciale si passeggia soprattutto. Si compra meno di qualche anno fa e, per un paradossale capovolgimento di ruoli, l’aspetto urbano del centro commerciale ha preso vigore rispetto a quello mercantile. Si viene per passeggiare, per trascorrere il tempo molto più di prima, racconta Gabriella. E pur non essendo una città né un suo pezzo, pur simulandone goffamente le fattezze, è diventato più città di quanto non lo fosse all’inizio della sua storia. Involontariamente. È sempre un veicolo spaziale approdato sulla collina, con i portelloni che si aprono a comando. Ma piccole cose negli anni sono mutate. La piazza di Porta di Roma è il centro commerciale. La città pubblica si ritira.
Eppure lo scopo della centralità era un altro. Le centralità, diceva Campos Venuti, serviranno a rigenerare zone degradate. Ci riescono? Ci riusciranno? Ci riesce Porta di Roma a trasmettere qualità nella zona Nord, dove s’innalzano le torri di Nuova Fidene e Castel Giubileo e poi di Vigne Nuove, Val Melaina, Serpentara, tutti quartieri di edilizia pubblica, edilizia popolare? Alcuni anni fa, con otto suoi compagni di università, Gabriella ha condotto una ricerca proprio in quei quartieri che un tempo erano la porta di Roma, un Municipio, il IV, che conta oltre duecentomila abitanti, quanto una delle prime quindici città italiane. Era una ricerca a metà fra antropologia e urbanistica. Che cosa mancasse non era difficile da immaginare. Mancavano trasporti efficienti. Le strade erano carenti, incapaci di sopportare il carico dei residenti, e poi la manutenzione era scarsissima, l’asfalto giaceva in condizioni pietose, i marciapiedi erano sconnessi. Non c’erano biblioteche, centri anziani, scuole, parchi ben tenuti. Inoltre molti spazi erano sprecati, vaste distese di cemento si aprivano in attesa di asili che non erano mai arrivati o di parcheggi mai definiti. E poi le parti comuni degli edifici apparivano degradate, macchiate d’umido, nonostante l’anno di costruzione non fosse così lontano. Dalle interviste dei ragazzi veniva fuori che la città storica era lontana, inaccessibile, ostile. Ci si andava occasionalmente, ma nessun ponte la metteva in agevole comunicazione con il proprio quartiere. Roma era altrove e la città tutta viveva in uno stato di separatezza, noi qui, loro lì.
Trasferire qualità nelle periferie che qualità non ne avevano per niente era stato uno dei temi della migliore urbanistica romana. E chi ha redatto il Piano regolatore non poteva sottrarsi a riflettere, mutatis mutandis, sulla questione. Negli anni Cinquanta l’idea si coniugava con un’altra: quella di togliere dal centro storico una serie di funzioni poco compatibili con la struttura antica di strade ed edifici. Le due questioni si incrociavano nelle riflessioni di Luigi Piccinato e di Ludovico Quaroni, autori insieme ad altri del primo progetto di Piano regolatore del dopoguerra. E fu promotore di questa impostazione Antonio Cederna. Sgomberiamo il centro storico di ministeri e di uffici pubblici, dicevano, di banche e di assicurazioni, perché senza questi potenti attrattori di uomini e di auto il cuore rinascimentale e barocco della città pulsa con minore affanno. Lasciamoci solo le sedi delle più alte istituzioni, la Presidenza della Repubblica, le Camere, la Corte costituzionale. E portiamo ministeri, uffici pubblici, banche e assicurazioni nelle periferie, che smetteranno di essere tristi luoghi dormitorio. Il progetto Sdo, Sistema direzionale orientale, rispondeva a questo doppio bisogno. Nella zona Est di Roma sarebbe sorto un centro alternativo a quello antico. Discussioni infinite, pregi e difetti scandagliati con cura. Non se ne fece nulla.
Ma l’idea ha continuato a vagare in città, si è messa in cerca di paternità culturali e politiche e ha anche cambiato i propri connotati. Lasciamola per un attimo lì dov’è, nel dibattito di quegli anni, fra le pagine di I vandali in casa e di Mirabilia Urbis di Cederna. E torniamo al IV Municipio e alle storie raccontate da Gabriella.
A quei problemi, a quelle carenze, le amministrazioni comunali di centrosinistra, prima di Rutelli poi di Veltroni, hanno pensato di rispondere con le centralità e con un altro strumento urbanistico, i Pru, cioè Programmi di recupero urbano. Anche i Pru sono stati fra i cardini dell’urbanistica romana degli ultimi anni, poi entrati nel Piano regolatore generale. Furono varati nel 2006, ne fu artefice Daniel Modigliani, architetto, che dirigeva l’ufficio del Piano regolatore. Consistevano in questo: il Comune individuava i quartieri di edilizia popolare che, nonostante fossero terminati appena pochi anni prima, già mostravano le prime crepe, erano privi di servizi. Il Comune non definiva in dettaglio di che cosa un quartiere avesse bisogno, lo lasciava un po’ nel vago, e però si rivolgeva ai privati con un bando: vi diamo permessi edilizi in aree non previste come edificabili e voi, oltre ai cosiddetti oneri concessori stabiliti dalla legge (la legge n. 10 del 1977, la legge Bucalossi), ci versate altri soldi con i quali costruiamo strade, biblioteche, scuole, centri anziani, ecc. ecc. I quartieri romani interessati ai Pru erano tanti, da Prima Porta a Tor Bella Monaca, da San Basilio a Primavalle e Corviale. Fra questi anche Val Melaina, Fidene, Serpentara e Vigne Nuove. In totale 6 mila ettari di città in cui vivevano 450 mila persone, un quinto di tutti i romani. Gli investimenti erano cospicui: 1.800 milioni, di cui 1.620 privati e 183 provenienti dai bilanci del Comune. Un esempio di buona partnership fra pubblico e privato? Oppure una contrattazione al ribasso in cui erano i privati a dettare regole e a ricavarci profitti e rendita, lasciando ben poco alla città? Questioni cruciali nell’urbanistica degli ultimi anni, non solo romana, che si riproporranno e che si propongono ancora oggi con il loro portato di intrecci fra politica e interessi immobiliari, fra politica e affari. Io, Comune, ti garantisco suoli, edificabilità e cubature, tu, privato, costruisci, mi paghi e fai servizi. Le discussioni si accesero immediatamente. Perché mai per portare servizi in un quartiere che non li ha bisogna sovraccaricarlo di altro cemento? Non abbiamo soldi, rispondevano al Comune, e i servizi li possiamo fare solo se li pagano i privati. Ma così si consuma altro suolo, arriveranno altri abitanti e ci sarà bisogno di altri servizi, è un circolo vizioso, una spirale che non si chiuderà mai. Non è vero, replicavano in Campidoglio, vigiliamo noi, state tranquilli. E poi non finirà che sono i privati a decidere che cosa fare, con la conseguenza che prima si fanno le case e poi, con la mano sinistra, i servizi per il quartiere, seppure si faranno mai? State tranquilli, insistevano al Comune, vigiliamo noi.
Le centralità rispondevano, nelle intenzioni dei promotori, alle stesse esigenze. Vicino ai quartieri dormitorio, alle periferie desolate mettiamo insediamenti ricchi di funzioni pregiate (uffici, direzioni di banche, di aziende pubbliche e private, sedi universitarie, ministeri...). Questi produrranno effetti benefici e garantiranno servizi anche laddove la fatica del vivere e a volte la disperazione sembrano le uniche dimensioni dell’esistenza. Non una centralità, lo Sdo, ma tante centralità diffuse, auspicava Campos Venuti.
Passeggiando con Gabriella nel viale Carmelo Bene, che qui chiamano il boulevard, uno stradone che dal centro commerciale scorre verso Serpentara e Castel Giubileo (qui tutte le strade sono dedicate a personaggi dello spettacolo di ieri e di oggi. Qualche esempio: Cesco Baseggio, Alberto Lionello, Lina Cavalieri, Carlo Dapporto, Wanda Osiris. Compare anche Mario Soldati, evidentemente più come regista e documentarista che come scrittore), passeggiando con Gabriella, dicevo, riflettevamo sulla ciclicità dell’urbanistica romana. I quartieri di edilizia pubblica avrebbero dovuto portare servizi ai quartieri abusivi, le centralità e i Pru avrebbero dovuto portare servizi ai quartieri di edilizia pubblica. Ogni insediamento nasce come riparatore dei guasti commessi dal precedente, come se la storia della città fosse un rosario di colpe e di redenzioni, di affanni e di risarcimenti.
Che cosa è successo in questo lembo di Roma Nord quando si è cominciato a parlare di centralità e di Pru? Comitati di cittadini sono sorti in molte parti della città, e anche a Serpentara, uno dei quartieri meglio riusciti fra quelli del secondo Peep romano. In mezzo ai grandi edifici che si affacciano, dall’alto di un colle, sulla stazione Salaria c’è uno spazio verde che gli abita...