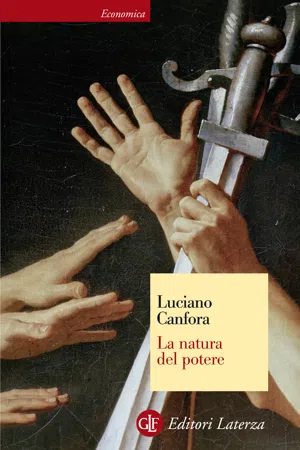capitolo quarto Cesarismo
Cesarismo: soluzione incompiuta, provvisoria, quasi una rinuncia a scegliere, quella adottata da Cesare alla fine della sua traiettoria politica. Bonaparte si ispira, proclamandosi imperatore, allo sviluppo della costituzione romana dopo Cesare – l’impero appunto –, ma evita anch’egli rigorosamente la parola «monarchia». Va oltre Cesare, porta il modello cesariano alle conseguenze estreme, e nondimeno coltiva, da sconfitto, il mito di Cesare. Tra l’altro dettando un’opera letteraria, il Précis des guerres de Jules César, che è un po’ una ‘resa dei conti’ tra l’imperatore e il suo archetipo romano. Una resa dei conti storiografica, politica, non solo militare. Bonaparte non si limita infatti, come farebbe pensare il titolo, a riconsiderare le grandi campagne militari del suo grande modello, mescolando gli elogi alle notazioni critiche: parla anche della politica, del regime instaurato da Cesare. Ed ha una particolare attenzione proprio per quel carattere di ‘terza via’ che il cesarismo viene ad assumere tra regime oligarchico da un lato e regime popolare dall’altro. In particolare su di un aspetto Bonaparte si sente pienamente solidale con le scelte compiute da Cesare: nella ricerca di una ricomposizione, di un accordo, con la nobiltà che lo aveva avversato. A questo proposito, anzi, il Bonaparte si spinge fino a una formulazione che sembra anticipare la michelsiana «ferrea legge dell’oligarchia»: «Nei popoli e nelle rivoluzioni l’aristocrazia esiste sempre: eliminatela nella nobiltà, ed eccola rispuntare nelle casate ricche e potenti del Terzo Stato; eliminatela anche qui ed essa sussiste nell’aristocrazia operaia»1. In queste righe vi è – tra l’altro – un riferimento abbastanza chiaro a quelle pagine dei Commentarii della guerra civile in cui si parla della repressione molto dura che Antonio, magister equitum di Cesare, esercita contro i moti miranti alla cancellazione dei debiti, esplosi in Italia quando la sconfitta pompeiana sembrava ormai assodata.
Non deve perciò sorprendere che Alphonse de Beauchamp (1767-1832), il quale partito giacobino terminò la sua carriera scrivendo le memorie che Fouché fece circolare sotto il proprio nome, abbia diffuso nel 1823, dunque poco dopo la morte del Bonaparte (5 maggio 1821), una Vie de Jules César che è, almeno nelle premesse, una storia a chiave avente di mira anche Bonaparte.
Il fatto che Bonaparte abbia cercato di dar vita a una forma di potere carismatico-militare di cui Cesare era stato una fonte di ispirazione ha aiutato a comprendere che quella cesariana non era stata sic et simpliciter una monarchia. Bonaparte legge quella remota esperienza, ne cava dei tratti fondanti e peculiari, e costruisce un modello – il bonapartismo appunto – che i contemporanei ben videro quanto fosse diverso dalle «salutaires et protectrices monarchies modernes», per dirla con Alphonse de Beauchamp.
Invece, per i ceti dirigenti della Roma tardorepubblicana (i quali pensarono di chiudere la partita col ‘tirannicidio’ delle Idi di marzo), l’esperimento cesariano non poteva che collocarsi sul versante costituzionale, a Roma sommamente illegale, della monarchia. Con in più i tratti dell’usurpazione, e dunque della ‘tirannide’. Se regnum, e soprattutto l’aspirarvi, a Roma è un crimine, un attentato alla costituzione, la tirannide è la nozione più vicina per chi voglia far ricorso alla tradizione greca di pensiero politico. Re-usurpatore e tiranno finiscono per coincidere e sono, dal punto di vista dei ceti dirigenti romani, entrambi compresenti nella figura di Cesare e nel tipo di potere da lui instaurato con la dittatura a vita. Non è superfluo aggiungere, a questo proposito, che anche il tiranno, prima di diventare l’antitesi, l’opposto, della politeía e quindi della democrazia, era stato il mediatore (filo-popolare) nei conflitti senza sbocco della Grecia del VI secolo a.C.
Quanto sbilanciato in senso monarchico – e perciò insostenibile – apparisse l’esperimento cesariano risulta chiaramente dalla già ricordata presa di distanze da parte di Ottaviano. Egli realizzò un capolavoro politico nel momento in cui, e sia pure a prezzo di un conflitto molto lungo contro Antonio (invaghito del modello ellenistico), riuscì al tempo stesso a guadagnare il controllo e l’appoggio delle legioni e della pars cesariana e però anche a stabilire una forma di potere presentabile come «restaurazione della repubblica».
Del resto, semplificando e togliendo all’esperimento cesariano il carattere peculiare di ‘terza via’ bonapartista, non classificherà Eduard Meyer, in uno dei suoi libri più celebri (Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius), quella di Cesare come monarchia e il modo di essere di Pompeo «in re publica» come principato e dunque come anticipazione del tipo di governo inventato da Augusto?
Eduard Meyer scriveva quel suo libro nel 1917 (e lo pubblicava nel ’18), mentre nella Russia, rivoluzionata dalla guerra e dal succedersi dei sussulti, si veniva affermando il potere personale di Lenin (un ‘bonapartismo di sinistra’ di cui, qualche anno dopo, Meyer si dichiarò ammiratore, nel saggio Das neue Russland2), e pochi anni prima che in Italia si affermasse, a fronte dell’impotenza dei rivoluzionari a «fare come in Russia» e dello Stato borghese a «schiacciare la rivoluzione», un ‘bonapartismo di destra’: la dittatura di Mussolini.
Riflettendo in carcere sulla sconfitta subita dalla ‘rivoluzione’ in Italia e, in modo quasi trasparente, sulle forme dittatoriali che il potere bolscevico aveva assunto in Urss, Antonio Gramsci approdava alla distinzione tra cesarismo progressivo (Cesare e Napoleone I) e cesarismo regressivo (Napoleone III e Bismarck). Distinzione quanto si voglia discutibile, a proposito della quale non va però mai perso di vista che la premessa, immediatamente precedente tale distinzione e comune a entrambi, è che, secondo la felice definizione di Gramsci, «il cesarismo esprime sempre la soluzione arbitrale, affidata a una grande personalità, di una situazione caratterizzata da un equilibrio di forze a prospettiva catastrofica»; e subito prima: «il cesarismo esprime una situazione in cui le forze in lotta si equilibrano in modo catastrofico, cioè in modo che la continuazione della lotta non può concludersi che con la distruzione reciproca»3. «Si tratta di vedere – prosegue Gramsci – se nella dialettica rivoluzione/restaurazione è l’elemento rivoluzione o quello restaurazione che prevale, poiché è certo che nel movimento storico non si torna mai indietro e non esistono restaurazioni ‘in toto’»4.
È proprio Cesare il personaggio intorno al quale questi schemi si intrecciano. Può essere curioso osservare l’entusiasmo con cui Marx parla di Cesare in una assai nota lettera a Engels, scritta nei mesi in cui Marx certamente legge (come si ricava da altre lettere) la Römische Geschichte di Mommsen. È la lettera del 27 febbraio 1861, più nota per il giudizio – tante volte ricordato – su Spartaco («grosser General, kein Garibaldi!») e su Appiano, lo storico greco-egizio di Alessandria. Nel seguito di quella lettera Marx mostra molto enfaticamente di apprezzare la spericolatezza militare di Cesare, prova dell’indiscussa sua superiorità sugli avversari: «Pompeo un vero mammalucco [Scheisskerl] salito in falsa risonanza come young man di Silla [...] un disgraziato non appena deve misurarsi con Cesare. Cesare fece i più grossolani errori militari a bella posta, da insensato, per far perdere la bussola al filisteo che gli stava di fronte. Un comune generale romano, diciamo Crasso, lo avrebbe annientato sei volte durante la lotta in Epiro»5.
Spira in questa pagina una simpatica esaltazione filocesariana che va oltre lo stesso tono ammirativo del Bonaparte. Il quale almeno su questo terreno non esita talvolta a denunciare gli errori tattici commessi da Cesare soprattutto nella guerra civile. E tra questi spicca, per l’appunto, l’azzardata condotta in Epiro: «Cesare a Durazzo compì manovre estremamente temerarie – scrive in proposito Bonaparte –, di cui fu punito»6.
L’entusiasmo di Mommsen per Cesare è ben noto e non è qui il caso di ricordarlo se non di passata, e per mettere in rilievo come esso coesista, in Mommsen, con la sua forma mentis liberale (soprattutto nel tempo in cui scriveva la Römische Geschichte). Che la lettura della Storia di Mommsen abbia influenzato Marx è anche possibile, ma c’è sicuramente dell’altro in quell’apprezzamento entusiastico – che Marx manifesta – per la statura e la spregiudicatezza di Cesare: un rapporto senza complessi con la ‘dittatura’.
Anche i tentativi di scrivere la storia di Roma da un punto di vista marxista hanno dovuto fare i conti con Cesare, e non di rado gli hanno attribuito il ruolo storico di aver aperto una nuova epoca ponendo fine alle contraddizioni insostenibili della città-Stato oligarchica non più in grado di dirigere un così grande impero. Il più ampio ed equilibrato sforzo di comprensione in tal senso è stato quello compiuto da Francesco De Martino, nel terzo tomo della Storia della costituzione romana. Resta comunque anche per De Martino assodato che contro Cesare si ergeva «una classe politica, la nobiltà senatoria, divenuta incapace di assicurare la retta direzione dello Stato, decisa soltanto a non rinunciare ad alcuno dei suoi privilegi»7.
Il richiamo a Cesare ricorre in scritti di esponenti del comunismo italiano (Gramsci, Togliatti), non francese o russo. Analogamente Cesare è ben presente, con alti e bassi, nell’ideologia e nel linguaggio del fascismo italiano, non però di quello tedesco, e nemmeno di quello spagnolo (che semmai celebra, con qualche ritardo, e solo per compiacere Mussolini, il bimillenario augusteo). Un esempio interessante è costituito dalla totale assenza del nome di Cesare nei sei ricchissimi volumi delle Opere scelte (ampia selezione) di Lenin stampati a Mosca in tutte le principali lingue del mondo. Il nome di Cesare figura unicamente in un estratto dalle Lezioni sulla filosofia della storia di Hegel (compilato da Lenin nella prima metà del 1915). Qui, come nel restante contesto, si tratta di parole di Hegel inframezzate da riassunti di Lenin. Eccole: «Egli (Cesare) ha assopito l’eterna contraddizione (sopprimendo la repubblica che era già un’‘ombra’) e ne ha suscitata una nuova»8. Le parole in parentesi sono di Lenin e riassumono il più ampio contesto hegeliano. Sul margine Lenin si limita a cavare questo succo dalla lettura: «Hegel e la contraddizione», ma nulla che riguardi Cesare. La ragione di questa assenza è chiara: per gli uomini del XX secolo il cesarismo ha ormai un altro nome, quello di «bonapartismo» (nelle sue due facce del I e del III Napoleone). E infatti quando il movimento comunista si spacca col drammatico ‘scisma’ di Trockij, quest’ultimo accuserà Stalin di aspirazioni bonapartiste, non di ‘cesarismo’.
Invece, nella realtà politica e culturale italiana di epoca fascista, c’è un rilancio di Cesare. Succede infatti che, presentandosi come una rivoluzione incentrata però sulla figura dominante di un capo, il fascismo trovi utile, soprattutto al suo avvio, ricorrere al modello rappresentato da Cesare. Cesare è visto come colui che al meglio coniuga in sé e nella sua azione i due elementi: la rivoluzione contro il vecchio ordine e il potere personale illimitato. Nei celebri Colloqui con Emil Ludwig, finiti di stampare presso Mondadori il 23 giugno 1932, Mussolini esprime, «con tono cupo e interiormente eccitato» a quanto riferisce il suo intervistatore, un giudizio ultra-mommseniano su Cesare: «Cesare, il più grande dopo Cristo fra quanti siano mai vissuti» (variante marginale: «il più grande uomo, dopo Cristo, etc.» a significare l’anti-cristianesimo che di tanto in tanto Mussolini lasciava trapelare). Questo giudizio appare nel capitolo intitolato «Sull’arte» (p. 208 dell’edizione critica9). Nel capitolo «Pericoli della dittatura», Mussolini difende, contro le obiezioni del suo intervistatore, la scelta cesariana di liquidare fisicamente l’ormai prigioniero Vercingetorige (p. 134), ed è sintomatico come egli abbia qui mutato le proprie parole ormai in bozze. Aveva detto che non «si dovrebbe giudicare Cesare dal fatto che egli ha torturato Vercingetorige», ma poi ha mutato di suo pugno «torturato» (che era la pura verità) in «incarcerato»! E ancora nel capitolo «Agire e pensare» (p. 190), a Mussolini che definisce il Cesare di Shakespeare «una grande scuola per i governanti», Ludwig chiede: «Sente questo romano come un modello?». Mussolini riflette e se la cava così: «Non precisamente, ma tutta la pratica delle virtù latine mi sta dinanzi [...]. Il materiale è lo stesso. E là, fuori, è sempre ancora Roma».
Queste parole di Mussolini, dette all’incirca nel decennale della ‘marcia su Roma’, stridono rispetto alla voce Cesare (1931) dell’Enciclopedia italiana (IX, pp. 867-873; la voce è di Mario Attilio Levi, ebreo fascista), che culmina – pur nell’ammirazione – nella tesi che Cesare, sognando una monarchia di tipo ellenistico, si era messo «contro la tradizione e contro la Storia» (p. 872). La voce scritta da Levi irritò molto Mussolini10.
Il 1932 è un anno importante per il fascismo. È il ‘decennale’ della marcia su Roma e il regime ottiene ormai innumerevoli riconoscimenti internazionali: dall’Inghilterra alla Francia, agli Usa, alla Grecia di Metaxas. È significativo un esempio di tale prestigio incontrastato, che fa sì che degli esuli antifascisti si abbia per lo più, nell’establishment europeo e nordamericano, un’idea non proprio favorevole. Nel novembre 1932 esce a Berlino un fascicolo della «Europäische Review» interamente dedicato al decennale del fascismo, e tra gli altri vi figura un ampio saggio di un alto esponente dell’ala sinistra del partito radicale francese, Pierre Cot, nel quale i riconoscimenti a Mussolini come «grande uomo di Stato» e «rigeneratore» del popolo italiano abbondano pur nel chiarimento della netta lontananza politica dell’autore rispetto al fascismo (p. 744). È perciò significativo che nel 1932 escano vari libri su Cesare. Essi indicano la percezione diffusa che sia legittimo l’accostamento tra esperienza cesariana (‘cesarismo’) e fascis...