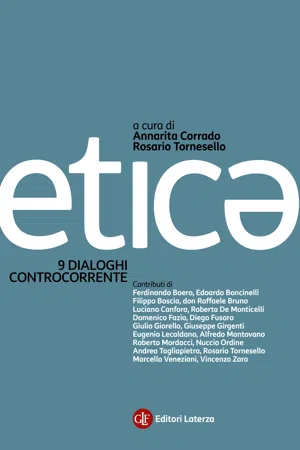Sincerità
di Andrea Tagliapietra, Marcello Veneziani
Tagliapietra Il tema del «diritto alla verità» era all’origine di un importante corso tenuto da Jacques Derrida, a Parigi, nel 1993. Un seminario apparentemente in tono minore su uno dei maggiori filosofi del pensiero moderno, Immanuel Kant, il quale nel 1797 scrisse un curioso articolo – un testo di appena sette pagine nell’edizione dei Kant’s gesammelte Schriften – dal titolo Sul presunto diritto di mentire per amore dell’umanità. In questo scritto Kant sostiene che dire la verità non è un dovere condizionato ma assoluto. Secondo il filosofo tedesco occorre dire sempre la verità. L’uomo ha il dovere assoluto della veridicità, pena la totale inaffidabilità di qualsiasi forma di comunicazione e, soprattutto, la perdita della dignità individuale. Bisogna essere macchine della verità, assolutamente trasparenti. Kant fa un esempio terribile: se un amico bussa alla tua porta per chiedere asilo e tu accetti di ospitarlo, cosa dovresti fare nel momento in cui sopraggiungono a casa tua gli assassini che lo stanno inseguendo per ucciderlo? Dovresti dire il falso e mandare via gli assassini, oppure la verità e consegnare il tuo amico? Kant risponde che persino in questo caso bisogna dire la verità. Il filosofo dell’Illuminismo afferma il dovere assoluto della veridicità, nel titanico tentativo di ancorare stabilmente il flusso della sincerità individuale alla struttura conoscitiva del soggetto, produttrice dell’oggettività formale e della sua stessa permanenza.
La breve opera Sul presunto diritto di mentire per amore dell’umanità viene scritta da Kant in risposta alle parole di un giovane intellettuale di origine svizzera, Benjamin Constant, autore di un trattato politico, Sulle reazioni politiche, in cui veniva messo in discussione proprio il dovere assoluto di dire la verità. Constant scrive: «Là dove non ci sono diritti, non ci sono doveri», con l’intenzione di collocare all’interno delle circostanze il principio astratto della veracità. Perché vi sia il dovere di dire la verità bisogna che colui che riceve questa «verità» ne abbia il diritto. L’assassino che, chiedendomi dov’è il mio amico, vuole coinvolgermi nell’atto di levare la mano su un altro uomo, vale a dire nel concreto disconoscimento dell’umanità dell’altro, esclude l’eventualità di una risposta veridica, poiché, conclude Constant, «nessun uomo ha diritto a una verità che nuoccia agli altri». Di fronte all’alternativa tra vita e verità, l’eccezione è la vita, ed è proprio l’eccezione che permette al principio di essere applicabile condizionatamente. Oggi si celebra Kant come alfiere del pensiero liberale, cionondimeno nelle sue opere si tratteggia la figura ideale di un assolutista del dovere. Constant contrappone a tale assolutismo la situazionalità dei principi e argomenta la sua posizione sostenendo che i principi, per adeguarsi alla realtà, devono utilizzare principi intermedi. La corrispondenza tra diritti e doveri è il principio intermedio che consente al diritto alla verità di diventare effettivo.
Inoltre, l’assolutismo del dovere della veridicità provocherebbe una situazione contraddittoria. Kant, nel momento in cui accetta l’amico in casa sua, è come se affermasse «ti offro sinceramente la mia ospitalità». In seguito, quando tradisce la fiducia dell’amico, seppur al fine di dire la verità, contraddice l’ospitalità e la protezione promesse. Paradossalmente, quindi, nel momento in cui Kant tenta di dire la verità assoluta, viene meno alla parola data e alla verità nella sua manifestazione concreta, perché la seconda verità smentisce in qualche modo la prima.
Ne consegue che il diritto e il dovere alla verità si intrecciano all’idea di sincerità, producendo configurazioni di senso complesse e stratificate.
Veneziani Stando alla retorica che la precede, la sincerità sarebbe oggi una virtù trionfante. Da quando furono abbattute le barriere architettoniche che la ostacolavano – il timore reverenziale, il rispetto, il galateo, la paura della punizione – la sincerità si presenta nuda, sfacciata. Via i tabù, vai con l’outing. La sincerità è una virtù socialmente pericolosa e difficilmente compatibile con l’amicizia, l’affetto e la simpatia. È una signorina stimata ma poco amata. Nubile, non sopporta mariti e conviventi. A volte è irritabile, più spesso è irritante. Nell’immaginario sociale, la sincerità è una virtù puerile come lo è la bugia, il cui metro vistoso è il naso di Pinocchio che s’allunga. Più della bugia ha le gambe corte, perché non va lontano, tronca molte relazioni. È un modo di dire ma non implica un conseguente modo di agire. Il sincero può persistere in tutti i suoi errori, vizi, bassezze; si limita a dichiararli. Chi è sincero può non essere onesto, e chi è onesto può non essere sincero. Se confesso di aver rubato sono sincero ma non smetto di essere ladro. Viceversa posso dire una bugia a fin di bene, dunque onesta. Non c’è nessun automatismo tra la sincerità e la verità. Il sincero non dice la verità ma dice quel che pensa. La sincerità è soggettiva mentre la verità implica lo sforzo di uscire dalla propria soggettività per avvicinarsi alla realtà obiettiva.
La sincerità può autoingannarsi: costruisce castelli d’illusioni e va ad abitarci. Il mio cuore messo a nudo di Baudelaire indica un sincero aprirsi, esponendo le passioni, i tormenti, le speranze; ma la verità è un’altra cosa. Senza dire del sofisma cretese: se dico «sto mentendo» sono sincero o no? Quesito insolubile perché si autosmentisce in ambo i casi.
La sincerità è spesso confusa con la spontaneità: niente freni, niente veli, dico tutto quel che mi passa per la testa. La spontaneità è immediata, non tollera la mediazione riflessiva; è diretta, selvatica, primitiva. La spontaneità in sé non è una virtù, è solo la liberazione di un impulso, quasi un’incontinenza. La brutale franchezza spesso produce nel nome di un piccolo bene, la sincerità, gravi danni al prossimo e ai rapporti umani. Ferisce l’altrui sensibilità, non si cura dei suoi effetti, danneggia i legami sociali. Dal Sessantotto in poi si è identificata la sincerità con la spontaneità. Come la verità è rivoluzionaria sul piano politico, così sul piano interpersonale la sincerità è stata considerata libertaria, liberatrice e dissacrante. Franco sta sia per sincero che per libero.
Da questa pseudo-sincerità sono nati due frutti, uno per affinità, l’altro per contrasto. Da una parte è sorto il coming out, detto in breve outing. Tutto ciò che era coperto dall’inibizione diventa oggetto di esibizione. Il pudore per l’intimità cede al narcisismo, con sfacciata sincerità. Dall’altra parte il risultato paradossale della guerra all’ipocrisia «borghese» è la nascita d’un nuovo codice dell’ipocrisia, il politically correct. Tutto viene smussato attraverso l’ipocrisia, mediante dei canoni per cui non bisogna dire la verità ma rappresentarla con giri di parole: l’uomo di colore, il rom, il diversamente abile, l’operatore ecologico, il personale ausiliario e tutta la retorica che noi sappiamo, fino al morto come diversamente vivo. La sincerità delle origini si è capovolta in uno stucchevole rococò della falsità. L’esplosione della sincerità attraverso il coming out, cioè la rivelazione pubblica di orientamenti che attengono alla sfera privata, soprattutto di natura sessuale, ha operato un’inversione dei tabù storici e culturali: prima c’era il tabù sull’eros e al contrario la condivisione comunitaria della morte, oggi c’è il tabù della morte e l’esibizione pubblica della sfera privata dell’eros. Torna in altre vesti la massima: la parola è data all’uomo per nascondere il pensiero (e la realtà). Una parodia delle ipocrisie rivoluzionarie la fece già Niccolò Tommaseo nel Vocabolario filosofico-democratico del 1799.
La civiltà è il contrario della sincerità intesa come spontaneità. Ciò vale sia nell’ambito del costume e dei comportamenti sia sul piano del pensiero e della fede. Nel primo caso, l’etica si accorda all’estetica e la sincerità non deve ferire lo stile e il buon gusto; nascono il galateo, la civiltà delle buone maniere, che velano la sincerità; le tende di pizzo del pudore. Ma anche in ambito teologico e filosofico la verità si è servita della menzogna quanto e più della sincerità. La pia fraus cristiana e le sante omissioni, le salutari menzogne di Platone, la doppia verità di Averroè, il bello mentire di Campanella, la dissimulazione onesta di Torquato Accetto praticata anche da rigorosi moralisti come Seneca, le menzogne necessarie di Nietzsche (il velo d’Apollo che veste di bello l’orrore della verità e copre la tragedia del divenire).
In particolare il pugliese Torquato Accetto, di Trani, vissuto a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento, prendendo le mosse dall’evangelica esortazione a essere prudenti come serpenti e candidi come colombe, ritenne che l’insincerità fosse «un velo composto di tenebre oneste», necessaria come la notte rispetto al giorno. La dissimulazione, spiega, è «una industria di non far veder le cose come sono. Si simula quel che non è, si dissimula quel che è»; dunque nella simulazione c’è la menzogna degradante, nella dissimulazione c’è l’arte di nascondere per prudenza, che è pure «arte della buona creanza», superamento degli istinti, autocontrollo, intelligenza, pietà e sensibilità, capacità di tacere e di tenere a freno gli impulsi. Ci libereremo della dissimulazione solo nell’ultimo giorno della vita, e da allora in poi entreremo nel regno puro e celeste della sincerità (o della dannazione). Accetto conclude il suo trattato con un elogio della virtù di dissimulare, che è «il decoro di tutte le altre virtù le quali son più belle quando in qualche modo son dissimulate, prendendo l’onestà del tuo velo, per non far vana pompa di se medesime»; «rifugio de’ difetti», «arte di pazienza». C’è tutto lo spirito del Seicento, il barocco artificioso che viene; c’è tutta l’arte di barcamenarsi tra Francia e Spagna, tra potere politico e potere ecclesiastico, assai praticata nel Sud d’Italia. Ma c’è, con qualche paradosso, anche l’arte della convivenza e la saggezza che la verità pura e assoluta acceca e rende impossibile la vita.
Anche in letteratura la menzogna troneggia. La realtà ha molte facce e noi possiamo essere sinceri rispetto a una e insinceri rispetto a un’altra. Possiamo dire la verità, ma non tutta la verità. Qui si tocca una questione cruciale che va oltre la sincerità e investe la verità, che ama nascondersi, si confonde col mistero e può essere colta per allusioni e frammenti. È la poligonia del vero, di cui parlava Gioberti nella Teoria del sovrannaturale; la verità ha vari lati, non uno solo. Nessuno ha la verità in tasca, semmai noi siamo dentro la verità, ne cogliamo uno spicchio; ma ciò non impedisce che ci siano altri spicchi di verità che non vediamo. Non è relativismo, che sottende la riduzione della verità ai punti di vista, alle interpretazioni soggettive; ma la verità ha più lati, è più grande di noi, ci trascende, noi possiamo aspirare a essere nella verità, non ad avere la verità in pugno. Questo salva la verità dal monopolio dispotico e dalla negazione nichilista.
Insomma la sincerità è una virtù interiore ma non sempre è una virtù pubblica. Spesso ferisce, nuoce, spezza i legami; non implica coerenza tra il dire e il fare. Non s’identifica con la spontaneità ma assume valore se è consapevole e riflessiva. La sincerità è poi soggettiva e dunque non coincide con la verità. Resta un pregio, una virtù vera, se indica l’aprirsi agli altri senza secondi fini subdoli. E se sa fermarsi davanti alla soglia del rispetto altrui, della carità, della prudenza e della pazienza. Come ogni virtù, la sincerità si fa tiranna se è unica e assoluta, sciolta da ogni vincolo e da ogni altra virtù. Non è la virtù regina, ha valore se non violenta altre virtù. Al poligono della verità corrisponde il politeismo delle virtù: le virtù si temperano a vicenda. Senza freni la sincerità sconfina nella malvagità.
La cosa più saggia è non stabilire l’assolutezza di una virtù. Una virtù ha valore se si riesce a integrare con altre virtù. La sincerità presa da sola, a sé come valore assoluto, produce effetti devastanti. L’esempio di Kant fatto prima da Andrea Tagliapietra è pertinente, la virtù che diventa assoluta produce catastrofi. L’incorruttibilità ha prodotto tragedie nella Rivoluzione francese e la purezza quando diventa un assoluto si traduce in distruzione del mondo. La stessa cosa accade nella sincerità.
Offendere brutalmente una persona ricordandole i suoi difetti è sicuramente un esercizio reale di sincerità, ma al tempo stesso è una forma di disprezzo dell’altro e quindi, per seguire la virtù della sincerità, si viola l’etica del rispetto della dignità altrui. Non si può mai prendere un principio ed elevarlo a norma assoluta; come Gioberti coglieva la poligonia del vero, così va colta la poligonia della sincerità, i suoi lati positivi e i suoi lati devastanti.
Tagliapietra Non solo le virtù sono correlate tra loro, ma anche le idee. La filosofia tende al purismo dell’idea. Ma questo tentativo non è che un’astrazione, dal momento che nella realtà troviamo solo concatenamenti, combinazioni, costellazioni di idee.
Le culture umane producono un numero notevole ma non infinito di idee. Ciò che cambia continuamente, nel processo storico, è il rapporto che intercorre fra di esse, così come varia la complessità con cui le idee si dispongono nelle configurazioni simboliche che determinano le culture. La sincerità è un’idea complessa, una virtù complessa, che ha almeno due poli: da una parte vi è il rapporto con la verità, la sincerità come dire il vero; dall’altra vi è un polo autoreferenziale, che riguarda la possibilità di essere se stessi, l’autotestimonianza. Si dice infatti: «Non dire bugie, sii sincero». Per questo secondo polo la sincerità non è un fare, ma un essere. Essere sinceri significa diventare ciò che si è producendo una coerenza che è innanzitutto interna, nella propria, per così dire, costituzione ontologica.
Noi viviamo all’interno di una società e di una visione del mondo in cui la verità sembra essere sostenuta dai fatti, tuttavia è sempre all’opera un processo di interiorizzazione, ovvero una costruzione di noi stessi, di cui, entro certi limiti, non siamo completamente sovrani. Esposti agli eventi diveniamo ciò che siamo, ovvero veniamo messi alla prova. A questo punto interviene una nuova funzione della sincerità: non si tratta tanto di dire la verità per entrare in relazione con gli altri, quanto di essere veraci e veridici verso se stessi, cercando di essere le persone che siamo.
Comincia così un processo di costruzione di sé connesso ad altre due virtù: fedeltà e pazienza. Compare il bisogno di costruirsi e di rimanere nel tempo, vivendo una biografia che testimonia una coerenza e si sviluppa secondo un tracciato di cui sia possibile rendere conto. Qui entra in campo la parentela tra sincerità e autenticità.
La sincerità mantiene una relazione con il polo della verità: si è sinceri con se stessi e allo stesso tempo si cerca di esserlo con gli altri, mantenendo in armonia il polo della verità (l’esteriorità) con il polo dell’autoreferenza (l’interiorità).
Nell’autenticità la tensione all’autoreferenzialità è talmente forte che, a un certo punto, si rompe il legame con la verità. Per essere autentici si tradisce il principio di coerenza, di affidabilità e di accettabilità sociale. Uno dei miti costitutivi del Sessantotto è appunto l’autenticità, perché tutta la temperie sessantottina è pervasa da un clima che Isaiah Berlin avrebbe definito «romantico», che gioca sull’autoaffermazione, sull’autoesibizione e sull’autorappresentazione, dimenticando il polo della verità.
Recuperare la virtù e il concetto di sincerità oggi significa preservarne la complessità, senza scivolare nell’autenticità in cui per essere ciò che siamo diventiamo carnefici degli altri e di noi stessi, come rammenta l’ultima saggezza di Nietzsche, quella dei Ditirambi di Dioniso, in cui l’individuo è definito «conoscitore di se stesso» e insieme «carnefice di se stesso». Ad esempio, nei reality show dire la verità spesso significa mettersi alla berlina per dimostrare di non avere niente da perdere; in tal modo la spudoratezza diviene una prova della verità e si instaura un rapporto di pura provocazione, anziché di rispetto e di riconoscimento da parte dell’altro.
Al contrario, la sincerità sa custodire il segreto ed ospitare la differenza. La complessità della sincerità può e dev’essere un valore, una capacità strategica nei confronti di se stessi e degli altri di contro al vizio di abbandonarsi all’ebbrezza dell’esibizionismo e al voyeurismo del «grande altro» sociale. I Greci, del resto, per definire questo fenomeno in cui la sincerità viene ridotta alla spudoratezza parlavano di athyrostomìa, ovvero «il non aver la porta sulla bocca». Tuttavia, la sincerità non è una virtù olistica: non si è sinceri allo stesso modo con tutti, vi sono stratificazioni a seconda delle cerchie affettive di riferimento. Talvolta la sincerità si combina con ...