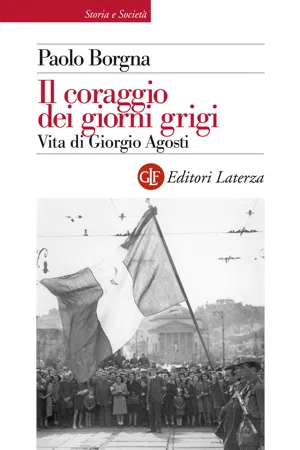Capitolo secondo.
Il questore Giorgio Agosti
“Che cavolo fa un questore?”. Con questa domanda impertinente Giorgio Agosti si rivolge al suo collega più anziano Giuseppe Manfredini, antico amico di Piero Gobetti, pochi giorni prima di prender possesso del suo nuovo ufficio.
In realtà, in questo ricordo dello stesso Agosti c’è una certa dose di understatement torinese e un pizzico di spirito dissacratorio dettato dal passare del tempo. Perché se è vero che l’incarico di questore a Giorgio Agosti viene deciso soltanto ai primi di aprile del ’45, è altrettanto vero che egli non giunge impreparato a quell’ufficio. Tant’è che già nel marzo 1944 il Partito d’Azione piemontese aveva approvato uno Studio per l’organizzazione della polizia nel nuovo Stato elaborato proprio da Agosti.
Non conosciamo, con precisione, la risposta che Manfredini diede al giovane collega. Siamo però in grado di rispondere alla domanda: che doti doveva avere un questore nominato dal Cln al termine di una guerra civile in cui una gran parte della polizia aveva giocato un ruolo importante nell’appoggio alla Repubblica sociale? Non abbiamo dubbi sulla risposta: occorrevano intelligenza, coraggio, estrema determinazione, autorevolezza e un tantino di spregiudicatezza. Ma affinché coraggio e spregiudicatezza non degenerassero in cinismo, bisognava avere alle spalle un profondo radicamento a saldi valori, una vasta cultura istituzionale e politica e una sostanziale indifferenza alle lusinghe del potere. Giorgio Agosti possedeva tutte queste qualità.
Di coraggio, durante la Resistenza, ne aveva dimostrato tantissimo, sfiorando, a volte, il limite della temerarietà. Un coraggio che gli veniva dalla generosità. Quando nei primi giorni dell’aprile ’44 i membri del Comitato militare di liberazione di Torino vengono processati al palazzo di Giustizia che, in quel periodo, Agosti frequenta ancora quotidianamente come giudice, tutto l’ambiente giudiziario torinese, che con molti di quegli imputati ha consuetudine di lavoro e di ambiente sociale, assiste con disperazione muta e impotente al dramma di quel processo il cui tragico esito è già stato scritto da Benito Mussolini e dai suoi padroni tedeschi. Uscieri, cancellieri, giudici, avvocati si affacciano sulla porta dell’aula per salutare con uno sguardo gli imputati in catene. A un tratto, dal pubblico, un uomo si avanza verso di loro e platealmente li abbraccia: è il giudice Giorgio Agosti. Scriverà Valdo Fusi, che quel giorno era sul banco degli imputati e ricevette quell’abbraccio: “Abbracciare uno, due o tre, come ha fatto il magistrato Giorgio Agosti, di quei terroristi non era da tutti, implicava pure un chiaro significato che non sfuggiva ai fascisti. Forse credevano di umiliarci collocandoci sulle panche dei comuni delinquenti. Ma non s’era mai visto tutto il Foro, tutta la Curia, tutti gli abitanti del palazzo accorrere in agonia accanto agli imputati in gabbia”. In quell’abbraccio pubblico di Giorgio Agosti ai condannati a morte è scolpita, in modo esemplare, la sua trasformazione da intellettuale borghese a dirigente politico. Come era avvenuto per Paolo Braccini, rappresentante del Partito d’Azione nel Comitato militare, uno degli imputati che Giorgio va a salutare. Sicuramente, quello a lui più caro. Probabilmente, quello a lui più simile come età, provenienza sociale e culturale. Quando affronta il plotone di esecuzione, Braccini ha trentasei anni (due in più di Giorgio). Ha una bambina, Gianna, che ha da poco compiuto quattro anni (tre in più di Aldo, primo figlio di Giorgio). Di famiglia antifascista, ha coltivato in silenzio la sua estraneità al regime, da cui è stato osteggiato ma non perseguitato. È professore di zootecnica alla facoltà di veterinaria di Torino. È autore di venti pubblicazioni scientifiche in materia di agraria e zootecnia. Di colpo, dopo l’8 settembre ’43, si trasforma in un capo carismatico e straordinario organizzatore. Nome di battaglia: Verdi. “Da quando ha accettato il comando delle G.L. piemontesi – scriverà di lui Ada Gobetti, dopo aver assistito a un suo incontro con Vittorio Foa nel dicembre ’43 – questo professore d’università, nuovo alla politica e alla clandestinità (mi pare d’averlo visto per la prima volta il 9 o il 10 settembre) sta diventando un capo efficiente, preciso, audace e prudente al tempo stesso. E la sua singolare simpatia umana, la sua ricchezza di vita, gli danno su tutti un dominio e un fascino particolare. Senza questa situazione, avrebbe forse continuato a studiar le sue bestie, a far lezione, a dare esami, a occuparsi della sua famiglia, senza manco dubitare d’aver la stoffa del cospiratore e forse dell’eroe. È curioso che esistano uomini le cui qualità modellan la storia, e altri di cui la storia crea le qualità e le virtù”. La stoffa dell’eroe Paolo Braccini la mostrerà pochi mesi dopo. Nelle sue ultime righe alla moglie e alla figlia scriverà di “andare sereno davanti al plotone di esecuzione. La mia fede mi ci fa andare sorridendo”.
Da borghesi a capi politici e militari. C’è, in questa repentina trasformazione, qualcosa di affascinante. Che la sensibilità di Ada Gobetti coglie anche fin dai primi incontri con Giorgio Agosti. “Son stata al Tribunale da Giorgio Agosti – scrive la vedova di Piero il 5 novembre ’43 –. È straordinaria la calma con cui questo giovane giudice fa le cose più pericolose. Il suo studio è frequentato press’a poco come la mia casa; e credo che sia anche un magnifico deposito di stampa e magari d’armi. Ha un senso di quadratura che dà sicurezza. Su lui si può contare per le piccole come per le grandi cose. E la sua aria leggermente ironica è ottima contro ogni forma d’esaltazione”. Questi intellettuali che, mazzinianamente, si trasformano in uomini di pensiero e d’azione, sprigionano energie nuove dietro cui si intuisce una solida forza tranquilla: l’ancoraggio a valori profondi plasmati dalla loro educazione familiare e dalla loro formazione culturale.
Raccontando, nell’intervista a Paolo Gobetti, il proprio impegno nella lotta antifascista clandestina che precede l’8 settembre, Agosti tenderà a minimizzare: “È allora che abbiamo fondato a Torino il Partito d’Azione [...] In realtà non facevamo niente, sai, era anche abbastanza difficile fare qualcosa in quelle condizioni. [...] Ci trovavamo in casa di Livio e in casa di Brosio. [...] Andavamo lì alla sera ogni tanto, ci trovavamo, e naturalmente si può pensare che discorsi facevamo, ma insomma eran discorsi”. In realtà il suo ruolo di cospiratore non fu così irrilevante, a meno di considerare cosa di poco conto essere stati, nel 1942, tra i fondatori del Partito d’Azione! Per la verità, già a partire del 1935, sfruttando il suo “libretto ferroviario” di magistrato, fa la spola fra Torino e Parigi – dove nel 1932 è espatriato il cugino Aldo Garosci – per portare in Italia la stampa clandestina di «Giustizia e Libertà».
“Basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell’anima, e ci si trova dall’altra parte”. Queste considerazioni che Italo Calvino fa dire al suo partigiano Kim sono state spesso usate – ci ricorda Giovanni De Luna – come paradigma della casualità delle scelte della maggior parte dei giovani italiani del Nord nei mesi tra la fine del ’43 e l’inizio del ’44. Scelte non politiche ma dovute al capriccio del destino che, come un uragano, si era abbattuto sulle spalle di milioni di italiani per i quali la politica (e dunque anche la scelta tra fascismo e antifascismo) fu soltanto una dolorosa intrusione nella loro vita quotidiana, fondata sui valori della comunità e della famiglia. Questo fu indubbiamente vero per la grande maggioranza degli italiani e in particolare per le popolazioni contadine del Nord, la cui reazione contro il fascismo di Salò e la guerra fu in primo luogo un atto di difesa contro questa intrusione. Ma non fu così per alcune minoranze attive, che nelle drammatiche traversie del ’43-’45 videro l’occasione per scelte a lungo preparate, eticamente motivate e politicamente determinate.
Giorgio Agosti appartiene a una di queste minoranze. La sua, si chiama Giustizia e Libertà (Gielle). A Torino è una minoranza significativa, molto forte nell’ambiente culturale, in costante osmosi con la profonda tradizione liberale della città che con il Risorgimento aveva vissuto la sua apoteosi e, influenzata dall’interventismo democratico, nella Grande Guerra aveva visto la quarta guerra di indipendenza; e che infine dalla lezione di Piero Gobetti aveva tratto nuovo ossigeno e più ampie e moderne visioni. L’ambiente di Gielle è il risultato di un lungo e laborioso intreccio di relazioni amicali e familiari, di frequentazioni universitarie e professionali, di affinità culturali e consanguineità degli spiriti. Lo racconteremo: narrando, con un lungo passo indietro, la giovinezza di Giorgio. Ma già qui, ricostruendo il suo ruolo nei giorni dell’insurrezione, è necessario ricordare che la sua determinatezza di resistente affonda le radici in una ventennale preparazione culturale e morale.
Nel 1934 lo storico napoletano Adolfo Omodeo, in una lettera ad Alessandro Galante Garrone – che di Giorgio Agosti fu amico dall’adolescenza fino alla morte – aveva scritto: “Vi sono nella vita lunghi periodi o di letargo o di lenta, quasi fisiologica, maturazione, che paiono tristi e non necessari [...]. Non sempre l’albero ha la fioritura della primavera o i frutti dell’estate. E troppi problemi sono immaturi e acerbi [...] e forse quella che ci pare fiacchezza e ignavia e oblio è ponderazione d’un migliore impiego della nostra forza, maturazione di una più decisa volontà nel momento propizio”.
Ebbene, Giorgio Agosti e i suoi amici giungono preparati a quel momento perché alle spalle hanno una lunga preparazione culturale, che li ha difesi dallo “spirito dei tempi” del ventennio fascista, facendo di loro una minoranza isolata ma fortissima, sorretta da una straordinaria coscienza del proprio valore. L’esser stati vaccinati per vent’anni dalla retorica del regime li rende più lucidi all’avvicinarsi del conflitto mondiale e darà loro una consapevolezza totale del proprio compito quan...