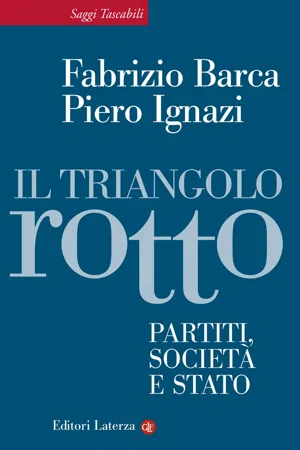La discussione
Nando Pagnoncelli
Esprimerò qualche considerazione sull’aspetto messo in luce da Piero Ignazi sulla disconnessione tra società e partiti. E mi scuso anticipatamente se per ragioni di sintesi alcune affermazioni risulteranno eccessivamente sbrigative o tenderanno a evidenziare i comportamenti e gli atteggiamenti prevalenti e non le diverse articolazioni in cui si struttura l’opinione degli elettori.
Ignazi sostiene che il rapporto partiti-società entra in crisi non solo in Italia, ma in tutta Europa. In Italia, però, assume delle caratteristiche molto particolari che rendono la criticità del rapporto tra partiti ed elettori particolarmente acuta. Penso che gli elementi di cui si è parlato negli ultimi tempi e che hanno suscitato i sentimenti di antipolitica – la riemersione del fenomeno della corruzione, l’utilizzo improprio dei rimborsi elettorali e i privilegi della politica – siano solo la punta di un iceberg di un rapporto che si è deteriorato. Vale la pena di riflettere su quello che è avvenuto negli ultimi vent’anni per poi arrivare a parlare di un paradosso a cui stiamo assistendo.
Negli ultimi vent’anni, attraverso tutti i barometri sulla fiducia dei cittadini (tra cui il più conosciuto è quello Isae-Istat), abbiamo osservato che alla vigilia delle elezioni politiche (ma non solo) si è riscontrata un’impennata della fiducia degli elettori, collegata all’aspettativa di un cambiamento, un cambiamento di segno politico, un cambiamento di governo, l’auspicato avvio di una stagione di riforme e di modernizzazione del Paese. Puntualmente, nell’arco dei sei-otto mesi successivi alla tornata elettorale, alla fine della luna di miele con il governo, si ritornava in una situazione di sfiducia prevalente, di “depressione” della pubblica opinione. Negli ultimi vent’anni abbiamo osservato una serie ininterrotta di aspettative disattese.
L’Italia è l’unico Paese in cui – dal 1994 in poi – le maggioranze che hanno sostenuto i governi sono risultate sconfitte alla prova elettorale successiva. Alla politica si imputa di non essere in grado di interpretare i bisogni del Paese e di dare risposte: la politica non sa leggere la realtà sociale e non sa proporre soluzioni. Ma il paradosso è proprio questo, perché negli ultimi vent’anni la politica è stata in larga misura guidata da una ricerca ossessiva del consenso, attraverso i sondaggi. A questo proposito, vent’anni fa Stefano Rodotà coniò il termine sondocrazia. È paradossale, quindi, osservare partiti che inseguono l’opinione pubblica nella definizione della loro proposta politica e si ritrovano, vent’anni dopo, a subire una vera e propria delegittimazione.
Ignazi nel suo libro riferisce i dati dell’Eurobarometro, secondo i quali coloro che dichiarano di avere fiducia nella politica rappresentano il 30% circa degli elettori. In realtà, i dati più recenti rilevati in Italia evidenziano che coloro che hanno fiducia nei partiti politici rappresentano il 15% degli elettori (di cui solo il 3% dichiara di avere “molta fiducia”).
Il sistema è imploso in un clima di campagna elettorale permanente, nel quale ogni elezione, anche quelle locali, assumono il carattere simbolico di un referendum pro o contro il governo in carica, una sorta di ordalia. E tra un’ordalia “formale” (elezioni) e l’altra non sono mancate le ordalie “virtuali” basate sui sondaggi, utilizzati per certificare il consenso nei confronti del governo e dei partiti. L’utilizzo dei sondaggi come bussola della politica ha ingessato il Paese, costringendo la politica a concentrarsi su un presente “iperdilatato”, impedendo l’avvio di politiche di riforme di lungo periodo. Perché le riforme, lo sappiamo, sono impopolari, mettono in discussione le certezze dei cittadini, li costringono a cambiare, a rivedere le proprie abitudini e i propri stili di vita. E rischiano di far perdere il consenso. Ma il paradosso è proprio questo: inseguendo ossessivamente il consenso i partiti hanno perso il consenso. E la frattura che ha caratterizzato gli ultimi vent’anni – quella tra destra e sinistra – è stata sostituita da una nuova frattura, confermata clamorosamente dal risultato elettorale delle ultime elezioni politiche, quella che contrappone la politica, considerata responsabile di tutti i mali e le nefandezze del Paese, e i cittadini, considerati i depositari di tutte le virtù del Paese.
È uno scenario nel quale i cittadini si autoassolvono con un atteggiamento deresponsabilizzante e convogliano la loro ostilità e il loro livore verso la politica, i partiti e i leader considerati “tutti uguali”. Ma le ricerche demoscopiche evidenziano che i valori espressi dal Paese negli ultimi vent’anni corrispondono a quelli espressi dalla politica, che ne rappresenta lo specchio fedele.
Qualche esempio: si imputa alla politica di fare i propri interessi. Ma gli elettori hanno votato guidati prevalentemente da pragmatismo, attratti da una proposta che rispondesse ai propri interessi, individuali e familiari, incuranti di interessi più generali. Ai politici si imputano i tanti privilegi di cui beneficiano soprattutto in un periodo caratterizzato da grandi sacrifici imposti dalla crisi ai cittadini. Ebbene, gli stessi cittadini sono alla ricerca di privilegi, che si tratti di evitare una lunga attesa per una visita medica o di ottenere i biglietti per un concerto o un evento sportivo. La furbizia, nel nostro Paese, è un valore non un disvalore e, mentre si reclama a gran voce il rispetto delle regole (da parte “degli altri”), l’anomia è largamente diffusa. Si imputa alla politica di non promuovere merito e competenze e nei sondaggi difficilmente otteniamo meno del 100% di favorevoli alla meritocrazia, probabilmente perché tutti pensano di essere titolari di un merito. Ma nella vita di tutti i giorni tra i cittadini prevalgono le conoscenze e le relazioni, non il merito. Lo stesso vale per la concorrenza, le liberalizzazioni, reclamate da tutti ma accettate da pochi. In assenza della consapevolezza di queste contraddizioni e di un’assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, credo che non si vada molto lontano.
Su un secondo elemento vorrei riflettere: in questa fase di acuta ostilità nei confronti della politica c’è – a mio parere – un eccesso di condiscendenza rispetto a questi sentimenti caratterizzati da forte emotività e scarsa razionalità. Ancora una volta c’è la tentazione di cavalcare l’opinione pubblica con il rischio di adottare decisioni che prendano in considerazione l’emotività e non la razionalità, che pure spesso coesistono nelle stesse persone.
Prendiamo il tema del finanziamento dei partiti. L’opinione pubblica, coerentemente con il livore che esprime nei confronti della politica, si dichiara fortemente contraria. Ma quando si entra nel merito di forme alternative di finanziamento affiorano molti dubbi e perplessità: per quale ragione un’azienda dovrebbe finanziare un partito? Le imprese (quotate o meno in Borsa) sono molto attente alla profittabilità: per quale motivo dovrebbero finanziare un partito? Per consonanza ideale? Per affinità valoriale? E ancora, quando, anziché parlare del “palazzo” o della politica “romana”, nei sondaggi parliamo della politica del proprio comune e del ruolo dei partiti sul territorio, allora si attenuano gli aspetti emotivi e prevalgono quelli razionali. E al posto dell’eliminazione di qualsiasi forma di finanziamento pubblico si chiede un contenimento, la rigorosa rendicontazione degli impieghi e il severo controllo delle spese.
Un altro esempio riguarda la legge elettorale attuale (il “Porcellum”) e il voto di preferenza, oggi reclamato da tutti i cittadini che si sentono espropriati di questo diritto, rimuovendo completamente il dibattito degli inizi degli anni Novanta, quando il voto di preferenza sembrava essere strumento di inquinamento della vita politica. Ebbene, quando nei sondaggi menzioniamo il fatto che Franco Fiorito (più noto come “Batman” di Anagni) o Carlo De Romanis (reso famoso dal Toga Party finanziato con denaro pubblico con cui ha festeggiato la propria elezione), due dei protagonisti dello scandalo che ha colpito la Regione Lazio, sono stati votati con migliaia di voti di preferenza, allora le granitiche certezze vengono meno, le opinioni cambiano.
Perché sottolineo questi aspetti? Perché mi pare preoccupante, nella fase attuale, questo atteggiamento di accondiscendenza nei confronti dell’opinione pubblica. Non si ristabilisce una relazione di fiducia con i cittadini inseguendo l’emotività dell’opinione pubblica (la “pancia” del Paese), ma restituendo dignità alla politica. Cito un episodio che mi ha molto colpito: quando a Ballarò i presidenti di Camera e Senato hanno annunciato la decisione di ridurre il loro compenso del 30%, mi sono chiesto in quanti paesi al mondo è successo qualcosa di analogo. Alcune proposte di riduzione dei compensi o di “commissariamento” della politica possono sì blandire l’opinione pubblica, ma rappresentano un’umiliazione delle istituzioni. I cittadini confondono “governo” e “politica”, l’amministrazione dell’esistente e la costruzione del futuro.
I partiti ricomincino a fare politica, una politica fatta di progettualità ispirata a valori e ideali, la cui forza consentirà di coniugare interessi personali e interessi generali, presente e futuro. La politica deve re-impossessarsi del proprio ruolo di guida. Solo così potrà recuperare la fiducia degli elettori.
Walter Tocci
Vorrei mettere in discussione un luogo comune. E se il caso italiano fosse un’anticipazione, invece che un’arretratezza? Forse in questo caos politico si rivelano tendenze ancora latenti in Europa. Le cancellerie europee si preoccupano non per noi ma per sé stesse, perché intuiscono che le nostre anomalie potrebbero riguardarle. D’altro canto, non sarebbe la prima volta che l’Italia esporta un’invenzione maligna.
Bisognerebbe innanzitutto capire la forma concreta assunta dall’organizzazione della politica. L’analisi è impedita da due visioni appiattite dei fenomeni: da un lato, la polemica mediatica che vede solo le vacche nere nella notte buia; dall’altro, la retorica delle riforme che sposta l’attenzione sull’ingegneria istituzionale nascondendo la radice politica della crisi decisionale.
La forma-partito reale ha assunto un carattere originale perché mescola elementi che si collocano prima e dopo il partito di massa: in alto il leader che cura il brand, in basso il notabile locale che gestisce il consenso. Sono legati da una sorta di patto di franchising, molto leggero, che impedisce al leader di controllare l’operato del notabile – abbiamo visto l’impotenza dei dirigenti nazionali verso il malcostume locale – e al notabile di mettere in discussione le svolte politiche del leader.
I partiti in franchising sono adatti ad attrarre clienti, non i cittadini che vogliono partecipare alle scelte; sono concentrati sul mantenimento dello scambio locale e quindi rimangono indifferenti all’elaborazione di programmi di governo nazionali; tendono a conservare un ceto politico, non a selezionare una classe dirigente. Questa forma politica risponde alle tendenze dell’epoca, è un’anticipazione non un’arretratezza, ma è la causa principale della crisi della decisione.
La proposta di Fabrizio Barca di ricollocare l’organizzazione di sinistra nel vivo della società ha riscosso un largo interesse e ha rimesso in movimento energie. È suggestiva e foriera di preziose sperimentazioni la proposta di “mobilitazione cognitiva”, che potremmo chiamare anche “creatività sociale”. Ma dobbiamo sapere che è una “repubblica immaginaria”, per dirla con Machiavelli, e quindi molto lontana dalla “repubblica effettuale”. Tra le due c’è un salto quantico, non c’è continuità.
Come un elettrone per passare da un’orbita all’altra ha bisogno o di acquisire energia o di perderla, così la trasformazione del partito può avvenire o per un salto in avanti o per una radicale destrutturazione dell’esistente. Bisognerà pensare a come organizzare la transizione. Il tema del congresso del Pd sarà appunto questo: trovare la forza per cambiare, oppure abbandonarsi alla deriva dello status quo.
Nell’epoca della privatizzazione a oltranza, paradossalmente i partiti hanno seguito il cammino opposto della statalizzazione. Ha ragione Piero Ignazi a sottolineare questo processo internazionale, che però in Italia ha avuto una differenza significativa tra sinistra e destra. La prima ha interpretato fedelmente il processo fino a insediarsi nella macchina statale. La destra, invece, ha saputo mantenersi in una posizione anfibia tra la statalizzazione disinvolta nell’uso del potere e l’agitazione della polemica antistale nella società. Il Movimento 5 Stelle è cresciuto fino 25% dei consensi pur collocandosi fuori dallo Stato. Il caso italiano è, per certi versi, un’eccezione rispetto alla tendenza internazionale, ma forse – ripeto – anche una differenza anticipatrice.
Da quando ci troviamo in questa anomalia, a sinistra abbiamo preso il vezzo di classificare come antipolitica e populismo tutto ciò che non rientra nelle nostre categorie di analisi. E non è poco, se tra i consensi raccolti dai due comici – il cavaliere e il vaffaleader – e quelli che non votano si arriva a circa tre quarti dell’elettorato. A noi rimane solo un quarto. Viene da domandarsi se siamo normali noi oppure gli altri. Pensare che la nostra è politica e il resto è solo antipolitica è come andare sull’autostrada contromano dicendo che sono impazziti gli altri automobilisti. No, purtroppo siamo impazziti noi a perdere tempo appresso a Casini con il suo 2% di voti, senza accorgerci del sommovimento elettorale in atto. Chi raccoglie milioni di voti fa politica, non antipolitica.
Come militante sono cresciuto nella periferia romana e da giovane facevo un esercizio mentale per mettermi di buon umore. La sera partivo dalla sede del Partito e andavo sempre in borgata. Lungo la strada, al succedersi dei palazzi collegavo la crescita dei voti a sinistra. Adesso per avere la stessa piacevole sensazione devo fare un’inversione di marcia dalla periferia verso il centro. Da trent’anni perdiamo i voti popolari e conquistiamo consensi tra i ceti agiati. Oggi Parioli è un quartiere rosso di Roma. Questa è la realtà.
E anche quando usiamo la parola populismo in senso spregiativo mostriamo una debolezza inconsapevole, cerchiamo di dimenticare che abbiamo perso il contatto col popolo. Come la volpe che dice che l’uva è acerba quando non riesce a coglie...