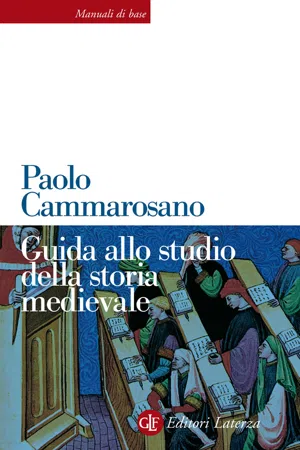1. L’idea di medioevo e lo sviluppo della medievistica
1.1. La formazione dei giudizi di valore
Il medioevo è un’idea, qualcosa che è nella testa delle persone, non fuori di essa. Dire medioevo è diverso da dire Beowulf, la cattedrale di Chartres, o Dante Alighieri. È bene ricordare questo, perché è talmente tradizionale, talmente incardinata nell’insegnamento scolastico e universitario la partizione fra età antica, medioevo, età moderna e contemporanea, talmente numerose sono le cattedre, i corsi di laurea, i centri di studio intitolati al medioevo, che si può rischiare di attribuire un’entità effettiva al medioevo, e di dimenticare che è un concetto.
Ci sono inoltre due difficoltà nella definizione di questo concetto. Più di altre epoche, quella che è stata definita medioevo ha implicato dei giudizi di valore, che sono stati poi prevalentemente negativi, e comunque tali sono nel linguaggio corrente. In secondo luogo, le definizioni di medioevo e l’elaborazione di quei giudizi di valore si sono sdipanate su un lunghissimo arco di tempo, sino in piena età contemporanea, e hanno così recepito visioni della storia e istanze culturali e politiche via via differenti. È per questo che il medievista non può fare a meno di conoscere le età moderna e contemporanea, perché è in queste età che si sono formate tante griglie interpretative sul medioevo, che lo studioso di cose medievali deve decostruire (può darsi invece che modernisti e contemporaneisti possano fare a meno di conoscere il medioevo, e in effetti si ha l’impressione che tale conoscenza sia a volte un po’ difettosa).
Con ciò che si è detto, sia anche detto che non è molto produttivo sforzarsi di rintracciare quando sono apparse precisamente nella storiografia le prime attestazioni di termini come media aetas e simili. D’altronde quando apparvero queste formalizzazioni c’era già una sedimentazione molto lunga, e risalente al medioevo stesso, di modi di visione del passato che suggerivano l’idea di un ordine antico rispetto al quale, a un certo punto della storia, si era verificato un mutamento.
Per quasi tutto il medioevo la connotazione di tale ordine antico era stata dominata da un’ottica, quella del sistema politico, e da un’idea centrale, quella dell’impero. Era l’impero romano, l’impero di Augusto e di Costantino, il fatto che aveva qualificato il passato. Non si deve pensare che fosse un’ideologia libresca, limitata a una ristretta élite di uomini di corte e di letterati. Il problema dell’impero, cioè di una autorità che fosse sovrana su una pluralità di nazioni differenti per lingua e per civiltà, era un problema vitale nei contesti dei movimenti di popolazioni e degli assestamenti etnici che caratterizzarono una gran parte del medioevo.
Rispetto alla situazione dell’impero romano due novità erano intervenute. La capitale era stata traslata da Roma a oriente, a Costantinopoli-Bisanzio. In occidente vi era stata una discontinuità di più di tre secoli della sede imperiale, dalla deposizione di Romolo Augustolo nel 476 alla restaurazione imperiale di Carlo Magno nell’800. Questa restaurazione fu vista dai contemporanei come tale, come il ripristino di un ordine passato; i panegiristi di Carlo Magno ripresero, nel tesserne gli elogi, stereotipi augustei, e vi fu anche chi considerò l’opera di Carlo non una mera restaurazione ma anzi un progresso: secondo Nitardo, l’impresa più mirabile di Carlo era stata quella di avere represso «gli animi feroci e ferrei dei barbari e dei Franchi, che nemmeno la potenza romana era riuscita a domare».
La seconda innovazione rispetto all’ordine imperiale antico era nella definizione cristiana dell’autorità politica, nell’intolleranza di altre religioni e nel ruolo di tutore della cristianità e dell’ortodossia attribuito all’imperatore. Tale ruolo risaliva anch’esso a molti secoli prima di Carlo Magno, risaliva al IV secolo, il secolo di Costantino il Grande e di Teodosio, e dunque non si avvertiva cesura, ma semmai, anche in questo caso, progresso. La cristianizzazione aveva però comportato, fra l’età di Costantino e quella di Carlo Magno, una enorme attribuzione di prerogative temporali e politiche alla Chiesa, in particolare alla Chiesa romana, e questo era stato uno dei principali motivi di distacco fra Roma e Bisanzio. Un testo che avrebbe avuto enorme importanza nel medioevo, la cosiddetta Donazione di Costantino, forgiata nel secolo VIII, dava fondamento giuridico a una sorta di sovranità papale su quella che era stata la parte occidentale dell’impero romano.
Solo verso il Mille si affacciarono, e nuovamente in funzione di una renovatio imperiale (promossa ora nell’elevato ambiente intellettuale che si era formato attorno a Ottone I e ai suoi successori), alcune idee di decadenza rispetto a un buon ordine imperiale antico. Queste idee si collegavano a giudizi negativi sulla moralità dei papi recenti, e ci fu anche un singolare accenno a qualche intervento falsificatorio nella Donazione di Costantino. Furono però episodi circoscritti, e che comunque non concludevano su una effettiva periodizzazione del passato. Un primo, importante scarto si ebbe nel secolo XII. Giuocò adesso la rinascita del diritto romano nelle università e negli stati: quell’imponente organismo, cristallizzato nel Corpus iuris civilis giustinianeo, venne considerato un possibile fondamento comune a formazioni politiche diverse, un sistema parallelo e sottostante alle leggi e alle consuetudini particolari di ciascuna città o territorio. Inoltre l’ambiente imperiale di Federico Barbarossa si specchiò in quella tradizione giuridica per ripristinare l’affermazione di un’autorità imperiale, di una res publica garantita dall’imperatore, che appariva decaduta e che si sarebbe voluta invece di nuovo prevalente sulla miriade dei poteri locali di nobili, prìncipi, città. Molte città, d’altro canto, andavano definendo adesso una propria sovranità pubblica, e in questo contesto si riesumarono termini antichi, con magistrati chiamati consules, e a Roma risuonarono appelli a richiamare in vita una classica e gloriosa istituzione quale il Senato, mentre si denunziava l’attribuzione che il clero si era fatta di prerogative non sue.
Prevaleva comunque sempre, nel secolo XII, un carattere di mitologia retrospettiva rispetto a una qualsiasi periodizzazione delle epoche e a una qualsiasi valutazione sulle modalità del mutamento storico. Lo stesso giudizio si può dare dei tanti richiami all’antico che si ebbero nella cultura e nella politica del Duecento e del primo Trecento. Brunetto Latini, che imperniò il suo ragionare politico su una ripresa ampia e geniale della retorica ciceroniana, disegnò una evoluzione del tutto mitica del vivere civile. Il suo allievo Dante Alighieri, che espresse un giudizio negativo sulle conseguenze della Donazione di Costantino (senza dubitare peraltro della sua autenticità), collocò in orizzonti cronologici di volta in volta diversi (che andavano dalla Chiesa prima di Costantino al buon tempo antico della Firenze del secolo XII) gli inizi di decadimento nella vita ecclesiastica e nei costumi del vivere civile. Anche la contestazione dell’ideologia teocratica e la rivendicazione dell’autonomia del potere imperiale, elaborate da Marsilio da Padova, implicarono solo marginalmente una valutazione periodizzante del passato.
Ma non molti anni dopo le grandi opere di Dante e di Marsilio una convergenza di esperienze politiche, religiose e culturali impresse una svolta più netta verso una denunzia dei tempi presenti e verso una valutazione retrospettiva. Nella lotta politica dei ceti popolari contro lo strapotere delle grandi famiglie nobili, si levò il rimpianto per i «buoni Romani» e la loro «summa iustizia»: Cola di Rienzo, che avrebbe voluto vivere al tempo di quel buon ordine, si immergeva nella lettura di Tito Livio e di altri classici e decifrava le epigrafi che erano «intorno a Roma» sotto gli occhi di tutti, ma che solo i suoi occhi, ispirati dalla passione politica, sapevano leggere. Negli stessi anni, cioè nei decenni centrali del secolo XIV, movimenti religiosi accentuavano la questione della povertà evangelica e denunziavano la ricchezza, e la conseguente corruzione, di una Chiesa che avrebbe tralignato rispetto a un modello primitivo, apostolico, di purezza e mendicità.
L’impulso politico a una bene ordinata res publica e l’impulso religioso a una comunità cristiana povera ed egualitaria convergevano così a formare il sentimento di una cesura fra una buona antichità e una successiva corruzione. Ma fu su un altro versante, letterario e artistico, che l’idea della cesura assunse i suoi contorni più marcati. E ciò accadde perché su questo versante i protagonisti del Trecento e del Quattrocento non videro se stessi coinvolti nella decadenza e sue vittime, ma di se stessi andarono fieri, si considerarono portatori di una novità e di una modernità che traeva forza dal loro genio e, congiuntamente, dalla ripresa e dalla rivitalizzazione di forme antiche. Forme della scrittura, anzitutto. Francesco Petrarca celebrò la littera antiqua, nella quale riconobbe la norma grafica più prossima a quella dei codici dei primi secoli, dei quali egli, come Giovanni Boccaccio e altri grandi, era appassionato ricercatore. Le scoperte dei codici greci e latini nel secolo XIV andarono di pari passo con una volontà di imitazione, ripresa e risorgimento che implicava la rivitalizzazione di modelli letterari, quali ad esempio l’epistola, l’elogio degli uomini e delle donne illustri, il dramma profano. E andò infine crescendo, soprattutto nelle città italiane dalla metà del Trecento in avanti, la ripresa di forme della creazione architettonica e figurativa.
L’attenzione ai monumenti classici e la loro riesumazione non erano mai venute meno, in realtà, nei secoli medievali. Imperatori sassoni e svevi, scultori operanti nelle chiese cattedrali, ricchi cittadini con spirito di collezionismo, avevano concorso a una plurisecolare storia di reimpieghi di spolia in monumenti ecclesiastici e civili e di imitazioni di modelli figurativi romani ed ellenistici. In qualche rarissimo caso si era anche affacciato un giudizio di superiorità di quei reperti della antiquitas rispetto alla «pochezza dei moderni» (modernorum parcitas). Ma è fuori discussione l’eccezionalità di testimonianze del genere, a parte l’assoluta indeterminatezza dei concetti di «antichità» e «modernità» in quei contesti. Ancora alla metà del Trecento, non si può esagerare lo spessore della passione antiquaria del notaio trevigiano Oliviero Forzetta, che nel 1335 ricercò a Venezia, in un manipoletto di codici e altri oggetti pregiati, sculture di teste classiche con ghirlanda e infula, figure di leoni e altri animali e un altorilievo romano con quattro putti. Vero è che questo tipo di collezionismo si andava facendo sempre meno isolato, e che nello stesso periodo il signore di Verona fece riprendere in affreschi alcuni ritratti esemplati su antiche monete e ripristinò una antica statua drappeggiata femminile in una piazza centrale della città. L’aumento quantitativo di simili attenzioni, utilizzi ed esperienze, il suo collegarsi ai movimenti ideologici e letterari, l’accresciuta circolazione culturale, tutto infine condusse a uno stacco, per cui i modelli antichi furono lucidamente contrapposti all’arte barbarica.
Lo stacco, il passaggio dal fatto imitativo e dall’inserimento occasionale al sistematico gusto classicista, divenne nettissimo con l’umanesimo, nel Quattrocento, quando artisti come Jacopo della Quercia e Donatello ripresero e rilessero in una loro autonoma e geniale ispirazione i lineamenti dei volti antichi, e architetti e scultori come Lorenzo Ghiberti, Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti modernizzarono forme classiche dell’architettura e dell’ornamentazione, non senza teorizzazioni importanti sulle arti e sulla loro storia, nelle quali si andò delineando il concetto di un’epoca di mezzo che aveva veduto obliterarsi una grande tradizione antica, risorta adesso finalmente nell’ambito di una «modernità»: il significato tradizionale di modernus nel senso di «recente», «attuale» veniva ad assumere una valutazione positiva, e albeggiava così quella che sarebbe stata la tripartizione scolastica «antico-medievale-moderno».
Ma di pari passo con il senso del distacco dalle culture che erano succedute alla crisi dell’impero romano-ellenistico si sviluppò un’attenzione ad alcuni aspetti di quelle culture stesse. Si cominciò a studiare la lingua dei testi mediolatini, si ripensò quel mondo greco che era stato progressivamente emarginato nella cultura europea occidentale, ma che era pure sopravvissuto per tanti secoli grazie a una struttura politica medievale, l’impero bizantino crollato sotto la pressione turca appena alla metà del Quattrocento, e che nel campo delle arti figurative aveva costituito una lunga cerniera tra antichità e modernità. Tutto questo si svolse nel quadro di un meraviglioso slancio della filologia, intesa sia come restituzione di testi sia come discernimento critico dell’autenticità e della falsificazione. E vi furono importanti collegamenti fra impegno erudito, critica filologica e contestazioni delle falsità che erano state apportate nel medioevo, soprattutto a maggior gloria e potenza della Chiesa di Roma. Lorenzo Valla («il migliore italiano che mai in vita mia abbia visto o sentito», avrebbe avuto occasione di dire Martin Lutero), contestualmente all’impegno nel ripristinare la lingua e la cultura latina classica contro le corruzioni di «Goti e Vandali», dimostrò nel 1440 la falsità della Donazione di Costantino in maniera inconfutabile, anche se ci sarebbero voluti un paio di secoli perché tale inconfutabilità fosse da tutti riconosciuta.
Si era così formata entro la metà del Quattrocento, e si sarebbe evoluta su tutto l’arco del secolo, una serie di parametri di giudizio sulla letteratura e l’arte, la politica e la relazione tra Chiesa e potere politico, la moralità ecclesiastica, che suggeriva una visione del passato per individuarvi gli inizi dei decadimenti, sempre in funzione, come era stato nei secoli precedenti, di una auspicata «riforma».
Quando la «riforma» si realizzò, con l’esito della lacerazione della cristianità innescata dalle tesi luterane, ciò comportò una rilettura giudicante della storia passata del cristianesimo, chiarì ed esasperò i giudizi che da tempo erano stati portati sulla deviazione romana dal cristianesimo delle origini, e si concluse da parte protestante in una visione del papato e di componenti tradizionali della religiosità cristiana (il culto dei santi e delle reliquie, i pellegrinaggi) come di cosa del demonio. Era però da chiarire in quale momento della storia il demonio fosse intervenuto. Negli scritti di Lutero i riferimenti alla storia non hanno carattere sistematico, sono sempre occasionali e dispersi, con rari accenni a una periodizzazione di massima. Certamente egli considerò sotto una luce positiva non soltanto l’epoca delle origini cristiane, ma tutta una lunga fase che includeva i padri della Chiesa, Agostino in particolare, e i primi concili, fra i quali nominò più di una volta il Niceno del 325. Le più atroci corruzioni della Chiesa, cioè la rapacità del papa e dei cardinali, il mercimonio dei benefici ecclesiastici, la spoliazione delle risorse della Germania e di tutte le terre cristiane a beneficio di Roma, che discendeva dall’autoattribuzione romana della collazione dei benefici, tutto questo era cosa dei due secoli precedenti Lutero, come in quel passato relativamente recente si inserivano l’ingiusta condanna di Giovanni Hus e le ingiuste lacerazioni inflitte da Roma al tessuto della cristianità.
Ma senza dubbio i danni erano cominciati prima. In un luogo della Cattività babilonese della Chiesa (1520) Lutero scrisse, a proposito del sacramento dell’eucaristia, che la vera dottrina era persistita nella Chiesa per milleduecento anni, e che gli errori erano apparsi trecento anni prima, su questa come su altre questioni della fede: si riferì dunque alla teologia scolastica, a san Tommaso, e a più riprese avrebbe condannato, nei suoi scritti e nei suoi discorsi, il grande dottore del Duecento e l’opera del pagano Aristotele che costui aveva celebrato. In realtà anche tutto il diritto canonico, elaborato tra l’XI e il XII secolo, venne respinto da Martin Lutero come una mutazione perversa della retta cristianità dei primi secoli, e altri importanti riferimenti – al divieto di matrimonio dei chierici, alla separazione dalla Chiesa greca, al rapporto feudale tra papato e regno di Sicilia – riconducevano in una luce negativa tutta l’età della riforma gregoriana, anche senza una esplicita qualificazione cronologica. Di più: Lutero rievocò in più luoghi la fine dell’impero romano a opera di Goti e Longobardi,...