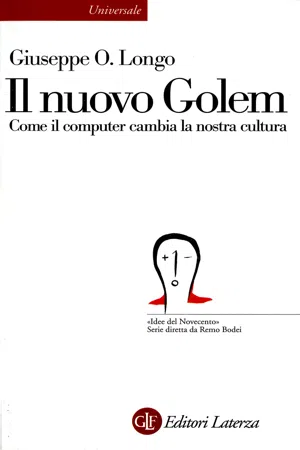Capitolo quarto. Società, senso e storia
4.1. L’informatica e la scuola
La scuola si trova, oggi più che mai, in una situazione contraddittoria, che genera disagio negli insegnanti e negli allievi. Da una parte la scuola è, o dovrebbe essere, una sorta di organo di riproduzione della società, l’organo che, trasmettendo la cultura da una generazione all’altra, garantisce la continuità e la stabilità: con la scuola la società tende a conservarsi nel tempo, evitando fluttuazioni troppo rapide e dirompenti. D’altro canto la scuola interagisce con la società di cui fa parte, ed è sollecitata a incorporare e a trasmettere le novità e le sollecitazioni culturali che nascono e si propagano nella comunità e, soprattutto, a rendersi utile allo sviluppo (specie economico) della società.
La questione di fondo diviene allora: deve la scuola opporsi (quasi per principio o per vocazione) alle perturbazioni culturali esterne, adottando una serie di filtri e di circoli di retroazione negativa che smorzino le novità e tendano alla conservazione, accettando solo le innovazioni collaudate e di lungo periodo; oppure deve innestarsi in presa diretta o quasi sulla società, adottando, o almeno non inibendo, una serie di amplificatori e di circoli di retroazione positiva, per favorirne le tendenze?1
In altri termini: che rapporto c’è, o ci dovrebbe essere, tra scuola (o cultura) e produzione, tra scuola e mercato, tra scuola ed economia? Questa domanda coinvolge il rapporto tra etica, estetica e pragmatica e solleva quesiti formidabili che certo non possiamo risolvere qui, e nemmeno affrontare in modo articolato. Resta tuttavia il fatto che in un momento di rapida innovazione (soprattutto tecnica) come quello attuale la scuola si trova sottoposta a tensioni fortissime: gli scricchiolii che si levano dalla sua veneranda struttura possono preludere tanto a un rinnovamento fecondo quanto a un collasso e a una piena incorporazione della scuola nei meccanismi produttivi della società (fatta salva la possibilità di un recupero culturale attraverso istituzioni vicarianti come scuole private, accademie e circoli culturali esclusivi).
Le difficoltà in cui si dibatte la scuola sono state acuite negli ultimi decenni dalla rapidità con cui si è evoluta e si evolve la cultura nel senso più ampio del termine, dunque anche la cultura scientifica e tecnica, in particolare la tecnologia dell’informazione, dai calcolatori alla televisione ai telefoni cellulari alle reti. Non è la prima volta nella storia che gli strumenti imprimono una svolta e una spinta all’evoluzione sociale e culturale: basti pensare all’introduzione della scrittura e all’invenzione della stampa. Ma è certo la prima volta che questa evoluzione è così rapida e quasi dirompente (vedi § 1.3). La cultura è divenuta pletorica e frammentaria, rifiuta l’apprendimento o lo rimanda a momenti ulteriori nell’illusione di potersi sempre documentare in una banca dati inesauribile. La rete non è soltanto una struttura materiale e informazionale che serve alla trasmissione e alla distribuzione dei dati: è anche una metafora della cultura contemporanea, una cultura priva di organizzazione e di struttura gerarchica forte, che ha sostituito l’apprendimento con la documentazione, lo studio con la consultazione, e che sta estroflettendo anche la memoria individuale di lavoro, quella che sta alla base delle nostre elaborazioni più elementari e quotidiane (il linguaggio, la lettura)2.
È cambiata la nostra visione del mondo, la nostra epistemologia. Secondo alcuni, stanno cambiando la nostra psicologia e la nostra stessa fisiologia (pare che le persone che fin dall’infanzia guardano molto la televisione abbiano una corteccia visiva più sviluppata della norma, a scapito forse dello sviluppo di qualche altra area cerebrale) e ci avviamo forse a un’integrazione, a una simbiosi con le macchine informazionali, che assume i caratteri di una svolta biotecnologica (vedi § 1.4). La facilità e il costo quasi nullo della comunicazione comportano uno scambio frenetico di messaggi intersoggettivi, che si affiancano ai messaggi intrasoggettivi producendo un nuovo luogo comunicazionale collettivo.
La scuola non può non essere toccata da questa rivoluzione. Il libro e la penna, strumenti classici dell’istruzione, vengono affiancati da altri dispositivi, che influiscono sulla lingua, sulla comunicazione, sull’espressione. Alla scrittura, lineare e rigorosa, si affianca l’immagine, che rafforza la percezione gestaltica e parallela e che corrisponde forse a un ritorno a tradizioni antiche, a lungo represse o dimenticate dalla nostra civiltà. E gli insegnanti, che si sono formati sui libri, si trovano a dialogare con allievi che sono cresciuti alla scuola della televisione e del computer: ciò provoca disagio, riprovazione, incomprensione, indifferenza, a volte ostilità. La povertà linguistica dei giovani, spesso denunciata dagli insegnanti, è in parte dovuta a questo ritorno dell’immagine: alla lingua tradizionale si affianca questa nuova e robusta lingua iconica, con i suoi codici e le sue convenzioni di rapidità e immediatezza. Si passa (o si ritorna) dalla serialità al parallelismo (cfr. nota 14 al cap. terzo).
Nei confronti dell’immagine c’è una lunga tradizione di sospetto e di diffidenza. Già Goethe, in un tempo in cui il trionfo attuale dell’immagine era di là da venire, dichiarava: «A che serve dominare la sensualità, coltivare l’intelletto, assicurare alla ragione la sua supremazia? La forza dell’immagine è in agguato. Come il più potente nemico essa possiede per sua natura una tendenza irresistibile all’assurdo, la quale, vincendo ogni costrizione della cultura, riemerge con l’innata crudezza dei selvaggi che amano le smorfie». Un nemico da esorcizzare o da sconfiggere, dunque.
Ma chi nasce nella società dell’immagine, della realtà virtuale, della multimedialità, come percepisce questo profondo contrasto con i mezzi espressivi classici? Non certo come lo percepisce chi si è formato nella cultura tradizionale. E la scuola avverte questo contrasto, vive la crisi di passaggio tra parola e icona: si chiede quale strada seguire e la perplessità è accresciuta dalla rapidità con cui accadono le cose. La nozione tradizionale di generazione è sfumata e sta per scomparire in un tumulto di percezioni e sensazioni vaghe, indeterminate, in cui si accavallano tutte le età, tutti gli strumenti, tutti i segni, tutte le informazioni.
L’ambiguità di fondo in cui vive la scuola, fra tradizione e rinnovamento, è diventata acuta nella nostra epoca anche per un altro motivo, legato ancora alla tradizione scientifica e tecnica dell’Occidente, che tanto spazio concede alla riflessione razionale, alla simulazione e all’indagine preventiva sui fenomeni e sui problemi. Questa propensione all’analisi si accompagna al desiderio, o alla pretesa, di prevedere l’evoluzione dei fenomeni e di indirizzarne il corso con interventi mirati. La premessa, sovente non dichiarata, su cui si regge questo desiderio è che la realtà conoscibile (ad esempio la realtà scolastica) sia indagabile fino in fondo, senza residui, con gli strumenti della razionalità e di conseguenza sia controllabile mediante le nostre azioni.
Questa ipotesi sulla nostra potenziale onniscienza, e conseguente onnipotenza, non è sostenibile: non solo viene smentita dalla vita quotidiana, che appare intrecciata di eventi imprevedibili e incontrollabili, ma anche dagli sviluppi più recenti delle scienze esatte. Nella scienza di oggi si fa strada, rispetto alle concezioni ottocentesche, una visione meno ambiziosa: non più leggi esatte, eterne e universali, sono quelle che la fisica cerca e scopre, bensì leggi statistiche, nelle quali dunque trova posto un certo grado ineliminabile di incertezza e di approssimazione. L’universo è un sistema in evoluzione, immerso in una storia irreversibile e imprevedibile, in cui trovano spazio l’instabilità, la contingenza e il caos. La complessità dei fenomeni comporta una loro sensibilità estrema alle condizioni iniziali, nel senso che una piccola variazione dello stato di un sistema può causare cambiamenti enormi nella sua evoluzione (il cosiddetto «effetto farfalla», cfr. nota 6 al cap. primo).
Dunque le previsioni sull’andamento dei fenomeni complessi sono difficili, e le previsioni a lunga scadenza sono impossibili. E il sistema scuola-società è di certo un sistema complesso. Eppure le decisioni vanno prese e anche non prendere decisioni, in fondo, è una decisione. Quindi ci troviamo nella necessità di agire senza poter calcolare la portata delle nostre azioni. Le nostre capacità limitate di simulazione e di previsione ci possono indurre a prendere decisioni che, in quel momento, ci appaiono utili o necessarie ai nostri scopi ma che, alla lunga, possono portare a conseguenze indesiderate. A questa situazione, imbarazzante e per certi versi frustrante, ci si deve adattare: in un certo senso «il mondo è fatto così» e dobbiamo accettare un grado più o meno elevato di incertezza e di approssimazione. Questa è, credo, la lezione etica più importante della nostra epoca (e forse è proprio questa l’essenza del postmoderno).
Per converso, le conseguenze delle nostre azioni, anche se imprevedibili, si esplicano nella loro interezza e possono essere irreversibili: questa consapevolezza provoca un certo disagio se non angoscia, soprattutto perché sono caduti molti dei valori tradizionali che ci sorreggevano e confortavano nelle decisioni: non c’è nessuno che, da una posizione privilegiata di saggezza e bontà, ci indichi il cammino da percorrere. Orfani di queste guide benigne, dobbiamo assumerci tutta la nostra responsabilità, o al massimo delegarla alle nostre macchine (vedi § 1.3). Non ci è più concesso il senso di rassicurante e struggente rassegnazione (o letizia) con cui un tempo si accettavano le conseguenze del nostro agire.
D’altra parte, se fosse possibile procedere a un’analisi esauriente e prendere le decisioni ritenute corrette in vista di un controllo completo dei fenomeni, vi sarebbe un altro rischio, quello della rigidità. Un sistema complesso è caratterizzato da un certo numero di variabili tra loro interconnesse e più o meno importanti rispetto alla sopravvivenza e al benessere del sistema. Ciascuna variabile ha una soglia di tolleranza inferiore e una superiore e se, ad esempio per effetto di una perturbazione esterna, esce da questo intervallo di tolleranza, il sistema comincia a manifestare sofferenza e patologia. Se la variabile è molto importante, il sistema può giungere anche al collasso e alla morte. Molti sistemi (per esempio gli organismi biologici, ma anche le società) sono stabili, cioè dopo una perturbazione ambientale tornano più o meno rapidamente a uno stato di equilibrio. La stabilità di questi sistemi è dovuta alla presenza di circuiti di retroazione negativa che conferiscono loro forti caratteristiche omeostatiche, cioè autoregolative.
In altre parole, una perturbazione esterna, se non è troppo forte, cioè tale da distruggere il sistema, provoca una variazione dei valori delle variabili, le quali, dopo una serie di oscillazioni smorzate, tornano ad assumere valori compatibili con la sopravvivenza del sistema, cioè interni ai loro intervalli di tolleranza. Nel periodo transitorio, e poi nel nuovo regime stabile, le variabili meno importanti si modificano in modo da mantenere costanti i valori delle variabili più importanti. Tuttavia, se i valori di alcune variabili meno importanti vengono fissati e non possono modificarsi, può accadere che le variabili essenziali, sotto la spinta della perturbazione, subiscano variazioni eccessive, incompatibili con la conservazione del sistema. Per usare un esempio caro a Gregory Bateson, l’acrobata che non possa cambiare la posizione dell’asta rischia di cadere, cioè non può mantenere la sua variabile vitale «cammino sopra la corda» entro i limiti compatibili con la propria sopravvivenza.
Se una variabile è costretta ad assumere un valore prossimo a uno dei suoi limiti di tolleranza, se cioè il sistema è «alle strette» rispetto a questa variabile, diremo che il sistema manca di flessibilità sotto questo profilo. Siccome le variabili sono interconnesse, se una certa variabile è alle strette di solito le altre non possono modificarsi senza esercitare una pressione su quella variabile: dunque la perdita di flessibilità si diffonde per tutto il sistema, nel senso che tutte le variabili tendono ad assumere valori fissi: il sistema diviene rigido. In casi estremi il sistema accetta solo quei mutamenti che portano a una modifica delle soglie di tolleranza della variabile sofferente (una società sovrappopolata ricerca quei mutamenti, ad esempio un aumento della produzione alimentare, che possono rendere più accettabili le condizioni di sovrappopolamento, le quali tuttavia restano patologiche e patogene). Queste modificazioni ad hoc, proprio perché rendono tollerabile una patologia senza eliminarla, alla lunga possono portare a patologie ancora più fondamentali.
Una normativa troppo precisa, che voglia prevedere tutti i casi possibili e dare ricette per la soluzione di tutti i problemi, non fa altro che fissare entro soglie molto anguste le variabili del sistema, sottraendogli quasi tutta la flessibilità con l’impedirgli quasi tutti i cambiamenti. I sistemi complessi, soprattutto quelli che comprendono gli esseri umani, hanno grandi riserve di flessibilità, che non vanno congelate con una normativa troppo stretta. Ecco perché, tornando alla scuola, può essere disastroso volerne pianificare a priori il funzionamento in tutti i particolari: cercare le risposte a tutte le possibili domande, prevedere tutte le reazioni a tutti i possibili comportamenti, fissare i programmi in tutti i dettagli, insomma razionalizzare integralmente. Anche certe impostazioni riduzionistiche, che rischiano di diventare stereotipate e abitudinarie (ad esempio il ricorso ai modelli offerti dalla neurobiologia di base, la delega di funzioni e decisioni alle macchine informatiche, la ricerca delle soluzioni di tipo algoritmico o più in generale deterministico), possono portare il sistema alla sclerosi per esaurimento della flessibilità.
È forte, vista la nostra miopia e la nostra tendenza alle azioni finalizzate, la tentazione di adottare soluzioni che offrano vantaggi a breve scadenza. Ma non solo le conseguenze di queste soluzioni sono spesso irreversibili, come ho già accennato: anche i comportamenti e gli atteggiamenti psicologici corrispondenti divengono abituali e difficili da sradicare. La perdita di flessibilità del sistema si accompagna a una perdita di flessibilità delle idee. È raro che le abitudini mentali vengano sottoposte a un esame critico: esse tendono a divenire premesse indiscusse da cui discendono altre idee, che ne ereditano in parte l’inflessibilità. Certo, a noi piacerebbe avere un programma di calcolatore (o qualche altro deus ex machina) che con un colpo di manovella o con la pressione di un tasto fornisse le risposte a tutti i nostri problemi... ma, in un mondo in continuo e tumultuoso cambiamento, questo ente o programma sarebbe l’incarnazione nefasta di una rigida e pericolosissima abitudine.
Molto spesso i vantaggi a breve scadenza su cui si misura l’azione corrispondono all’accrescimento di certi parametri. Si tenta cioè di rendere massimo il valore di qualche variabile singola: il rendimento scolastico, l’abilità nell’uso del calcolatore, l’uniformità disciplinata del comportamento e via dicendo. Orbene, qualunque variabile, anche la più utile e positiva, oltre un certo valore diviene tossica. Le variabili dovrebbero avere un valore «giusto», cioè restare entro i limiti di variabilità compatibili con la salute e il benessere generale del sistema. Quando il sistema ha perduto troppa flessibilità (perché certe variabili sono state fissate rigidamente oppure perché si tenta di aumentare a dismisura il valore di qualche variabile), ogni sollecitazione esterna o interna può essere fatale. Il sistema non può affrontare nessuna emergenza. Queste considerazioni non valgono solo per la scuola, ma anche per altri settori della società e per la società nel suo complesso.
Un altro punto fondamentale riguarda l’insegnamento, cioè la pratica conversativa, cognitiva e attiva che accomuna insegnanti e scolari nel lungo viaggio dell’«istruzione» (viaggio che in realtà non termina mai). L’insegnamento è un processo comunicativo dinamico, pertanto rientra a tutti gli effetti nelle considerazioni generali relative alla comunicazione.
L’universo della comunicazione, per sua natura, è impervio al riduzionismo. In esso è importante considerare, accanto ai messaggi scambiati, i contesti di questi messaggi e i messaggi che qualificano i messaggi e i contesti (vedi §§ 3.2 e 3.4). L’informazione, il significato, la forma e la struttura si creano e si evolvono nel complicato e mutevole rapporto tra chi parla e chi ascolta. In questo rapporto sono importanti i messaggi scambiati, ma anche le emozioni e le coloriture affettive, che gli insegnanti, come i bambini, sanno cogliere e apprezzare perché sono, prima di ogni altra cosa, esseri umani e quindi posseggono un bagaglio innato di capacità comunicative che, tranne nei casi patologici, dopo la nascita viene esercitato e affinato nelle interazioni con l’ambiente e con gli altri. Queste capacità condivise consentono interazioni quasi sempre soddisfacenti, almeno all’interno della stessa area culturale, senza che sia necessario codificarle e analizzarle troppo a fondo.
Certo, una competenza specialistica può essere utile per evitare certi errori grossolani, ma sono abbastanza convinto che due esseri umani in genere riescano a conversare, passandosi informazioni, significati, nozioni ed emozioni, purché sia stato aperto il canale della simpatia e dell’attenzione. Forse questo è il compito più delic...