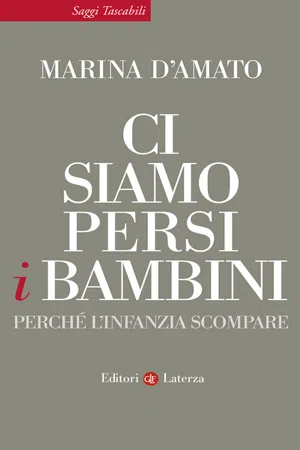1. I bambini sono sempre esistiti, l’infanzia no
Una presenza incerta
I bambini sono sempre esistiti, l’infanzia no. Ci vuole un’idea, perché senza un’idea di infanzia, l’infanzia non c’è. Viva come concezione nella nostra cultura prevalentemente quando si propone nei suoi tratti problematici – calo demografico, violenza, disaffezione scolastica... – l’infanzia viene di solito pensata per la sua atipicità o per i suoi rapporti con il mondo adulto, ma comunemente ignorata nella sua specificità.
Genericamente considerata come preistoria individuale, come momento esistenziale al quale rendere testimonianza, o luogo “altro” da cui si proviene, che cos’è l’infanzia oggi?
In passato il termine infanzia è stato utilizzato per identificare il periodo della vita che va dalla nascita all’utilizzo della ragione. Oggi si tende ad articolare l’infanzia in almeno tre fasi: la prima va dalla nascita ai due anni; la seconda, dai tre ai cinque; la terza dai sei ai dieci. A partire da questa età i bambini vengono sempre più spesso definiti “ragazzi”.
Appare evidente, però, che l’infanzia non può essere prigioniera di definizioni parziali che non ne colgono l’identità complessiva di mondo, di condizione: sia che essa esista come momento esistenziale cronologicamente definito, sia in relazione al mondo adulto, che di volta in volta la identifica in funzione di un rapporto affettivo, filiale, istituzionale, legale, normativo anziché come una condizione sociale permanente di ogni comunità umana. La nostra cultura, inoltre, è andata sempre più definendo il mondo dei bambini come una proiezione e/o una dipendenza di quello adulto.
Solo a partire dalle indagini psicologiche e sociali degli anni Sessanta del secolo scorso è stato accordato all’infanzia uno statuto a sé stante, in base al quale i bambini devono essere considerati nella loro individualità, rispettati in quanto esseri unici e soggetti di diritti (Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989).
La sociologia si è interessata soprattutto dei bambini a scuola, delle relazioni parentali, dei problemi relativi alla socializzazione, trascurandone troppo spesso la condizione di gruppo a sé stante, di categoria permanente della società.
La psicologia, dal canto suo, si è servita frequentemente dell’infanzia ritenendola in molti casi indispensabile per spiegare problematiche del mondo degli adulti.
Anche la pedagogia, a ben guardare, trova il suo fondamento all’interno di un progetto dei “maggiori” nei confronti dei “minori”, di cui chiede il coinvolgimento nel costruire le basi della società futura, lasciando inesaminata la condizione del presente.
La letteratura ha per lo più raffigurato l’infanzia come un mondo “rimpicciolito” rispetto a quello dei grandi di cui condivide le dinamiche, caratterizzato da un senso morale e da uno stato di innocenza ancora intatti che funzionano come rimando mitico per la coscienza e la sensibilità adulta.
La pittura, fra le arti, è quella che più di ogni altra li definisce come sintesi e metastoria del loro tempo. Un esempio per tutti: il dipinto di Bruegel Giochi di bambini (1560), in cui circa trecento bambini giocano senza alcun adulto che li sorvegli. Visto da lontano, il quadro è inquietante: sembra quasi che i bambini, lasciati a sé stessi, non abbiano altra capacità che quella di rompere le regole.
I media – soprattutto la televisione – rinviano a una rappresentazione dell’infanzia che gravita intorno a sentimenti di regressione emotiva o a stati d’animo di incertezza e paura. I bambini vengono infatti proposti come simboli in cui identificare gli ideali o come strumenti attraverso i quali veicolare l’autenticità di prodotti e di oggetti da vendere. In altre parole, vengono utilizzati mediaticamente per re-incantare un mondo disincantato.
Nella nostra società contemporanea, insomma, prevale un’immagine dell’infanzia come presenza nei suoi aspetti fungibili dal mondo dei grandi. I bambini sono presi in considerazione come figli oppure per quello che saranno e non per ciò che sono ora, trascurati dagli interventi di politica culturale, urbanistica e sociale, ma sono riconosciuti in funzione del mantenimento di virtù e valori di cui si piange il declino e dei quali ci si fa promotori.
Così l’epoca in cui viviamo si è sviluppata attorno a un sistema simbolico che fa appello a una precisa subcultura puerocentrica e a modelli consumistici che da un lato riflettono il disconoscimento dei bambini “veri” e, dall’altro, la forza delle immagini infantili. Si tratta di posizioni ambivalenti che vanno dall’autonomia alla dipendenza del bambino e rimettono in questione soprattutto il modello di cultura dell’infanzia che presuppone un bambino esploratore del mondo, come un buon selvaggio, e individuo sociale semplicemente perché maggiormente esposto al contatto. Oggi si chiede al bambino di esplorare il mondo al fine di potersi adattare a una società in rapida trasformazione, che esige di essere aperti e disponibili nei confronti di qualsiasi modello di comportamento, che esalta un progresso illimitato sia delle opportunità materiali, sia soprattutto della realizzazione di sé.
Importante, oggi, sembra essere non la finalità del viaggio, né l’obiettivo da raggiungere, né lo scopo per cui intraprenderlo, ma il viaggio in sé stesso: il bambino deve svilupparsi per rendersi autonomo nel più breve tempo possibile, e in conformità all’ambiente mutevole in cui vive.
Un’assenza antica
È l’idea di pudore che mette al mondo l’infanzia. Questa si afferma con la crisi del paganesimo e con il diffondersi della cultura cristiana in Occidente.
Se nel mondo greco l’infanzia è un tempo senza severi margini cronologici, che comprende un lungo tratto dell’esistenza umana, intorno al quale tuttavia si consolidano molte teorie educative, è la civiltà romana, meno solare e piena di contrasti, che considera per prima l’infanzia un mondo a parte, separato dal mondo adulto che detiene le prassi e i segreti della sessualità. È proprio il non accesso a questo segreto che dà un luogo e un tempo all’infanzia, riconoscendola nella sua specificità e complessa alterità: con la scuola si definisce il tempo dei bambini, quello necessario per imparare a diventare grandi.
La caduta dell’impero romano rompe questo equilibrio. Nell’assenza di forme di scolarizzazione (l’organizzazione della cultura e dell’istruzione vanno in crisi) e nella perdita di ogni stabilità economica e politica, età adulta e infanzia si riconfondono tra loro, la prima impotente a stabilire il proprio primato sull’altra, perché alla stessa maniera illetterata.
Nella cultura orale del Medioevo è la capacità di comunicare che distingue le due condizioni: quando un bambino è in grado di controllare il linguaggio e, per la Chiesa, di distinguere tra bene e male, è da considerarsi adulto (a sette anni si può già guadagnare l’inferno!).
Del resto l’infanzia era costituita da pochi anni di vita incerta e quando il bambino non aveva più bisogno delle cure materne, entrava a pieno diritto a far parte del mondo adulto. Verso i sette anni, con quella che veniva definita l’età della ragione, poteva già raggiungere una parziale indipendenza economica, ma rimaneva in famiglia per un periodo che variava in relazione alle condizioni economiche, fino a quando c’era bisogno del suo apporto.
L’infanzia diventa protagonista di un processo educativo diffuso con la fine dell’impero bizantino e la caduta di Costantinopoli (1453 d.C.).
L’uscita dal buio che si compie nei secoli successivi a partire dalla metà del Quattrocento, il benessere conquistato e il definirsi della società in senso culturale con la scoperta della stampa, ridanno all’infanzia una connotazione precisa: è il sapere che la divide dal mondo adulto. Saper leggere e scrivere è la chiave di accesso alla comunità dei grandi.
Questo processo, già iniziato nei due secoli precedenti ad opera di chierici o laici che praticavano nelle loro case l’arte di insegnare le lettere, si trasforma radicalmente. Non si tratta più di case-botteghe come per le arti meccaniche. Questo tipo di maestri, dopo l’anno Mille, stabilivano un vero e proprio contratto notarile con i loro discepoli (una sorta di variazione laica dell’antica oblazione al convento), in cui si definiva che cosa il bambino doveva apprendere, per quanto tempo e in cambio di quanto denaro. In queste primissime scuole, si cominciava dalla didattica del leggere e scrivere (pueri de tabula) e si passava poi al latino per quelli più capaci (pueri latinantes). I testi erano costituiti dal salterio, e poi dalla grammatica e da libri di morale (disticha Catonis), da leggere si offriva Esopo, Boezio, Agostino. È solo con il Rinascimento che nasce la grande età pedagogica, in cui pur non accantonando l’esperienza religiosa, i laici e i chierici contribuiscono al processo di laicizzazione dell’istruzione e della cultura.
Il Rinascimento si caratterizza infatti, tra la metà del Trecento e la metà del Cinquecento, soprattutto per l’educazione e per la scuola. Con la riscoperta della cultura ellenistica si afferma anche la centralità del bambino. Ne è un esempio importante lo Spedale degli Innocenti a Firenze, primo luogo al mondo pensato per accogliere fanciulli abbandonati (la prima bimba accolta nel 1496 si chiamava Agata Esmeralda). Fu progettato da Brunelleschi, che lo concepì in funzione dei bambini realizzando le logge delle stanze a loro misura e mettendoli quindi al centro di un nuovo universo.
Quando dall’intreccio della cultura medievale cristiana e di quella classica nasce la civiltà moderna, i bambini diventano uno strumento per diffondere il nuovo e in questo scenario si osserva una partecipazione sempre più intensa alla cultura da parte del ceto aristocratico.
Prima i nobili venivano fin da piccoli addestrati esclusivamente alle armi, adesso l’educazione – con la riscoperta del mondo antico – fa perno sulla ginnastica, più vicina al gioco sportivo e non esclusivamente finalizzata alla preparazione militare. Il progresso delle conoscenze scientifiche, con la diffusione della stampa, impone nuovi testi destinati alle scuole. Con le città, governate da aristocrazie o da signori feudali (comune corporativo o signoria borghese), si afferma il ceto mercantile, che ha sempre più necessità di formare le giovani generazioni. Nell’Italia dei comuni esistono tre tipi di scuole: ecclesiastica, comunale e privata. Sono presenti in tutte le città; e a Firenze verso la metà del Trecento su 80.000 abitanti – scrive Villani – “tra otto e diecimila fanciulli e fanciulle stavano a leggere”, cioè più del 10% dell’intera popolazione.
Nell’Europa del XVI e XVII secolo si reinventa un’infanzia il cui spazio è la scuola, dove bambini che non sono più considerati adulti miniaturizzati, ma semplicemente immaturi, diventano adulti una volta istruiti.
A partire dal Seicento, si riconoscono i bambini in quanto tali, si cerca per loro un abbigliamento particolare e sono guardati anche come fonte di svago e di distensione per gli adulti. Iniziano in questo periodo anche le preoccupazioni per la fragilità psichica oltre che fisica del bambino, e perciò si rivela necessario cercare di proteggerlo.
I due secoli che vanno dalla metà del Cinquecento alla metà del Settecento, e che nella storia europea meritano il nome di età moderna, in Italia diventano un’età retriva per quanto riguarda l’infanzia, perché istruzione e scuola saranno prevalentemente sottomessi al controllo della Chiesa cattolica. Il sistema educativo, così come la vita culturale e politica, di fatto era ispirato ai canoni espressi dal concilio di Trento (1545-64) e trovò il suo modello nella ratio studiorum dei gesuiti (1586). Mentre in Europa la riforma protestante porterà con sé la necessità di istruirsi perché tutti possono e devono interpretare la parola di Dio e per farlo devono essere messi in grado di leggerla, in area cattolica e in Italia in particolare, dove l’interpretazione delle Scritture è riservata al clero, le plebi urbane e contadine rimangono per lo più masse subalterne da catechizzare e da acquietare con un po’ di assistenza e beneficenza, elargita affinché nulla cambi nei rapporti sociali. In qualche modo l’indottrinamento e il catechismo costituiscono la risposta cattolica alla sottolineatura del libero arbitrio di stampo protestante, arrestando nei fatti il libero accesso alla lettura e alla scrittura.
Per due secoli il controllo ecclesiastico, che tendeva a servirsi del potere dello Stato come del suo braccio secolare, non si attuò solo con il tribunale dell’Inquisizione e con l’indice dei libri proibiti, ma soprattutto si espresse nelle scuole. L’ordine dei gesuiti si dedicò soprattutto alla formazione dell’infanzia aristocratica e dei ceti borghesi e gli altri ordini ecclesiastici si impegnarono nell’educazione dei bambini delle classi popolari. Ad essi veniva offerto il catechismo perché ogni altra idea “filosofica” appariva pericolosa. Era il tempo, non dimentichiamolo, in cui ogni ricerca scientifica veniva sottoposta alla verifica di una sua concordanza con la Bibbia: il caso di Galileo a questo riguardo è emblematico.
L’indottrinamento del popolo era quindi la finalità essenziale dell’istruzione, fatta di prediche morali e di dogmi teologali. Solo i laici dei ceti privilegiati ricevevano fin da piccoli un’istruzione elementare privata per potere accedere ai “ginnasi pubblici”, dove era comunque obbligatorio l’insegnamento della teologia. I gesuiti ebbero un ruolo fondamentale nell’educazione perché riorganizzarono l’educazione tradizionale con un curriculum minuziosamente predisposto nei contenuti e nei metodi, in cui non mancavano, accanto a grammatica, retorica, poetica e filosofia, gli insegnamenti matematici e scientifici. Lo scopo evidente della loro educazione era di “imprimere insieme con le buone lettere la pietà dell’animo”. Dalla metà del Cinquecento alla metà del Settecento gli studi saranno dominati dalla presenza di questa didattica e disciplina. In quel tempo nascono anche le congregazioni di suore maestre (Rosa Venerini a Viterbo e Lucia Filippini a Montefiascone), che danno vita alla regola delle scuole “della dottrina cristiana delle zitelle” (1704). Questa dottrina riguardava la formazione delle suore maestre e la loro funzione educativa, indirizzata prevalentemente alle bambine che dovevano “abilitarsi nei lavori manuali” con la missione di “far scuola con profitto delle fanciulle”. Il loro insegnamento era gratuito e la loro didattica fondata su domande e risposte e sull’apprendimento a memoria.
Rinasce così il concetto di educazione, di formazione del bambino perché sia adeguatamente preparato per la vita adulta. Le nuove istituzioni educative, la scuola in particolare, hanno un ruolo determinante nel sottrarre i fanciulli al mondo degli adulti e nel “riempire” lo spazio concettuale dell’infanzia.
Alterne vicende, che concernono soprattutto l’egemonia dei gesuiti nell’ambito dell’insegnamento e, per contrapposizione, fanno emergere una concezione illuministica, predispongono all’idea dell’universalità e della laicità dell’insegnamento che escluse i sacerdoti non fedeli allo Stato, inserendo i laici nelle scuole pubbliche.
È grazie a Napoleone che nel Regno d’Italia la scuola primaria fu aperta anche alle bambine. Sebbene nel nostro paese lo sviluppo industriale non fosse in alcun modo paragonabile a quello di altre nazioni, come l’Inghilterra – ove si può affermare che la scuola pubblica nasce contemporaneamente alla rivoluzione industriale –, la statalizzazione dell’istruzione significò l’avvio di riforme interne alla scuola, ma anche la nascita di un’istruzione tecnica e professionale, sulle ceneri dell’antico apprendistato corporativo.
Il cambiamento avvenuto nella considerazione dell’infanzia e la sua identificabilità con la scuola stimolarono una trasformazione anche nella famiglia, perché se l’istruzione assolveva il compito culturale, i genitori assunsero la funzione di sovraintendere alla sfera morale, etica e religiosa.
Da allora, i primi anni di vita hanno acquisito sempre più centralità al punto che si parla, a proposito ...