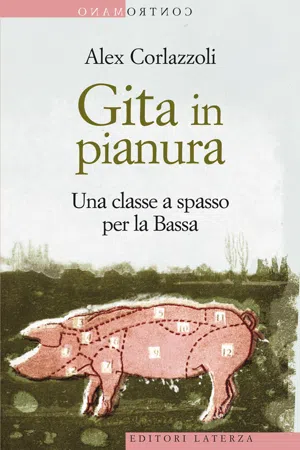In cascina
“Mi chiamo Danvir, ho sette anni, sono dell’India e abito alla cascina Albera. Sai dov’è, maestro?”.
“Io mi chiamo Payal, ho nove anni. Mia sorella è già stata tua alunna, ti ricordi? Casa mia è alla Fiorita, dove ci sono i maiali”.
“Ciao. Sono Surya, ho otto anni e la mia casa è alla cascina Ronchi. Vieni a trovarmi?”.
Da quando ero adolescente non andavo da quelle parti. L’ultima volta che avevo abbandonato il paese per inoltrarmi in bicicletta fino ai Ronchi avrò avuto sedici anni.
Mi era rimasto un ricordo sbiadito, da cartolina: il lungo porticato, le abitazioni su tre piani, le porcilaie lungo la roggia una in fila all’altra, la rüdéra [letamaio], la campana sulla casa padronale con il gallo in metallo montato sul tetto e soprattutto quei quattro enormi platani che facevano ombra a tutta l’aia.
Franchino, che ai Ronchi aveva vissuto la sua infanzia, mi aveva raccontato che le radici di quegli alberi erano così grandi da fuoriuscire dal terreno e formare dei seggiolini naturali. Ne è rimasto solo uno di quei platani.
Era lì, davanti alle piante e al cazòt [capanno degli attrezzi], dove ogni giorno, alle sei del mattino, Cammi, al fatùr [il fattore], radunava tutti i dipendenti e impartiva gli ordini.
Quel giorno, arrivato a casa di Surya, mi sembrò di sentire l’eco della voce del fattore così come la squillante melodia del corno che all’alba Rico, il nonno di Franco, suonava dal baladùr [ballatoio]: il suono attutito dal vento si disperdeva in ogni direzione, arrivava alle orecchie dei cavallanti che nel giro di pochi minuti dovevano essere nelle stalle a strigliare le bestie.
Se non fosse stato per Surya, forse non sarei più tornato in quel luogo sacro della pianura. Era come se avessi messo in cantina, tra i vinili della sigla di Heidi e Lady Oscar e i quaderni di matematica e d’italiano foderati, anche la memoria per quei mondi ormai lontani.
Quando ancora non avevo la patente e i peli della barba erano solo accennati sotto il mento, andavamo con il Ciao o con la bicicletta fino ai Rùch o alla Cantaràna per poi fare tappa ai fontanili, percorrendo la strada che costeggia la roggia Pallavicina.
Partivamo nel pomeriggio dalla piazza del paese, ancora intitolata “alla vittoria”, e andavamo alla conquista di una terra che ci aveva cresciuti e alla quale non siamo mai stati abbastanza grati.
Da lontano quelle cascine apparivano, ai nostri occhi d’adolescenti, mute, vuote, tristi. Veniva il nodo alla gola ogni volta a pensare che un tempo sotto quei porticati si celebrava la vita dettata dalle quattro stagioni. Ora non c’era più niente.
Neanche un vaso di fiori, un orto, una catasta di legna. La stessa sensazione l’aveva avuta don Angelo.
Al cürat [il curato] per anni aveva attraversato quelle stradine traballando sul calesse avvolto dalla nebbia per andare ogni domenica a celebrare la Santa Messa. Franchino mi aveva raccontato che lo accoglievano a braccia aperte; lo aspettavano in quella cappella, al centro dell’aia, che durante la settimana fungeva anche da scuola. Lì, avvolti dalla fuliggine della stufa a legna, i bambini facevano un po’ di catechismo e il quaresimale per la preparazione della Pasqua.
Anni dopo, don Angelo tornò in quel luogo che era stato la sua prima missione parrocchiale ma non trovò più nessuno. Nemmeno gli indiani “sbarcati” nella distesa della pianura agli inizi del 2000.
Surya, arrivata dalla terra dei guru, coperta da campi gialli e montagne azzurre, non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi tra zanzare e campi di granoturco, avvolti dalla foschia autunnale e dal grigiore della nebbia dell’inverno.
E neanche Franco avrebbe mai detto che a mungere le vacche e ad arare i terreni sarebbe arrivato Kumar.
Ai Ronchi ci vivevano centocinquanta persone, cento mucche da latte, una ventina di cavalli, al sciùr padrù [il signor padrone] Pietro Bettinelli con la moglie e i figli. Sessant’anni più tardi solo una famiglia d’indiani.
Era avvenuta una rivoluzione: nel momento in cui i nostri mungitori erano pronti ad andarsene, erano arrivati gli uomini dall’India a salvare le stalle.
Mario e Tòne [Antonio], mio padre e mio nonno, neanche sapevano indicarmi sulla cartina dov’era questa “India”. Non conoscevano i profumi delle loro spezie, l’odore della loro pelle, la bellezza dell’olivastra carnagione delle loro donne. A casa mia non c’è mai stato un atlante. Anzi non c’era nemmeno la libreria. L’India era solo un Paese lontano per nonno Tòne, come l’Italia lo era stata per la nonna di Surya. Ora, grazie alla mia alunna, sotto quei vecchi porticati s’incontravano due mondi.
La cascina era cambiata molto dall’ultima volta che l’avevo vista. Stavolta era abitata.
Erano tornati i contadini. Nuovi braccianti per la Padania leghista: uomini con il turbante in testa, accompagnati da mogli con lunghi sari colorati e decorati con lustrini e perline e da giovani figlie con salwar kameez, i pantaloni con coulisse.
Ai Ronchi avevo trovato anche la nonna di Surya: “Namaste”, avevo accennato all’anziana donna, portandomi le mani giunte al petto, inchinando leggermente la schiena in segno di rispetto, come avevo imparato nel mio viaggio tra Calcutta e Delhi.
“Vieni, vieni maestro. Entra, beviamo qualcosa”. La dolce ospitalità indiana, che avevo già vissuto tra le polverose strade di Calcutta, mi riaprì dopo decenni le porte della cascina Ronchi.
Sul tavolo i libri d’italiano di Surya accanto ai testi in hindi con la foto in copertina di qualche guru.
La voce gracchiante della radio del Gazzettino Padano e mamma Rai erano state sostituite da qualche film di Bollywood. E, all’angolo della cucina, il santino di Sant’Antonio abate, protettore degli animali, aveva lasciato il posto a un’immagine di Vishnu, con le sue quattro braccia che tengono in mano un fiore di loto, una conchiglia di strombo, un disco e una mazza.
Erano rimasti il camino e la credenza con la cristalliera: dietro quei vetri, la moglie di Kumar aveva messo, come facevano le nostre nonne, i pochi piatti salvati dalla dote. Al posto della farinéra [madia], dove un tempo si preparava al pastò [il pastone] per le anatre e le oche, faceva bella mostra uno di quei mobili di Ikea, in compensato. E, al centro, la grande tavola: whisky e Coca-Cola avevano sostituito il Barbera.
“Chissà quante serate passate a giocare a morra si saranno fatti su quest’asse di legno”, pensai.
Zio Augusto e zia Teresa, per un certo periodo, avevano avuto la concessione dal sciùr padrù ad aprire la loro casa al calar del sole per fare da osteria: certe sere, in quella cucina, arrivavano anche venti persone e quando anni dopo comprarono il televisore si trovavano tutti a vedere in bianco e nero Campanile sera con Enzo Tortora o il Musichiere con Mario Riva.
“Come va mia figlia a scuola?”, chiese subito Kumar riempiendo a metà il bicchiere di whisky.
Era arrivato in Pianura Padana senza neanche sapere dove fosse.
Offanengo non c’era sulla cartina. Nemmeno la cascina Ronchi.
Kumar era partito dal Punjab il 3 settembre 1992: “Guarda, maestro, questo è mio biglietto quando sono arrivato in Italia, l’ho tenuto. Sono atterrato a Torino, i carabinieri mi hanno preso e portato all’ospedale per una visita. Ho dato indirizzo di mio fratello e mi hanno ospitato in un hotel vicino alla stazione, dove mi hanno dato stanza per dormire e mangiare. Il mattino mi hanno accompagnato al binario. A Potenza ho fatto agricoltore: avevo quindici mucche da mungere. Ho preso il posto di mio fratello, vivevo con il padrone come una persona di famiglia e non come un operaio. Quando mi sono sposato, ho pensato di trovare un posto dove la mia moglie potesse trovare altre famiglie indiane. Qui ce ne sono tante, ecco perché sono a Offanengo”.
Kumar aveva fatto da staffetta a Bruno, l’ultimo italiano, un testimone di Geova, che aveva abitato in quelle mura intrise di memoria.
Dal 2000 il nuovo custode della cattedrale rurale del paese era un indiano, papà di una mia alunna.
Ormai conosceva i Ronchi meglio di chi era nato in paese.
“Sali, qui sopra c’erano le stanze”.
Una ripida scala traballante mi portò sul ballatoio da dove il nonno di Franchino suonava il corno.
Sbirciai nelle stanze, quasi fossi un intruso del tempo passato: intravidi una di quelle camere senza soffitto, divise da sottili pannelli di legno, con poveri e semplici mobili e due letti, quello matrimoniale e quello dei bambini. Attorno c’erano le ricchezze di famiglia: i sacchi di granaglie ricevuti in cambio del lavoro e il baldacchino con i salami. Appese al muro, le stampe sbiadite della Sacra Famiglia e del Sacro Cuore.
“Sai Surya che i bambini dormivano insieme? La conosci la storia del toro Ioli?”.
Era una bestia che aveva animato le notti di Franchino ma soprattutto del cugino Andrea che per anni ebbe incubi; si alzava d’impeto nel buio gridando: “Aiutooo! Aiutooo! Al tòr, al tòr! [il toro]”.
Ioli era un “marito” di quelli seri: una bestia da oltre dieci quintali che aveva il compito di fecondare tutte le mucche. Anche una o più al giorno. Quando veniva fatto uscire dalla stalla era tenuto con due catene, una legata all’anello del naso.
Durante una di queste scarrozzate galanti, Ioli si divincolò. Riuscì a strappare i catenacci. Sporco di sangue iniziò a scappare per tutta l’aia. Nessuno riusciva a fermarlo. Era come impazzito. Correva trascinando i suoi quintali con una potenza incredibile. Sbatteva la testa ovunque, muggiva con ferocia e raspava l’aia con gli zoccoli. I salariati cercarono di mandare tutti al riparo, soprattutto i più piccoli. Lo zio Augusto gridava: “Andrea, scàpa, scàpa!” [Andrea, fuggi, fuggi!].
Andrea si nascose dietro il carro di fieno, tirando il fiatone e ascoltando con il cuore a mille le voci dei contadini che cercavano con i forconi di catturare la bestia. Ioli riuscì a ribaltare il carro e Andrea si trovò il quadrupede davanti agli occhi sbarrati e atterriti. Da quel giorno, nonostante i bergamini riuscirono a salvarlo, le notti non furono più le stesse per il piccolo.
“Ma poi che fine ha fatto il toro?”, m’interruppe la bambina.
Non feci in tempo ad inventare un finale che il mio piede finì ad inciampare su una mòniga [monaca, in questo caso scaldaletto], uno di quei magici attrezzi di legno che servivano per riscaldarsi. Non ho mai capito come funzionassero, ma posso assicurare d’averli provati quando ancora ero piccolo. Mio padre ne aveva ereditata una dal nonno Tòne e per anni la usò prima che arrivasse quella elettrica. S’infilava sotto le coperte, poco prima di andare a letto: serviva a creare l’illusione che il freddo fosse meno freddo almeno per una mezz’ora.
Pensai: “Chissà se anche la nonna di Surya in India l’aveva una specie di mòniga”.
Mentre divagavo con l’immaginazione, la voce di Kumar mi interruppe: “Ora ti porto alla stalla. Qui non c’è più una sola mucca, ma ho fatto anch’io il bergamino come tutti gli altri indiani. Mi alzavo alle quattro e per ore mungevo, mungevo...”.
Le mammelle delle migliaia di bovin...