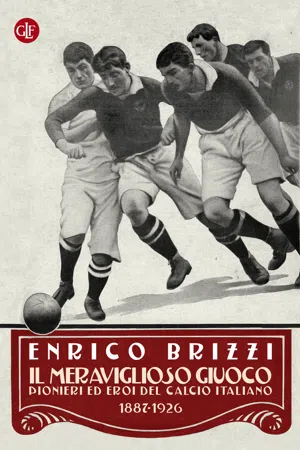Il mondo nuovo
Un tragico bilancio – Jimmy Hogan, il prometeo del football – Oltreoceano nasce il mito dell’Uruguay – D’Annunzio s’inventa una crisi internazionale (e lo scudetto)
Fra i tanti ragazzi che avevano lasciato la propria giovinezza sul Carso c’erano naturalmente anche gli sportivi: erano morti atleti e ciclisti, nuotatori e ginnasti. Erano morti, a frotte, anche i pionieri del football in Italia, primi attori del meraviglioso giuoco che aveva cominciato ad appassionare le élite sul finire del XIX secolo e che nel 1915 era già diventato un affare pubblico, con partite in grado di infiammare intere città e un giro di soldi sufficiente a muovere parecchi interessi: aveva fatto scalpore una campagna-acquisti del Genoa, che aveva prelevato dal Milan “Il figlio di Dio” De Vecchi per 24 mila lire, e il trio Santamaria-Fresia-Sardi dall’Andrea Doria.
Aggiudicarsi quattro giocatori del giro della Nazionale non era una mossa che potesse passare inosservata ai tempi in cui il calcio si professava rigorosamente dilettantistico: quando erano stati scoperti gli assegni pagati sottobanco dal presidente rossoblu Geo Davidson, il Grifone era stato condannato a una multa e i giocatori squalificati per due anni. Alla fine, però, la squalifica era stata dimezzata e i nuovi acquisti avevano riportato il Genoa in alto. Le altre squadre avevano mangiato la foglia: per vincere i tornei servivano soldi, tanti soldi, ché l’amore per la casacca e la città non erano sufficienti nemmeno nella Belle Époque.
Certo, il nuovo sport era ancora confinato ai trafiletti sulla stampa sportiva, consacrata in primo luogo alla velocità, la dynamis futurista espressa dalle esclusive corse di auto e moto, come dal proletario sforzo di polpacci dei campioni della bicicletta. La strada verso le prime pagine, tuttavia, era tracciata: il football era partito come passatempo per i club più esclusivi di residenti britannici, quindi aveva contagiato i ragazzi delle italianissime società ginnastiche, dalle più blasonate a quelle di origine borghese, e ormai si era trasformato in uno spettacolo che infiammava le plebi.
Il fatto era che gli italiani non sapevano resistere a un confronto fra portacolori di città diverse. Una partita di calcio fra rappresentative in divisa non faceva pensare alle vecchie battaglie fra liberi comuni? E non erano forse, i derby, degne rievocazioni delle lotte intestine tra fazioni? Per un popolo tendenzialmente conservatore era una sensazione confortevole: erano tornati gli eroi cittadini, gli idoli locali, le bandiere e i capitani; erano tornati i guelfi e i ghibellini e, anche se in realtà erano pettinati alla maniera del XX secolo, indossavano casacche degne degli antichi araldi: portavano i colori sacri e, come otto secoli prima, la gente era felice di delegare loro l’onore di tutta la comunità. Quando poi serviva fare fronte comune, bastava trovare un nemico esterno, e questo era il compito della Nazionale, attiva dal 1910.
Nemmeno i capitani della Nazionale erano stati risparmiati dal conflitto: il primo, il siciliano Franz Calì dell’Andrea Doria, sguardo fiero e baffoni all’insù da domatore, era stato ferito in battaglia e, una volta curato, lo si era riposizionato vicino a casa, al comando del carcere genovese di Forte Sperone, allora traboccante di prigionieri austro-ungarici. Il suo successore, Giuseppe Milano della Pro Vercelli, aveva dovuto piangere la morte sull’Isonzo del fratello minore Felice, compagno di squadra tanto nelle Bianche casacche come in maglia azzurra. Quanto al terzo e ultimo capitano, l’interista Virgilio Fossati, come abbiamo visto il suo nome figurava nell’elenco dei caduti in battaglia.
Anche la Nazionale doveva ripartire praticamente da zero, affidando le nuove leve all’esperienza dei pochi veterani, come De Vecchi, Sardi e Santamaria, in grado di vestire ancora la maglia azzurra.
Le armate italiane, dopo aver resistito nell’estate del 1918 alla terribile Offensiva del solstizio, cominciarono a intravedere la luce della speranza: gli austro-ungarici e le potenze che li sostenevano erano messi ancora peggio di noi e forse non era lontano il momento del loro crollo definitivo. Re Vittorio Emanuele poteva sorridere: con ogni probabilità, gli ammutinamenti e la rivoluzione non sarebbero andati in scena a Roma, bensì a Vienna, Berlino e Costantinopoli.
In estate, l’esercito del nuovo imperatore Carlo – erede del defunto Francesco Giuseppe – cominciò a perdere pezzi, la diplomazia a tessere le proprie pazienti ragnatele e la propaganda a macinare i propri argomenti; il 9 agosto, a dimostrare la superiorità delle ali (e del morale) d’Italia, Gabriele D’Annunzio portò a termine il suo celebre raid aereo sulla capitale austriaca, sganciando dal cielo una pioggia di volantini tricolori. Cinquantamila recavano stampato il messaggio composto dallo stesso Vate, che però era stato giudicato circonvoluto e praticamente intraducibile in tedesco, così a bordo dei velivoli SAV ne erano stati caricati altri trecentocinquantamila che riportavano un più efficace testo di Ugo Ojetti rivolto alla popolazione: «Viennesi! Imparate a conoscere gli italiani! Noi voliamo su Vienna, potremmo lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto a tre colori: i colori della libertà! Noi non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi, alle donne. Noi facciamo la guerra al vostro governo nemico delle libertà nazionali, al vostro cieco testardo crudele governo che non sa darvi né pace né pane, e vi nutre d’odio e d’illusioni».
Dietro gli argomenti scelti per reclamizzare l’Italia e i suoi valori, c’era lo scoperto intento di demoralizzare il nemico e frantumarne il fronte interno: la campagna risultò efficace non tanto per i suoi contenuti, quanto perché i messaggi provenivano dalle carlinghe di aerei liberi di sorvolare indisturbati le retrovie e giungere a stormo sulla capitale.
A Vienna l’impressione fu enorme e furono in tanti a pensare che il messaggio di Ojetti, nel suo prosieguo, contenesse una verità incontrovertibile e una domanda imbarazzante: «Voi avete fama di essere intelligenti. Ma perché vi siete messi l’uniforme prussiana?».
Negli stessi giorni crollava il fronte occidentale stabilito dai tedeschi sul Reno e nel mese di settembre si registrarono nuove vittorie alleate nei Balcani: anche turchi e bulgari, alleati delle potenze centrali, erano prossimi alla resa. Se si voleva profittare dell’occasione e guadagnare terreno prima che gli austro-ungarici alzassero bandiera bianca, era tempo di attaccare su tutto il fronte: il 24 ottobre scattò l’offensiva di Vittorio Veneto, volta a vendicare lo scacco di Caporetto e assicurarsi una posizione favorevole al tavolo della pace.
Cinquanta divisioni italiane e sei alleate attaccarono all’unisono le linee austriache dalle creste tridentine sino all’Adriatico: sotto l’impeto di oltre un milione di uomini, gli austro-ungarici combatterono solo in determinati settori, mentre negli altri si davano a una fuga scomposta, compromettendo ogni possibilità di ripiegamento ordinato. Come l’anno prima le armate italiane si erano precipitate verso i ponti sul Piave, così ora il nemico intasava le strade verso i passi alpini, e volavano insulti e fucilate fra unità austriache e ungheresi, boeme e croate.
Il 3 novembre una flottiglia di sette cacciatorpedinieri al comando del generale Petitti di Roreto sbarcò a Trieste fanti e bersaglieri; fra i reparti nemici in rotta si registrava, per ammissione degli stessi comandi austriaci, “completa anarchia e mancanza di viveri”. Ai delegati imperial-regi, che da giorni avevano intavolato trattative per l’armistizio in quel di Villa Giusti, presso Padova, non restò che accettare un patto che aveva tutta l’apparenza di una capitolazione. Gli italiani smisero d’inseguire i nemici solo alle 15 dell’indomani, 4 novembre, esattamente come previsto dalle clausole dell’accordo.
Dopo anni di sofferenze indicibili, fu la più facile delle vittorie: Diaz poté vantarsi di aver catturato in pochi giorni oltre 400 mila prigionieri, fra i quali una ventina di generali, e un arsenale di 4000 mitragliatrici e 5000 fra cannoni e bombarde.
L’impero degli Asburgo era crollato come un castello di carte: i magiari e i boemi, gli slovacchi e gli slavi del Sud reclamavano l’indipendenza, e in quelle condizioni la stessa Austria piombò nel caos. A Carlo non restò che lasciare il trono per evitare guai peggiori alla sua patria: sparì dalla circolazione e se ne andò in esilio a Madera.
La Germania, rimasta sola a combattere, accelerò i tempi e sottoscrisse nel giro di sette giorni un armistizio di fronte ai delegati alleati. Le questioni territoriali sarebbero state discusse in separata sede, a Versailles, ma ormai era insorta anche la piazza di Berlino. Avevano preso il potere i socialisti, e il Kaiser Guglielmo era dovuto riparare in Olanda.
Re Vittorio Emanuele III poteva ridere sotto i baffi: grazie agli Alleati e ai valorosi “Ragazzi del ’99”, a casa Savoia non sarebbe toccato niente del genere. Ancora non sapeva che entrambe le categorie di benefattori avrebbero presto presentato il conto, sprofondando anche l’Italia sull’orlo di una guerra civile.
Il Paese si leccava le ferite e si confortava scoprendo ogni giorno nuove targhe e nuovi gruppi bronzei. Nonostante le mille difficoltà quotidiane, la sorte ancora incerta di tanti, la frustrazione dei veterani e le epidemie, si era ancora vivi. La gente aveva voglia di mangiare a crepapelle e di tornare a divertirsi, nei caffè e nei teatri, alle fiere e, naturalmente, negli stadi. La Prima categoria doveva tornare per certificare il ritorno alla normalità e per regalare agli italiani un po’ di spensieratezza. Senza contare che sarebbe stata utilissima per distrarre i veterani rimasti senza lavoro, gli esaltati rivoluzionari e i nuovi ragazzi d’Italia.
Oh sì, avrebbe fatto comodo a tutti il ritorno del grande calcio. E il grande calcio sarebbe tornato, assumendo un ruolo ancora più centrale nella società italiana di quello ricoperto prima della guerra: nemmeno la strage di una generazione sarebbe riuscita a fermare il football. Si sarebbe vista un’Inter fortissima con il ritorno di “Zizì” Cevenini, del redivivo Ermanno Aebi e del giovane Pino Fossati a tener viva la memoria del fratello; si sarebbero visti un Livorno straordinario, una Pro Vercelli rinnovata, una Juventus lanciata verso la gloria, un Genoa deciso a non mollare, un Torino di fuoriclasse, una riforma e una scissione. Si sarebbero visti nuovi campioni maturare all’ombra dei pionieri superstiti e squadre nuove di zecca destinate a lasciare un segno indelebile.
La leggenda del calcio italiano si sarebbe arricchita nel corso degli anni Venti di nuovi volti, nuovi viaggi e nuove avventure.
La Grande Guerra aveva fatto strage di calciatori non solo da noi. Il Regno Unito, culla del “meraviglioso giuoco” e medaglia d’oro nel football alle Olimpiadi del 1908 e del 1912, aveva pagato un tributo non meno pesante. Benché le armate di sua maestà britannica non si fossero trovate a difendere direttamente il suolo patrio, si calcola che su cinquemila calciatori retribuiti dai club nel 1914, non meno di duemila abbiano perso la vita nel conflitto.
Nella prima fase erano stati istituiti particolari battaglioni di volontari da inviare sul fronte occidentale, i cosiddetti Pals battalions, costituiti da amici e colleghi che si arruolavano insieme con la garanzia di “combattere fra amici”. In questo contesto si erano segnalate varie unità composte da sportivi, e almeno tre specificamente da calciatori: il 17° e il 23° Battaglione del Middlesex Regiment, e il 16° Battaglione dei Royal Scots. Quest’ultimo era formato dai calciatori della prima squadra e della formazione-riserve, nonché dallo staff e dai tifosi più accaniti del più forte club di Edimburgo, lo Heart of Midlothian, che perse nel conflitto ben sette titolari.
Nel 1918, però, il Regno Unito non aveva solo martiri da piangere e onorare: la guerra aveva cambiato per sempre anche la vita di tanti campioni che erano riusciti a sopravvivere, come le “stelle” Steve Bloomer e Vivian Woodward. Bloomer, leggenda del Derby County con 23 presenze e 28 reti in Nazionale fra il 1895 e il 1907, si era ritirato alla bella età di quarant’anni, e nell’estate del 1914 aveva accettato di guidare come allenatore-giocatore il club berlinese del Britannia: appena tre settimane dopo il suo arrivo in Germania, era scoppiata la guerra e Bloomer si era trovato segregato in un campo di prigionia riservato ai cittadini di Paesi nemici. Ne sarebbe uscito solo quattro anni dopo, decisamente troppo vecchio per riprendere a giocare sul serio.
Woodward, centravanti del Tottenham e poi del Chelsea, poteva essere considerato il suo erede nella Nazionale dei Tre leoni: all’inizio della guerra poteva vantare 23 caps e 29 reti, un bilancio arricchito da ulteriori 44 presenze (e 57 gol) nella Nazionale dilettanti, con la quale aveva trionfato nei Giochi di Londra 1908 e Stoccolma 1912. Aveva preso servizio in uno dei già ricordati footballers battalions, il 17° del Middlesex Regiment, riportando in battaglia ferite tanto gravi da impedirgli di riprendere l’attività ad alto livello: Woodward venne giudicato fortunato quando fu chiaro che, perlomeno, poteva ancora reggersi in piedi senza stampelle; si gridò al miracolo allorché riapparve in campo per una manciata di partite e tornò a segnare, ma ormai si trattava di incontri nelle serie minori.
Fu invece trattato senza mezzi termi...