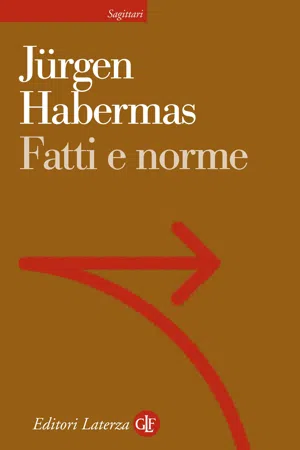1. Il diritto: una categoria di mediazione sociale tra i fatti e le norme
Il concetto di ragion pratica come facoltà soggettiva è formazione moderna. Quando la concettualità aristotelica si convertì alle premesse della filosofia del soggetto, lo svantaggio fu che la ragion pratica cessò d’incarnarsi in forme culturali e ordinamenti politici. In compenso, il vantaggio fu che la ragion pratica diventava ora riferibile alla felicità (intesa in senso individualistico) e all’autonomia (acuita in senso morale) del singolo individuo. Essa diventava cioè applicabile alla libertà dell’uomo inteso come soggetto privato, il quale può anche presentarsi quale membro della società civile, cittadino dello Stato, cittadino del mondo. Nel suo ruolo cosmopolitico, l’individuo viene a coincidere con l’uomo in generale: un Ego nello stesso tempo singolare e universale. A questo repertorio di concetti settecenteschi, l’Ottocento aggiungerà la dimensione della storia. Il singolo soggetto è coinvolto nella sua storia di vita allo stesso modo in cui gli Stati (come soggetti dello jus gentium) sono implicati nella storia delle nazioni. Hegel conia a questo fine il concetto di spirito oggettivo. Ma Hegel è ancora per certi versi aristotelico, nel senso che anche per lui la società trova la sua unità nella vita politica e nell’organizzazione dello Stato; la filosofia pratica della modernità continua a fondarsi sulla vecchia ipotesi secondo la quale gli individui appartengono alla società così come i membri appartengono al collettivo, così come le parti appartengono al tutto (anche qualora tale insieme possa costituirsi solo a partire dal riunirsi delle sue parti).
Sennonché, nel frattempo, le società moderne sono diventate così infinitamente complesse, che anche queste due figure teoriche – società centrata sullo Stato e società composta d’individui – non paiono più giustificabili a priori. Già la teoria marxista della società aveva pensato di dover rinunciare a ogni teoria normativa dello Stato. E tuttavia, persino il concetto marxista di un’autoamministrazione democratica della società – dove il potere burocratico dello Stato si sarebbe dissolto insieme all’economia capitalistica – rivelava ancora tracce di una ragion pratica mascherata da filosofia della storia. La teoria dei sistemi elimina ora anche queste ultime tracce, cancellando qualsiasi riferimento ai contenuti normativi della ragion pratica. Lo Stato forma uno dei tanti sottosistemi sociali funzionalmente specializzati; questi si dispongono tra loro in un rapporto “sistema/ambiente” analogo a quello che le persone intrattengono con la società. Una stessa linea di pensiero collega Hobbes a Luhmann: la strategia con cui la ragion pratica venne inizialmente negata dall’autoaffermazione naturalistica degli individui sfocia ora nell’autopoiesi dei sistemi autoreferenziali. A questo punto, né riduttive formule empiristiche né tentativi di riabilitazione sembrano più in grado di restituire alla ragion pratica quella forza esplicativa di cui essa un tempo godeva – quando ancora si collegava a etica e politica, diritto naturale e teoria morale, filosofia della storia e teoria della società.
Dai processi storici la filosofia della storia può ricavare solo quel quantum di ragione ch’essa vi ha preventivamente inserito tramite concetti teleologici; allo stesso modo non è possibile desumere dalla costituzione biologico-naturale dell’uomo imperativi di tipo normativo per una ragionevole condotta di vita. Non diversamente dalla filosofia della storia, anche un’antropologia à la Scheler o à la Gehlen ricade sotto la critica sviluppata dalle stesse scienze ch’essa vorrebbe strumentalizzare: entrambi gli approcci mostrano difetti analoghi. Né risulta più convincente rinunciare in maniera contestualistica ad ogni fondazione. Così facendo, si reagisce sì al fallimento fondativo dell’antropologia e della filosofia della storia, ma senza andare al di là di un ostinato richiamo alla forza normativa del fattuale. È certamente vero che la via “nord-atlantica”, su cui si è incamminato lo Stato democratico di diritto, ci ha fruttato risultati degni d’essere salvaguardati. Ma questo vorrebbe dire, nella prospettiva contestualistica, che tutti quelli che non derivano dai Padri fondatori della costituzione americana non potrebbero mai trovare, nelle loro tradizioni diverse, una buona ragione per distinguere ciò che va conservato da ciò che va criticato.
Le tracce superstititi del normativismo giusrazionalistico si perdono dunque in un trilemma. I contenuti della ragion pratica – ormai “scoppiata” nella figura che ancora la legava alla filosofia del soggetto – non sono più giustificabili né con il finalismo della storia né con l’antropologia naturale né col repertorio di tradizioni casualmente ereditate. Ciò spiega l’attrazione esercitata dall’unica opzione apparentemente ancora disponibile: quella d’una risoluta smentita della ragione tout court, espressa o nelle forme drammatiche della critica post-nietzscheana o nella variante disincantata di un funzionalismo sociologizzante che neutralizza tutto ciò che – nella prospettiva del partecipante – ancora riveste obbligatorietà e significato. Chi però, nel campo delle scienze sociali, non intende puntare tutte le sue carte su ciò che è controintuitivo, troverà poco attraente anche questa soluzione. Per questo, con la teoria dell’agire comunicativo, io ho scelto una via diversa: al posto della ragion pratica subentra la ragione comunicativa. E non si tratta solo di un cambio d’etichetta.
Nelle tradizioni di pensiero della vecchia Europa si era generato un corto circuito tra ragion pratica e prassi sociale. Tutto quest’ambito era infatti scivolato nel quadro di problematiche normative o cripto-normative (ossia filtrate da una filosofia della storia). Come la ragion pratica doveva orientare l’azione del singolo individuo, così il diritto naturale (almeno fino a Hegel) doveva disegnare normativamente l’unico ordinamento giusto sul piano politico-sociale. Per contro, una ragione che si trasferisse ora nel medium linguistico, e si liberasse da questo legame esclusivo con la morale, rivestirebbe un ruolo assai diverso nella costruzione teorica. Questa ragione potrebbe infatti, per un verso, descrittivamente servire alla ricostruzione di competenze e strutture di coscienza già da sempre operanti, nonché, per l’altro verso, funzionalisticamente agganciarsi ad approcci e spiegazioni di tipo empirico39.
La ragione comunicativa si distingue dalla ragion pratica anzitutto perché non è più riferita a singoli attori, o a macrosoggetti di natura statale e sociale. Ciò che rende possibile la ragione comunicativa è il medium linguistico, attraverso cui s’intrecciano interazioni e si strutturano forme di vita. Questa razionalità è inscritta nel telos linguistico dell’intesa reciproca [Verständigung; mutual understanding], formando un complesso di condizioni possibilitanti e limitanti insieme. Chiunque, servendosi di un linguaggio naturale, voglia mettersi d’accordo [Sich verständigen: dove la dimensione semantica dell’informazione e della comprensione si coniuga alla dimensione performativa del mettersi d’accordo e dell’allertare N.d.T.] con un destinatario, circa qualcosa di esistente nel mondo, si vede costretto ad assumere un atteggiamento performativo, affidandandosi a determinate presupposizioni. Tra l’altro deve presumere che gli interessati: a) perseguano senza riserve mentali i loro fini illocutivi, b) subordinino la loro intesa al riconoscimento intersoggettivo di pretese di validità criticabili, c) si mostrino disponibili ad accollarsi obbligazioni che, scaturite dal consenso, influenzino l’ulteriore sviluppo dell’interazione. Ciò che in tal modo pertiene alla base di validità del linguaggio si trasmette – attraverso l’agire comunicativo – anche alle forme di vita che ne derivano. Tuttavia – pur estrinsecandosi in un contesto decentrato di condizioni possibilitanti, strutturanti e plasmanti sul piano trascendentale – la razionalità comunicativa non è una facoltà soggettiva che prescriva ai singoli attori che cosa essi devono fare.
A differenza della classica figura della ragion pratica, la ragione comunicativa non è, di per sé, fonte immediata di norme d’azione. Essa possiede contenuti normativi solo nella misura in cui, per agire comunicativamente, ci si deve sempre affidare a presupposti pragmatici di natura controfattuale nonché intraprendere delle idealizzazioni. Per fare un esempio: attribuire alle locuzioni significati identici, assegnare alle affermazioni una pretesa di validità oltrepassante il contesto, ascrivere implicitamente ai destinatari una “capacità d’intendere e volere” (ossia, autonomia e sincerità sia verso sé che verso gli altri). Nel fare ciò, l’attore si trova senz’altro coinvolto nella costrizione di una debole necessità trascendentale. Ma non per questo si trova già comandato dalla costrizione obbligatoria d’una determinata regola d’azione, vale a dire da una costrizione che si presenti come riconducibile a) in termini deontologici, alla validità prescrittiva d’un imperativo morale, b) in termini assiologici, a una costellazione di valori privilegiati, c) in termini empirici, all’efficacia d’una regola tecnica. Ogni effettiva prassi d’intesa, capace di volgersi criticamente contro i propri risultati e di trascendere se stessa, poggia sul fondamento controfattuale d’una corona d’idealizzazioni. Con ciò la tensione idea/realtà irrompe nella stessa fattualità delle forme di vita linguisticamente strutturate. Certo, la prassi comunicativa quotidiana è sempre sovraccaricata di presupposti idealizzanti; ma solo alla luce di questa trascendenza intramondana possono aver luogo processi di apprendimento.
Dunque la ragione comunicativa ci consente di orientarci alle pretese di validità, ma non ci offre, di per sé, orientamenti utili alla soluzione di compiti pratici: essa non è né informativa né direttamente pratica. La ragione comunicativa, per un verso, abbraccia l’intero ventaglio delle pretese di validità – riguardanti verità proposizionale, sincerità soggettiva, giustezza normativa – e in questo senso oltrepassa ampiamente l’ambito delle questioni pratico-morali. Per l’altro verso, però, si riferisce unicamente a intuizioni ed enunciati che si presentano come criticabili, cioè suscettibili di spiegazione argomentativa, e in questo senso la ragione comunicativa non si solleva affatto al livello di una ragion pratica che voglia direttamente motivare e guidare la volontà. La normatività, intesa come obbligazione diretta del comportamento, non coincide con la ragione comunicativa. Normatività e ragione comunicativa s’intersecano solo sul terreno fondativo delle intuizioni morali. Cioè di quelle intuizioni che – acquisite in atteggiamento ipotetico e sostenute da una debole forza motivazionale – non sono in grado di convertirsi da sole, automaticamente, in azioni motivate40.
Occorrerà non dimenticare queste differenze se, nel quadro di una teoria ricostruttiva della società, io cercherò di non perdere di vista l’idea della ragione comunicativa. Si tratta di un contesto inedito, dove il concetto tradizionale della ragion pratica acquista un valore diverso, per molti versi di tipo euristico. Esso non ci mette più a disposizione una teoria normativa del diritto e della morale. Piuttosto ci fornisce il filo conduttore per ricostruire quell’intreccio di discorsi – formativi dell’opinione e preliminari alle decisioni – da cui nasce il potere democratico quand’è esercitato per vie legali. Nella prospettiva dello Stato di diritto, le forme comunicative che guidano la formazione della volontà politica e le procedure legislative e giurisprudenziali, rientrano nel più ampio processo di razionalizzazione e modernizzazione dei mondi di vita delle società moderne, le quali si sono organizzate in base a imperativi di natura sistemica. Solo una ricostruzione di questo tipo ci fornisce criteri valutativi per giudicare le pratiche d’una realtà costituzionale oggi sempre più ambigua e sfuggente.
Anche se diamo per superate le versioni più tradizionali della ragion pratica, non abbiamo però ancora dimostrato perché una teoria contemporanea del diritto e della democrazia debba ancora sentirsi legata alla concezione classica. La nostra teoria prende le mosse dalla forza socio-integrativa di processi d’intesa non violenti e razionalmente motivati: processi che, nella salvaguardia di credenze comuni, rendono possibile prendere atto delle distanze e riconoscere le differenze. In questa prospettiva, i filosofi della morale e del diritto continuano anche oggi a condurre avanti i loro discorsi normativi, in maniera anzi sempre più vivace. Tuttavia, quando trattano della validità normativa nell’atteggiamento performativo di chi è coinvolto e partecipe, essi mostrano una certa difficoltà a oltrepassare quell’orizzonte ristretto dei mondi di vita che gli osservatori delle discipline sociologiche hanno da tempo “disincantato”. Per questo motivo, le teorie normative sono oggi accusate di non tener conto di quei crudi dati di fatto, che hanno ormai largamente smentito l’autocomprensione giusrazionalisticamente ispirata del moderno Stato costituzionale. Dalla prospettiva oggettivante delle scienze sociali, ogni concezione filosofica ancora operante in base alla venerabile alternativa di ordine stabilizzato con la forza vs. ordine legittimato dalla ragione, ricade nella semantica di transizione della prima modernità. Da quando le società stratificate si sono convertite in società funzionalmente differenziate, l’uso di questa terminologia sembra essersi fatto obsoleto: passé, out of fashion. Anche chi volesse sistemare in posizione strategicamente centrale l’eredità comunicativa della vecchia “ragion pratica”, finirebbe tuttavia per privilegiare – ecco ciò che ci viene rimproverato – una forma di comunicazione speciale e particolarmente esigente, che riguarderebbe soltanto un piccolo settore nell’ampio spettro delle comunicazioni osservabili. «Passando per queste strettoie, non sarà praticamente più possibile reinserire nel nuovo paradigma dell’intesa una teoria sufficientemente complessa della società»41.
Risucchiata in direzioni opposte dalla tensione tra fattualità e validità, la teoria politica e giuridica si spezza oggi in campi che non hanno quasi più niente da dirsi. Sennonché la tensione che si viene a creare tra gli approcci normativistici, sempre in pericolo di perdere il contatto con la realtà sociale, e gli approcci oggettivistici, che mettono fuori gioco tutti gli aspetti normativi, potrebbe anche venir intesa come un’ammonizione a evitare ogni irrigidimento in un’unica prospettiva disciplinare. Conviene infatti restare aperti a diversi punti di vista metodologici (partecipante vs. osservatore), a diversi obbiettivi teorici (esplicitazione interpretativa e comprensione di senso vs. descrizione o spiegazione empirica), a diverse prospettive di ruolo (giudice, politico, legislatore, cliente, cittadino), a diversi atteggiamenti pragmatici d’indagine (impostazione ermeneutica, critica, analitica, ecc.)42. Le ricerche che seguono intendono appunto muoversi in questo ampio ventaglio di possibilità.
La teoria del discorso è stata finora applicata alla formazione individuale della volontà, trovando conferma nell’ambito della filosofia morale e dell’etica. Ma è sufficiente adottare una prospettiva funzionalistica per capire perché una morale guidata da princìpi debba oggi per forza allearsi al diritto positivo43. I problemi affrontati dal diritto fanno allora immediatamente saltare in aria il punto di vista astrattamente normativo di considerare le cose. La teoria discorsiva del diritto (e dello Stato di diritto) deve saper oltrepassare i percorsi tradizionali della filosofia del diritto e dello Stato, pur ereditandone temi e problematiche. Nei capitoli 1 e 2 del libro intendo spiegare due cose: in che senso la teoria dell’agire comunicativo debba concedere una posizione centrale alla categoria del diritto, e in che senso essa formi il contesto più appropriato per una teoria discorsiva del diritto. Così facendo, cerco di elaborare un approccio ricostruttivo che accolga in sé le due diverse prospettive della teoria sociologica del diritto e della teoria filosofica della giustizia. Nei capitoli 3 e 4 viene ricostruito, dal punto di vista della teoria discorsiva, il contenuto normativo implicito...