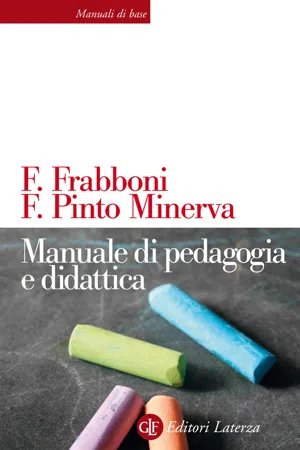III. La pedagogia tra soggetto, cultura, società
Premessa
Il soggetto, la cultura e la società – nell’intensa dialettica del nesso che lega le rispettive istanze – si incontrano e si scontrano, si condizionano e si modificano vicendevolmente, stratificando complesse dinamiche di interdefinizione, di cui gli stessi processi educativi sono contemporaneamente testimoni e promotori.
In questa prospettiva, la centralità pedagogica della transazione tra soggetto, cultura e società sollecita la pedagogia a indirizzare la riflessione su ciascun elemento di tale relazione, reinterpretando in chiave pedagogica gli approfondimenti prodotti dalle discipline che, in maniera peculiare, se ne occupano: la psicologia, l’antropologia e la sociologia.
La psicologia e la psicoanalisi consentono alla pedagogia di riflettere sulla complessità multidimensionale che caratterizza ciascun individuo umano, nella particolarità dei suoi percorsi di sviluppo e di apprendimento, approfondendo una questione centrale e fondante per entrambe le scienze: l’antinomia fra logos ed eros.
Per quanto riguarda il logos, la dimensione più squisitamente cognitiva dell’individuo, esso va affrontato nell’ambito del rapporto tra mondo interno e mondo esterno. La diversa accentuazione del ruolo della realtà interna al soggetto oppure del ruolo della realtà esterna ha dato luogo a due diverse interpretazioni dei processi di modificabilità e di educabilità. Nel caso dell’accentuazione dei fattori intrinseci all’organismo, il processo di modificabilità è inteso come processo di sviluppo in gran parte geneticamente predisposto (è il caso delle teorie di Piaget). Nel caso dell’accentuazione dei fattori estrinseci all’organismo, tale processo è inteso, al contrario, come conseguenza di un progressivo apprendimento di conoscenze, competenze, abilità attivate da specifiche esperienze condotte nell’ambiente di vita. La nostra ricognizione ha inteso evidenziare posizioni talora radicali nell’accentuazione dei fattori interni ovvero dei fattori esterni e, parallelamente, mettere in rilievo originali tentativi di sintesi e integrazione.
La nozione di ambiente, a sua volta, si è presentata diversamente connotata a seconda che se ne sia valorizzata la dimensione fisica e percettiva (è il caso delle teorie comportamentista e gestaltista), la dimensione contestuale e storico-culturale (è quella che fa capo alla teoria sociale di Vygotskij), la dimensione storico-affettiva (è l’interpretazione della psicologia dinamica). Gli studi e le ricerche su tali questioni sono, in realtà, molto più complessi e sfumati di quanto da noi schematicamente delineato al fine di far emergere i contributi più significativi ed esemplificativi del complesso e dialettico rapporto tra struttura interna e influenze esterne, a partire dal quale delimitare e precisare lo spazio specifico della riflessione e dell’operatività pedagogica.
Per quanto riguarda l’eros, invece, è da notare come il panorama già frastagliato e diversificato offerto dal logos riceva ulteriori arricchimenti e complicazioni. L’irruzione dell’eros, con la sua componente pulsionale, emozionale e sessuale, nella qualificazione dei rapporti che il soggetto intrattiene con se stesso, con gli altri e con il proprio ambiente di vita, spiazza e mette in crisi antiche certezze. Con la scoperta dell’inconscio, la ricerca si avventura nei territori impervi del «non detto» e del «non dicibile» con l’intento di «dar voce» a quella parte di se stessi che non parla la medesima lingua della ragione. La ragione altra del desiderio e della sensualità mette in crisi il suo doppio, la dimensione più dogmatica e assoluta della razionalità monocentrata.
A metà tra ragione e desiderio, anche questo itinerario psicologico – ricostruito con la logica della pedagogia – vede riconfermata per intero la categoria della differenza. Differenza di formae mentis tra soggetto e soggetto, differenza di stili cognitivi, di tempi e ritmi conoscitivi, ma anche differenza irriducibile dei modi di vivere emozioni, sentimenti, desideri. Ogni individuo, dall’interno delle mille sfaccettature della propria storia personale – che è storia biologica, storia cognitiva e storia affettiva – si incammina su un sentiero che, da un lato, lo accomuna al resto dell’umanità e, dall’altro, lo riporta all’unicità e all’irripetibilità della sua mente e del suo cuore.
L’approfondimento della dimensione autocostruttiva dell’intelligenza, l’individuazione dei nessi linguaggio-pensiero-emozioni, la riflessione sul ruolo svolto dai differenti media in relazione alle molteplici forme dell’intelligenza, il riconoscimento della funzione insostituibile dell’istruzione nell’attivazione del potenziale mentale, sono – tutti e in egual misura – temi e problemi cruciali per il pensare pedagogico e per l’agire educativo.
L’incontro con l’antropologia offre alla pedagogia l’opportunità di ritornare a quell’antinomia natura-cultura già incontrata nello studio delle interrelazioni tra la pedagogia e la biologia. Nel rapporto con la biologia l’attenzione si era concentrata sul primo polo di tale antinomia e sui vincoli posti ai processi adattivi da strutture e funzioni neurobiologiche geneticamente preordinate, nonché sul sistema di scambi che intercorrono fra tali strutture e le sollecitazioni dell’ambiente. Nel rapporto con l’antropologia la prospettiva si sposta sul secondo polo dell’antinomia e sul peso che le variabili culturali esercitano nel determinare la specificità delle forme espressive e comunicative, nonché la varietà delle rappresentazioni simboliche del mondo e la complessità delle strategie messe in atto per affrontare e risolvere i molteplici problemi posti dall’istanza della sopravvivenza biologica e culturale. La categoria della differenza – fondamentale nello studio e nell’interpretazione dei fenomeni biologici – si rivela, anche in questo caso, centrale e irrinunciabile.
Il dibattito antropologico sulle culture altre, la problematizzazione del nesso pensiero-linguaggio-cultura e, soprattutto, il riconoscimento del ruolo delle culture di appartenenza nella strutturazione della personalità di base hanno permesso di evidenziare come la concreta attuazione del diritto alla differenza richieda un progetto pedagogico opportunamente mirato, programmato e verificato. All’interno di tale progetto, l’obiettivo del rispetto e della valorizzazione delle differenze culturali perde la genericità delle dichiarazioni di principio e si salda alla ricerca conoscitiva delle analogie e delle divergenze che caratterizzano le diverse culture. Si salda, altresì, all’acquisizione di specifiche competenze nel confronto attraverso esercizi di decentramento cognitivo e sociale e attraverso la sperimentazione della produttività della ricerca di più punti di vista da cui analizzare e interpretare la realtà.
La sociologia, infine, offre alla pedagogia l’opportunità di riflettere sull’influenza che i sistemi sociali hanno sui modelli della socializzazione e dell’alfabetizzazione, approfondendo un’ulteriore antinomia pedagogica: quella fra autorità e libertà, fra vincoli di natura istituzionale (regole, norme e valori dell’agire sociale) e autonomia del soggetto.
In particolare, la ricerca sociologica ha individuato e analizzato la peculiarità e la specificità con cui ciascuna istituzione realizza la propria funzione di socializzazione, differenziando tra la socializzazione mediata dalle istituzioni specializzate e intenzionalmente orientate (la famiglia e la scuola) e quella immediata e diffusa all’interno della città quale luogo di scambi amicali, associativi, lavorativi, ricreativi, multimediali.
La famiglia, la scuola e la città sono state analizzate utilizzando una doppia chiave di lettura: da una parte, se ne è evidenziata la funzione autoritaria e repressiva; dall’altra, se ne è mostrata la funzione di liberazione ed emancipazione. Per molti versi famiglia, scuola e città sono viste come luoghi dell’esclusione e della marginalità, della subordinazione e dell’omologazione, della solitudine e della disgregazione esistenziale; per altri versi, sono interpretate e proposte come luoghi di arricchimento cognitivo e affettivo, di moltiplicazione dei linguaggi, delle intelligenze, delle culture.
In breve. La riflessione sui nessi soggetto-cultura-società, realizzata attraverso il contributo conoscitivo della psicologia, dell’antropologia e della sociologia, consente alla pedagogia di evidenziare e rendere esplicita la specificità e l’originalità della propria progettualità, sul versante dell’indicazione del telos della formazione (l’emancipazione e la liberazione da tutte le forme di dipendenza sociale, culturale, cognitiva e affettiva) nonché degli obiettivi specifici dei processi di insegnamento-apprendimento. Le consente, inoltre, di rielaborare, secondo un’ottica teorica e pratica, i temi della diversità e dell’uguaglianza e di evidenziare il ruolo dei differenti contesti dell’educazione-istruzione-formazione.
1. Soggetto
1.1. Le dimensioni del «logos»
1.1.1. L’approccio psico-genetico
Con Jean Piaget (1896-1980) si realizza una prima mediazione tra mondo interno e mondo esterno. In tal senso vengono superate tanto le concezioni psicologiche più radicalmente preformiste (che sostengono la presenza nella mente di principi o idee innate, presupponendo l’esistenza nel soggetto di strutture cognitive a priori) quanto le concezioni ambientaliste (che fanno derivare i contenuti della mente dall’esperienza, sottovalutando l’attività del soggetto nella costruzione delle conoscenze).
La meta evidente della ricerca piagetiana è quella di approdare sulle spiagge di un attivo costruttivismo. Se è vero che il funzionamento dell’intelligenza possiede una base geneticamente vincolata, è vero, allo stesso modo, che l’intelligenza produce la costruzione delle strutture della cognizione solo nel corso delle esperienze concretamente effettuate dal soggetto a contatto con gli oggetti e le persone del proprio ambiente.
La conquista dell’intelligenza superiore (cioè della logica formale) è l’esito di un lento e articolato processo di ricerca di equilibrio tra le strutture mentali del soggetto e i dati del mondo esterno. L’intelligenza, infatti, nella sua fondamentale funzione di adattamento all’ambiente, si avvale dialetticamente dei meccanismi funzionali dell’assimilazione e dell’accomodamento. Attraverso l’assimilazione, la mente include, entro le proprie strutture mentali, gli elementi dell’ambiente esterno; attraverso l’accomodamento essa modifica le strutture di cui dispone quando queste, per effetto dell’assimilazione, si rivelano inadeguate a includere al proprio interno ulteriori oggetti ed elementi. L’intelligenza, in tal modo, «mette ordine» nel flusso delle informazioni che le giungono dall’esterno e, al contempo, modifica le forme stesse delle proprie «attività ordinatrici» (per utilizzare il linguaggio piagetiano, delle proprie strutture). In breve, la mente costruisce il mondo costruendo se stessa.
Questa tesi di originale integrazione tra fattori strutturali e fattori ambientali trova il proprio fondamento nella proposizione dello strutturalismo genetico, che rappresenta la sintesi delle due più importanti e contrapposte interpretazioni dello «sviluppo», al centro del dibattito scientifico della prima metà del Novecento: la teoria dello «strutturalismo senza genesi» e la teoria della «genesi senza struttura».
La prima è la teoria che considera l’evoluzione dell’organismo umano totalmente determinata da alcune «strutture interne» già date, costitutive del patrimonio genetico del soggetto umano e scarsamente modificabili dall’influenza ambientale. La seconda considera l’evoluzione dell’organismo umano del tutto soggetta all’azione modificatrice delle «influenze esterne», perché privo di str...