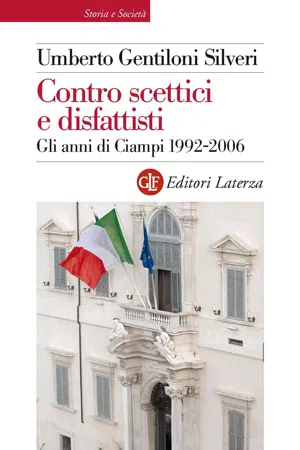1. “Una frattura storica”
1.1. Sull’orlo del baratro
Nei primi anni Novanta del secolo scorso l’Italia entra nel vortice di una trasformazione senza precedenti, immersa in una fase di profondi cambiamenti degli assetti internazionali. Tutto appare in movimento, difficile trovare una convincente graduatoria di urgenze e priorità che si materializzano nel breve spazio di alcuni mesi. Crisi finanziaria, politica e istituzionale si sovrappongono; interrogativi inevasi riguardano la tenuta del sistema Paese e le strategie di risposta delle classi dirigenti. La “stagione di Tangentopoli” mette in discussione il rapporto tra eletti ed elettori e la credibilità di un’intera architettura politico-istituzionale; la stessa identità nazionale è a rischio, sottoposta a critiche e verifiche continue.
Un contesto difficile, condizionante, per molti versi inedito e imprevedibile. Il tempo aiuta a definire contorni e problematiche, ma il passaggio tra la fine degli anni Ottanta e il decennio successivo consegna lasciti ed eredità che si spingono molto al di là degli anni e degli eventi considerati.
Una lunga ombra che condiziona il cammino della Repubblica e le sorti di quella che ben presto verrà definita come una transizione; un cammino dagli approdi incerti, una ricerca di risposte e soluzioni che ancora oggi, dopo alcuni decenni, non trova conferme rassicuranti, pur cominciando a interessare studiosi di diverse discipline.
Più ci si allontana da quel tornante e meglio si vede la natura di cesura periodizzante che accompagna il periodo immediatamente successivo al 1989. Sono almeno due gli aspetti che meritano attenzione e motivano la tensione interpretativa degli anni successivi. In primo luogo la coincidenza e la sovrapponibilità tra il quadro interno della Repubblica italiana e il contesto internazionale della Guerra Fredda: il crollo del primo trova conferme e spiegazioni in una più ampia ridefinizione di equilibri e rapporti di forza. Troppo spesso la scorciatoia di spiegazioni semplicistiche o monocausali ha portato fuori strada, verso ipotesi interpretative segnate dall’urgenza del momento o da un uso strumentale e distorto del passato. In secondo luogo si evidenzia la debole valenza di una ricostruzione basata sulle presunte successioni di repubbliche non meglio definite o definibili. Cosa distinguerebbe la prima dalla seconda e soprattutto quando e perché sarebbe possibile narrare e interpretare una fase nuova, in base a quali assunti e riferimenti? Interrogativi che ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi anni e che rimandano direttamente a un complesso di eventi e questioni che tengono insieme il crollo del muro di Berlino, l’avvio delle inchieste di Mani Pulite, l’instabilità internazionale e le spinte separatiste che si affacciano nel Nord Italia.
Negli anni successivi si è rovesciato il paradigma interpretativo: dagli accenti e dalle speranze di un nuovo inizio possibile e ravvicinato si è passati agli inquieti scenari di un mondo senza regole e di una transizione senza approdi rassicuranti. Molti temi sono arrivati fino al tempo presente, aggravati da fattori inediti che hanno contribuito a sedimentare un senso di inquietudine e incertezza della nuova fase.
Carlo Azeglio Ciampi ha usato il termine “frattura” come definizione della strettoia riconducibile al 1992. Una frattura nella sua biografia, che lo proietta dalla Banca d’Italia (dopo quasi mezzo secolo) all’impegno politico, ma anche una cesura per la storia del Paese per le compatibilità delle sue strutture, per la compromessa tenuta di istituzioni e poteri dello Stato. Sul suo Diario nei primi giorni del nuovo anno (9 gennaio 1992) annota impressioni e giudizi scaturiti da un incontro con il presidente della Camera dei deputati Giorgio Napolitano; l’indicazione è chiara: «Mi parla della situazione politica (che definisce caotica) ed economica. Su quest’ultimo punto rinnovo le mie consuete posizioni in merito soprattutto all’Italia nell’Europa e auspico che la prossima campagna elettorale si incentri sui “problemi”: a mio avviso il governo che uscirà dal nuovo Parlamento dovrà adottare una politica economica d’urto».
L’“urto” richiama l’urgenza di un momento particolarmente delicato. Vale la pena richiamare gli elementi di contesto: campagna elettorale incerta (segnata dal persistere di una instabilità politica di lungo periodo); il presidente Cossiga a fine mandato che minaccia dimissioni anticipate o pressioni per indirizzare una crisi complessa verso soluzioni più stabili; lo stesso governatore della Banca d’Italia viene sollecitato da offerte di candidature o proposte di partito. La sua linea si ispira a una duplice convinzione, per la verità poco in auge in quegli anni: da un lato la centralità della guida politica, dall’altro l’urgenza di intervenire decisamente, non subire passivamente il corso degli eventi. Il 5 maggio consegna alla pagina del suo Diario un distillato del suo convincimento: «Mi esprimo contro l’ingresso di tecnici nel governo ed auspico la costituzione di un governo che duri più anni e che dedichi i primi due al risanamento economico». Anche nel caso di un coinvolgimento personale (un dicastero economico?) reagisce senza mediazioni cercando di mostrare la contraddizione di una classe politica che per rinnovare e salvare il Paese fa ricorso ai tecnici, a competenze che non sono sottoposte alle dinamiche del processo democratico. Sarebbe stato fuorviante e pericoloso rinunciare alle prerogative di scelta e di indirizzo della politica e di una classe dirigente responsabile. Il tempo avrebbe ridimensionato le speranze e le analisi del governatore; altre stagioni vicine a noi ripropongono i termini di un rapporto complesso e contraddittorio tra funzione politica e competenze tecniche.
Una politica che si assuma responsabilità e oneri di un passaggio così delicato in grado di rimettere in moto energie e risorse per evitare il peggio, lo scivolamento inconsapevole verso lidi pericolosi. Sembra essere questa la stella polare del governatore Ciampi: un’accorata richiesta per l’assunzione di compiti e scelte necessarie, non si poteva dilapidare il tempo prezioso ritardando le risposte in un futuro indefinito e comunque troppo lontano. Ma il suo appello non trova interlocutori in grado di tradurlo in politiche adeguate. E così nel breve spazio di alcune settimane la situazione sembra degenerare ulteriormente. Uno sguardo preoccupato e per molti versi profetico; si trattava di un punto di non ritorno.
Ma quali sono gli elementi ricorrenti dell’analisi del governatore Ciampi? Quali gli aspetti evidenziati nelle sue note, nei suoi interventi e nelle conversazioni sulle tumultuose giornate del 1992? Riassumendo il suo interrogarsi su ciò che stava avvenendo si possono richiamare tre grandi motivazioni che lo spingono verso l’inquietudine e che lo collocheranno (con una buona dose di inconsapevolezza) in nuovi ruoli e funzioni negli imminenti sviluppi della transizione italiana. Innanzitutto il sistema internazionale sconvolto dal 1989 perde regole e riferimenti (in particolare nel rapporto tra la politica e l’economia) e sembra incerto sul cammino da percorrere. Ciampi non si iscrive alla schiera degli entusiasmi immediati e dei facili ottimismi, semmai si interroga con crescente preoccupazione su quale potrà essere il nuovo assetto di regole e indirizzi della politica internazionale. Torneremo più avanti su questo aspetto, ma un tratto di continuità nel suo percorso biografico risiede proprio nella consapevole ricerca di un rapporto sinergico e costruttivo tra l’Italia, la sua collocazione e gli scenari più ampi delle relazioni internazionali. In secondo luogo si coglie una profondità di analisi e di giudizio sul tema della instabilità del sistema Paese; non tanto riconducibile alle difficili composizioni di maggioranze di governo quanto alla incoerenza e inadeguatezza di fronte alle sfide che appaiono all’orizzonte. Un sistema instabile e diviso non può affrontare il peso di una crisi profonda che non risparmia i pilastri dell’architettura politico-istituzionale. In un contesto così drammatico irrompe la novità dell’azione della magistratura nei confronti di politici e imprenditori in una commistione di interessi e vantaggi che pregiudica pesantemente il corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Il 17 febbraio 1992 l’arresto di Mario Chiesa inaugura la stagione di Mani Pulite accentuando così i tratti di debolezza e progressivo distacco delle classi dirigenti; il pool di Milano conduce l’inchiesta. Più la frattura si manifesta nei suoi termini reali di sfida alla rifondazione del sistema Paese e più si evidenzia l’incapacità di poter offrire un rimedio o comunque un percorso condiviso per tentare di uscirne positivamente. Ciampi avverte il rischio dell’immobilismo e sente la responsabilità di chi ricopre funzioni e indirizzi generali. La sua valutazione è scissa dal destino personale, non trova riscontro in ambizioni o richieste individuali. Anche questo è un tratto distintivo del suo sguardo sull’Italia di allora. In molti cominciano a cercare collocazioni di prestigio o possibili promozioni in prima fila; aumentano le liste di potenziali generali senza esercito in cerca di fortune o visibilità mediatiche. La caduta di regole e indirizzi condivisi, la fine imminente dei grandi partiti che avevano attraversato la prima fase della Repubblica lasciano spazi per dinamiche e culture imprevedibili. Se ne avrà contezza soltanto qualche anno dopo, alla metà del decennio nel nuovo contesto della dialettica di un bipolarismo difettoso e per molti versi incompleto e squilibrato.
Il governatore Ciampi passa nello spazio breve di poche settimane dalla richiesta di uscire di scena ai riflettori di Palazzo Chigi. Il suo Diario riflette il succedersi di situazioni e stati d’animo in un processo significativo che non è emerso con la giusta attenzione nella ricostruzione dell’ingresso in politica di Carlo Azeglio Ciampi.
Il 16 gennaio del 1992 annota con precisione, mettendo quasi le mani avanti rispetto a scenari imprevedibili: «Amato mi rinnova, a nome dell’on. Craxi, l’invito ad accettare la candidatura per il Senato alle prossime elezioni (ad esempio Milano) per potermi utilizzare in un futuro governo al Tesoro. Ringrazio, ma rifiuto, precisando che non accetterò eventuali analoghe proposte da altri partiti e che ho già preparato la lettera di dimissioni da governatore, che presenterò al ministro del Tesoro del governo post elezioni». La lettera verrà indirizzata ai destinatari senza che abbia un seguito nelle verifiche del nuovo esecutivo scaturito dalle elezioni politiche del 5 aprile.
Settimane frenetiche si succedono. Il voto lascia intravedere una lieve maggioranza per il quadripartito fondato sull’asse Dc-Psi. Il 17 aprile il Consiglio dei ministri (uscente) dà il via libera agli accordi di Maastricht, il 23 si apre la nuova legislatura e due giorni dopo il presidente della Repubblica Cossiga annuncia le sue dimissioni aprendo la corsa tra i pretendenti al Quirinale. Ciampi osserva, dialoga in colloqui riservati. Si intrattiene con l’avvocato Agnelli mentre si svolgono le prime votazioni sul nuovo presidente: «Si è a una situazione di stallo. Agnelli ritiene che alla fine si arriverà ad una soluzione istituzionale con la nomina del presidente della Camera Scalfaro o del Senato Spadolini. Aggiunge che ricorre sempre più il mio nome per il governo, addirittura come presidente del Consiglio. Alla mia reazione che la Presidenza del Consiglio è funzione squisitamente politica, Agnelli replica ricordando Barre in Francia».
I ricordi affiorano dal passato con precisione. Poche ore dopo tocca all’onorevole Vincenzo Scotti, che ipotizza l’approdo di Ciampi al Colle come probabile conclusione di un iter segnato dal fallimento della candidatura Vassalli e l’insuccesso della via istituzionale. Ciampi ricorda con partecipazione quei momenti: «Era venuto nel mio studio dicendomi: “Caro governatore, oggi abbiamo il candidato che è Vassalli. Non avrà la maggioranza, non verrà eletto, avremo una nuova impasse. Tra le ipotesi percorribili rimangono solamente i presidenti della Camera e del Senato. Neppure sui loro nomi si troverà l’accordo e a quel punto toccherà a lei”». La previsione non era appropriata, un senso di confusione e incertezza accompagna la successione degli eventi in un tornante di svolta.
Il governatore ribadisce di non voler entrare nelle manovre politiche che prefigurano la nuova coalizione di governo, insiste su tre necessità: riforme economiche, rigore nella politica dei redditi e interventi sulla previdenza. Ma non c’è spazio per grandi strategie o ipotesi di intervento. La strage di Capaci irrompe sulla fisiologica dialettica politico-parlamentare (e non solo su quella). Il 23 maggio annota una riga senza commenti, non era possibile aggiungere altro: «Ore 19.45. La televisione dà notizia dell’uccisione a Palermo del giudice Falcone, della moglie e della scorta». Poche ore dopo Oscar Luigi Scalfaro sarebbe diventato il nono presidente della Repubblica italiana.
Ciampi e Scalfaro non si conoscevano, pur essendo accomunati dalle vacanze a Santa Severa, a nord della Capitale. «Malgrado avessimo la nostra seconda casa a duecento metri di distanza non ci frequentavamo», ricorda Ciampi. «Lui in genere predilige andare verso Tolfa, in montagna, per passeggiare, mentre io me ne vado verso il mare. Quindi era una divisione naturale del nostro tempo libero verso direzioni opposte, la montagna o il mare. Credo che raramente ci siamo fermati per scambiare due parole; non che ci fosse nulla tra di noi, avevamo due ambienti di amicizie e frequentazioni differenti».
Quando Scalfaro, in quella terribile estate del 1992, viene eletto al Quirinale, il governatore sente il dovere di renderlo partecipe del contesto drammatico che sfugge al controllo e alle attenzioni dei più: la profondità della crisi finanziaria. Un gesto dei vertici di “Bankitalia” in una fase difficile e molto rischiosa per la tenuta del nostro sistema economico. Non si poteva perdere altro tempo, sarebbe stato irresponsabile ridimensionare la portata del fenomeno.
«In quel preciso passaggio di fase – ricorda ancora Ciampi – il pericolo non era tanto il tasso di cambio della lira, che si poteva eventualmente accomodare con una svalutazione. Mi sembrava drammatica l’incapacità del governo di far fronte agli impegni di debitore nei confronti di coloro che in Italia e all’estero finanziavano lo Stato con cambio titoli».
Scalfaro è molto colpito dall’analisi del governatore e dalle possibili ricadute della situazione. Ciampi torna volentieri sul rapporto instauratosi a partire dalle analisi sulla congiuntura: «Devo dire sinceramente che a differenza di altri presidenti, ad esempio Sandro Pertini, che ebbero una scarsa sensibilità rispetto a questa materia, lui ne afferrava pienamente l’importanza; da quel momento cominciammo a incontrarci con frequenza al Quirinale. Incontri riservati, tra noi due, che si ripetevano nel tempo, dilungandosi a seconda degli argomenti o delle suggestioni che ci interessavano maggiormente. Il presidente chiedeva conto della situazione economico-finanziaria, cercava di raccogliere informazioni e contestualmente cominciava a confidarsi con me sulla situazione politica. Eravamo in una situazione di difficoltà e pericolosità estrema».
Una relazione particolare, per molti versi imprevista e inaspettatamente duratura oltre che di recip...