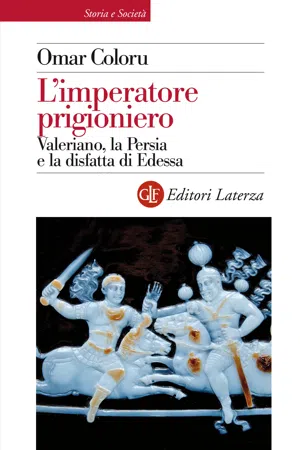I.
Un mondo
in mutamento
1. Come muoiono e nascono gli imperi
Il 28 aprile 224 d.C., nella pianura dove sorgeva la città di Hormozgan (Iran meridionale), si svolse una grande battaglia campale il cui esito avrebbe cambiato il corso della storia. Da un lato stava l’esercito comandato da Artabano IV (Ardawan), re dei Parti, esponente di una dinastia che dal III secolo a.C. regnava su una vasta area che dalla Mesopotamia arrivava ai confini dell’odierno Afghanistan. Il fondatore del regno, Arsace I, era un individuo di oscure origini che, messosi alla testa di un gruppo di nomadi di stirpe iranica, aveva ottenuto il controllo della Partia. Era questa una regione del Turkmenistan meridionale poco urbanizzata, ma importante crocevia di traffici commerciali sulla Via della Seta. Nel corso dei secoli la dinastia degli Arsacidi era riuscita a conquistare sempre più territori a spese dei regni vicini, fino a raggiungere le dimensioni di un grande impero che a ovest confinava con i possedimenti romani. Fu così che gli interessi dei Parti cominciarono a scontrarsi con quelli dei loro potenti vicini e il regno di Partia diventò di fatto il principale avversario di Roma in Oriente. Nel corso della storia, i rapporti tra i due Stati conobbero fasi alterne caratterizzate da scontri di proporzioni tragiche, come la disfatta inflitta dai Parti a Marco Licinio Crasso a Carre nel 53 a.C. o come l’avanzata dell’imperatore Traiano all’interno del regno avversario fino alle coste del Golfo Persico, dove l’optimus princeps eresse un monumentale trofeo per celebrare la sua vittoria.
Nel periodo di cui ci stiamo occupando, i Parti stavano attraversando una crisi che si sarebbe rivelata irreversibile. Durante il regno di Vologese V (Balash, 192-207), padre di Artabano, il regno aveva dovuto subire due attacchi da parte dell’imperatore Settimio Severo: il primo nel 196 e il secondo nel 198, quando l’esercito romano riuscì pure a saccheggiare la capitale Ctesifonte. Come se non bastasse, Vologese aveva dovuto affrontare delle rivolte interne. Alla sua morte, il regno passò nelle mani del figlio Vologese VI, ma pochi anni dopo, intorno al 213, Artabano, che era il fratello minore, contestò la sua autorità e a sua volta si proclamò re. In un primo tempo venne riconosciuto nell’Iran settentrionale, poi la sua sovranità venne accettata nella maggior parte delle province del regno. Vologese, però, continuò ad esercitare il suo potere in alcune aree della Mesopotamia e forse in alcune città come Seleucia al Tigri. Sul fronte esterno, Artabano dovette scontrarsi coi Romani. Approfittando del clima di instabilità dinastica del regno di Partia, l’imperatore Caracalla aveva infatti dato il via a una grande campagna militare nel 216. La guerra proseguì fino al 218 e si concluse con la vittoria di Artabano: secondo lo storico Cassio Dione egli ottenne un’esorbitante indennità di guerra, pari a cinquanta milioni di denari, più un numero imprecisato di doni. Ciò nonostante, non poté evitare la profanazione delle tombe reali arsacidi ad Arbela, un gesto che assestò un duro colpo alla sua credibilità. Inoltre, la questione del fratello Vologese rimase irrisolta, tanto che costui continuò a battere moneta in suo nome fino al 222. Di conseguenza, questi problemi avrebbero impedito ad Artabano di dedicare l’attenzione necessaria a quanto stava accadendo all’interno del suo stesso regno.
In effetti il nemico che Artabano si apprestava a combattere nella piana di Hormozgan veniva dalla regione della Persia (nota anche come Perside, oggi Fārs), una regione ricca di importanti memorie storiche per le popolazioni iraniche. Già culla dell’impero achemenide, a partire dal III secolo a.C. la Persia era stata governata da una dinastia di sovrani prima in modo indipendente, e poi in qualità di vassalli dei Parti. Ardashir (fig. 1), questo il nome del rivale di Artabano, aveva accresciuto il suo potere proprio in questi anni così tormentati per l’impero partico, cosicché quello che in precedenza era stato considerato un trascurabile problema di livello locale, cominciò ad assumere le proporzioni di una rivolta che metteva in pericolo la stessa sopravvivenza del regno. Ma chi era Ardashir? E come era riuscito ad arrivare fino allo scontro diretto con Artabano?
La storia di questo personaggio non è facile da ricostruire, perché nel corso dei secoli si sono accumulate molteplici tradizioni che hanno creato un complesso narrativo in cui è piuttosto arduo riuscire a districare la realtà dal mito. In effetti, la famiglia di Ardashir si vantava di discendere da un certo Sāsān, il quale aveva poi dato il suo nome a tutta la dinastia, i Sasanidi. Inizialmente onorato dai suoi discendenti in virtù del suo ruolo di capostipite, più tardi, quando i Sasanidi diventarono i nuovi signori dell’Oriente, Sāsān acquisì i caratteri di un personaggio straordinario grazie non solo a invenzioni letterarie, ma anche all’intervento della corte che voleva nobilitare il fondatore della dinastia. È così che sul suo conto nacquero numerose storie, che lo videro diventare un discendente degli Achemenidi, un sacerdote del tempio del fuoco, il marito di una principessa dei re della Persia dalla cui unione nacque Pabag, il padre di Ardashir. È anche probabile che Sāsān sia stato divinizzato per fornire alla dinastia una discendenza divina e una legittimazione del suo potere ancora più forte. In questo caso, si tratterebbe di un’eco della pratica ellenistica della divinizzazione del sovrano risalente all’epoca in cui la Persia era una provincia del regno greco-macedone dei Seleucidi.
Nel suo poema epico Shahnamē, “Libro dei re”, il poeta persiano Firdūsī (940-ca. 1020) sembra avvalorare l’ipotesi di un’origine orientale per la famiglia di Sāsān. Sappiamo che per la composizione di questo poema sulla storia dell’Iran Firdūsī aveva attinto a un ricco repertorio di fonti sia scritte sia orali e in particolare alla traduzione araba di una cronaca reale sasanide poi andata perduta, il Xwadāy-nāmag, “Libro dei re”. L’opera, redatta nel VI secolo, conteneva la versione “ufficiale” della storia dei Sasanidi e delle loro imprese. Il poeta racconta che al crollo dell’impero achemenide gli antenati di Sāsān si sarebbero rifugiati in India. Ora, è interessante notare che questa notizia può ricollegarsi a eventi che risalgono ai primi decenni del I secolo d.C., quando l’Afghanistan meridionale e l’India nordoccidentale vennero a trovarsi sotto il dominio di un clan partico originario del Sistan (Iran sudorientale). Il fondatore di questo regno, Gondophares, noto anche dagli Atti apocrifi dell’apostolo Tommaso, aveva affidato il governo dei vari distretti da lui conquistati a membri della sua famiglia o a sovrani locali che erano divenuti suoi vassalli. Alla sua morte i possedimenti furono contesi fra gli eredi, chiamati Indo-parti. Tra questi, c’era anche un individuo che sulle iscrizioni monetarie greche era chiamato Sases, un nome che richiama quello di Sāsān.
Prese così, queste informazioni potrebbero sembrare il frutto di una coincidenza, tuttavia altri dati sembrano avvalorare tale impressione. Il nome Sāsān ricorre ancora una volta nel nome del sovrano indo-partico Adur-Sāsān e poi di suo figlio Farn-Sāsān, un contemporaneo di Ardashir il cui regno, all’epoca, era ormai limitato al Sistan. Infine, il simbolo dinastico che compare sulle monete del re indo-parto Sases è lo stesso che ritroviamo rappresentato sulla cavalcatura del figlio di Ardashir, Shapur, su un rilievo rupestre di Firuzabad nel quale si celebra la battaglia di Hormozgan. I dati qui riportati possono perciò suggerire che la stirpe di Ardashir fosse in qualche modo legata all’Iran orientale.
Per parte loro, gli storici greco-romani non ci danno informazioni precise sulle origini della dinastia e si limitano a dire che Ardashir veniva dalla Persia, mentre le fonti bizantine, al contrario, puntano l’attenzione sui poco nobili natali di Sāsān, definendolo un oscuro persiano, un soldato, o addirittura uno schiavo. Dall’analisi delle fonti persiane, più tarde, si desume invece che i membri della dinastia sasanide si trasmettevano per via ereditaria la carica di sacerdote della dea Anahita nel tempio del fuoco di Istakhr. Quest’ultimo era un centro situato poco lontano dalle rovine di Persepoli, l’antica reggia dei re achemenidi. Anche il padre di Ardashir, Pabag, aveva svolto lo stesso ruolo e fu proprio lui che nel 205/206 d.C. organizzò una ribellione che portò all’eliminazione del dinasta locale, Gozihr, cominciando così un percorso di conquiste volto a ridurre in suo potere la regione. Pare che proprio la sua funzione di sacerdote di Anahita, una dea dal carattere guerriero molto popolare nel mondo iranico, abbia contribuito a fornire a Pabag un ampio sostegno alla sua causa. Mentre Pabag portava avanti la sua ribellione, Ardashir si sarebbe trovato distante dal teatro degli scontri, perché avrebbe esercitato la carica di ardbeg (governatore) della fortezza di Dārābgird, ai confini orientali della Persia. I problemi sorsero quando Pabag decise di nominare come suo successore il figlio maggiore Shapur, una scelta che evidentemente si scontrava con le ambizioni di Ardashir. Alla morte di Pabag nel 211/212, Ardashir si sarebbe proclamato re e avrebbe iniziato così la sua personale rivolta contro il fratello: lasciata Dārābgird, che si trovava in posizione troppo periferica, egli si trasferì nella città di Ardaxshir-Xwarrah (oggi Firuzabad, nell’Iran meridionale), che divenne la base da dove lanciare i suoi attacchi contro il fratello a Istakhr. Ardashir riuscì in breve tempo ad avere ragione del fratello e a consolidare il suo potere nella regione. Riassumendo, quello che ci è dato di intuire a grandi linee dalle fonti è che Ardashir apparteneva ad una famiglia di nobili locali, forse originari dell’Iran orientale, vassalli dei sovran...