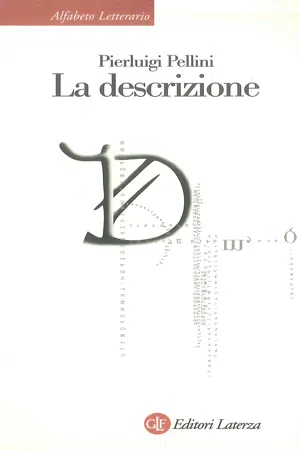1.
Una definizione problematica
Di che parla questo libro
Una buona definizione empirica potrebbe essere questa: sono descrizioni quelle parti di un testo narrativo che il lettore medio tende a saltare.
L’interesse di un romanzo risiede nella storia raccontata, nelle peripezie dei personaggi, nella suspense narrativa: al lettore importa conoscere la sorte dell’eroe, non il colore e la foggia delle tende del salotto di un personaggio minore. La descrizione, spesso, suscita impazienza, appare inessenziale, annoia.
Per una volta, i teorici della letteratura sembrano dare ragione al lettore medio. Insistono quasi sempre sul carattere subalterno della descrizione, che deve essere funzionale alla logica del racconto, e non può mai rendersi autonoma.
Fanno eccezione i pezzi di bravura, la cui inutilità a livello di intreccio è riscattata dalla funzione estetico-ornamentale. Infatti, una delle operazioni più frequenti nella storia della critica consiste nell’estrarre descrizioni celebri dal loro contesto: per cui lo scudo di Achille, il ritratto della monaca di Monza e i campanili di Martinville non possono mancare in nessuna antologia delle rispettive letterature.
Rifiutata o esaltata: la descrizione ha uno statuto ambiguo, è difficilmente definibile, ha una storia molto complessa – non sempre si sono descritte le stesse cose, e non sempre sono state usate le stesse tecniche. Per esempio, prima del realismo romantico, erano rarissime le descrizioni letterarie di oggetti bassi, quotidiani, e la materialità corporea non aveva diritto di cittadinanza nei romanzi.
Nella prima parte di questo volumetto, delineando un breve quadro dei principali dibattiti teorici sulla descrizione, e ripercorrendo per campioni la storia delle principali pratiche descrittive dall’antichità al nostro secolo, cercherò di rielaborare strumenti teorici in grado di interpretare caratteristiche e funzioni della descrizione letteraria. Nella seconda parte mi soffermerò su alcuni brani particolarmente significativi, la cui analisi permetterà di approfondire e mettere alla prova i modelli teorici proposti.
La vastità dell’argomento e l’esiguità dello spazio comporteranno molte limitazioni; in particolare, mi soffermerò principalmente su testi francesi del secolo scorso. L’Ottocento è a tutti gli effetti l’età dell’oro della descrizione (non solo di quella realistica); e la storia della letteratura francese, segnata da rivolgimenti bruschi e fratture generazionali nette, meglio di ogni altra consente di individuare situazioni (relativamente) pure, in grado di esemplificare fenomeni testuali altrove meno univoci.
I primi studiosi di retorica (Platone e Aristotele, ma ancora Cicerone e Quintiliano) non dedicano un’attenzione specifica alla descrizione, ricondotta all’ambito dell’elocutio, delle figure stilistiche utili a rafforzare l’effetto del discorso.
Manca una teorizzazione sistematica in materia di descrizione. Il termine descriptio, che in origine indicava la trascrizione di un testo già scritto, è attestato in Cicerone, in Quintiliano e in altri trattatisti, ma sempre affiancato da concetti come enàrgheia, evidentia, diatypòsis, hypotypòsis, con i quali spesso si confonde. La descrizione contribuisce a ottenere effetti di amplificatio e di ornatus. Il concetto di enàrgheia, che i latini traducono evidentia, e che potremmo rendere con rilievo icastico, è testimonianza di uno stretto legame fra rappresentazione letteraria e arti figurative: l’indugio sui dettagli deve rendere l’oggetto visivamente percepibile.
La distinzione fra segmenti narrativi e brani descrittivi rimane fluida: questi ultimi individuano piuttosto un particolare tipo di narrazione, ricco di elementi icastici ed emozionali. L’opposizione più importante non è fra narrazione e descrizione, ma fra narrazione fattuale, spoglia e breve, e narrazione amplificata, ornata, ricca di dettagli e di figure retoriche. Solo nella tarda antichità, in coincidenza con la fioritura del romanzo greco, l’interesse si sposta dal polo della narrazione, breve e sobria, a quello della descrizione, patetica e colorita. Il venir meno della funzione politica dell’oratoria determina l’autonomia dell’esercizio descrittivo, favorita anche dalla voga della letteratura di viaggio.
I trattatisti medievali pongono invece l’accento sul concetto, già antico, di amplificatio: la descrizione, che pure è considerata ancilla narrationis, in particolare da Matteo di Vendôme (secolo XII), contribuisce a rendere comprensibile la narrazione, arricchendola di elementi patetici e di dettagli icastici (i teorici medievali rifiutano l’obscura brevitas). Ma nel concreto delle realizzazioni testuali i rapporti fra essere e fare possono anche invertirsi: è allora la descrizione a generare e condizionare il racconto.
Il Rinascimento torna ai modelli classici della narrazione spoglia, senza peraltro rinunciare alle risorse dell’ornatus. Il manierismo ripropone la dominante descrittiva, che sarà poi caratteristica della prosa seicentesca. La trasformazione del gusto è interpretata esemplarmente, a fine secolo, da Nicolas Boileau (1636-1711), che si scaglia contro la prolissa profusione di dettagli caratteristica del romanzo barocco, il cui autore, «se incontra un palazzo, me ne dipinge la facciata; / mi conduce poi di terrazza in terrazza; / qui si presenta una scala; là domina un atrio, / là quel balcone è chiuso da una balaustra d’oro». Inevitabilmente, dice Boileau, «io salto venti pagine per trovarne la fine, / e a stento me la svigno attraverso il giardino».
Il grande legislatore del classicismo si fa portavoce di una diffidenza largamente condivisa, non solo ai suoi tempi: l’invito a selezionare i dettagli («non vi caricate di un dettaglio inutile») è un vero e proprio leitmotiv nella storia della teoria letteraria. Anche gli autori di romanzi devono applicare la «selezione epica», devono cioè scegliere, stabilire gerarchie, dire solo ciò che è davvero importante. La descrizione può svolgere un ruolo positivo solo in veste subalterna, come ancilla narrationis: funzionale alle esigenze del racconto. Deve chiarire aspetti ambientali indispensabili alla comprensione della storia o all’approfondimento del carattere dei personaggi; non deve mai rendersi autonoma. La descrizione è sfondo, non può ambire al primo piano.
La logica dei testi
La descrizione è imprecisa, superficiale, si sofferma su attributi accidentali, non sull’essenza: ecco un’altra critica che le hanno spesso rivolto i suoi detrattori. Fra questi, i logici di Port-Royal, Antoine Arnauld (1612-1694) e Pierre Nicole (1625-1695), che già nel 1662 contrapponevano descrizione e definizione, a tutto vantaggio della sintetica esattezza di quest’ultima. La definizione ha caratteri di verità e stabilità, risponde a precise leggi logiche; la descrizione si compone di elementi disomogenei, o selezionati arbitrariamente.
Per certi versi è analoga l’obiezione mossa da Paul Valéry (1871-1945), e improntata a un razionalismo classicista che richiede al testo letterario una coerenza ferrea e logicamente necessaria. La successione delle frasi deve apparire «chiaramente non arbitraria». Nel caso della descrizione si verifica «tutto il contrario»: «una descrizione è composta di frasi che si possono, in generale, invertire: posso descrivere questa camera con una serie di proposizioni il cui ordine è all’incirca indifferente».
I segmenti narrativi rispondono a una logica molto più rigorosa: un’azione ne esclude un’altra (per esempio: se l’eroina sposa Tizio, in regime di monogamia non può sposare anche Caio); la successione cronologica è incontrovertibile (un eroe vecchio deve essere stato giovane); ogni scelta di un personaggio condiziona il seguito (una partenza implica un ritorno, una ferita la guarigione...). Soprattutto, c’è una logica interna all’avanzamento della storia, che ha un inizio, uno svolgimento, una fine: quando un equilibrio è raggiunto (la guerra vinta, il matrimonio realizzato...), o quando l’eroe è morto, il racconto è finito.
La descrizione, potenzialmente, è infinita: non ha limiti prestabiliti, può indugiare su dettagli sempre nuovi – e poi su parallelismi e metafore, con progressione analogica inesauribile. Un brano descrittivo si chiude necessariamente solo quando è esaurito il vocabolario: perfino un eroe morto, ormai escluso dall’universo narrativo (non è più in grado di agire), può essere oggetto di interminabili descrizioni.
Di fatto, tutte le descrizioni sono aperte e chiuse da una decisione arbitraria dello scrittore. Potenzialmente, aprono una falla di proporzioni imprevedibili nella solida intelaiatura del racconto. Non a caso, nella tradizione dei testi manoscritti, i brani descrittivi sono fra i luoghi più esposti a corruzioni e manipolazioni: alle ricostruzioni filologiche non resta che affidarsi a fragili congetture.
Perciò certi scrittori, e tutti i maestri di retorica, raccomandano di ordinare gli enunciati descrittivi in griglie che ne lascino prevedere la scansione, assorbendo l’anarchia della lista nella logica di un quadro: i ritratti devono essere svolti dall’alto in basso (dalla testa ai piedi); i paesaggi raffigurati da sinistra a destra (o seguendo l’orientamento dei punti cardinali); le percezioni analizzate in successione sensoriale (vista, udito, odorato...); gli oggetti inseriti in una sequenza temporale fittizia («si vedeva innanzitutto», «poi», «infine»), al limite enumerati in ordine alfabetico.
È quindi eccessivo affermare che i brani descrittivi non presentano «nessun insieme, nessun ordine, nessuna corrispondenza» – è la tesi di Jean-François Marmontel (1723-1799), esposta nell’articolo «Descrizione» della grande Enciclopedia di Diderot e d’Alembert, apparsa fra il 1750 e il 1772 (significativa la consonanza fra il critico illuminista e Valéry). È vero, tuttavia, che introducono nell’opera, potenzialmente, un elemento di disordine, inaccettabile per le poetiche della coerenza e dell’armonia, classiche, idealiste o strutturaliste che siano.
Una diffidenza molto radicata investe anche il carattere spaziale dei brani descrittivi. Il racconto si sviluppa nel tempo, ha un inizio, uno svolgimento, una fine; le azioni, flash-back e anticipazioni a parte, si susseguono in ordine cronologico. La descrizione, al contrario, è sincronica, raffigura un quadro statico (non un’azione dinamica), si espande nello spazio (non nel tempo). Fa concorrenza alle arti figurative, in particolare alla pittura. Tuttavia, mentre queste presentano un’unità sincronica, rendono visibile in un solo colpo d’occhio una porzione di realtà (appunto, il quadro), la scrittura letteraria si sviluppa nel tempo, e la lettura frammenta lo spazio descritto in segmenti cronologici successivi, impedendo di cogliere l’unità sincronica dell’insieme. In realtà, anche la fruizione dell’opera figurativa non può prescindere da un processo temporale; a grandi linee, tuttavia, la distinzione resta valida.
È stato in particolare Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), teorico del neoclassicismo tedesco, ad avere insistito, nel Laocoonte (Laokoon, 1766), su questa contraddizione: non è vero che «ut pictura poësis»; che cioè, come si sosteneva, forzando il senso di un verso celebre di Orazio, la poesia è in grado di ottenere per mezzo di parole gli stessi effetti delle arti figurative. Alla letteratura, che si svilu...