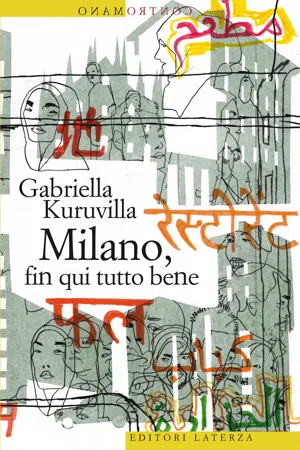Via Padova
“Via Clitumno 11, citofonare Paola Rossi”. Tanto il citofono non funziona, è stato sradicato. Tanto non mi chiamo Paola Rossi, ma Anita Patel. Quindi gli ho dato quel biglietto, sapendo che non riuscirà a scovarmi. Non ho alcuna voglia di rivederlo, forse.
Però è vero che abito in via Clitumno 11. E questo indirizzo, lui, potrebbe anche conoscerlo. Perché non abito in una strada qualsiasi, ma in una traversa di via Padova. Una via piena di immigrati, che ne vedi di tutti i colori. E non abito neanche in una casa qualsiasi, ma in un palazzo di ringhiera. Un palazzo del primo ’900, che non è mai stato ristrutturato.
Sto nello sprofondo, direbbero a Roma: che per me che sono nata a Milano vuole dire oltre il fondo, più o meno. Sto in un quartiere popolare, questo è certo. Sto in un posto dove tutti si salutano, e si parlano: è tutto un gran vociare, in tutte le lingue, in questo posto. È come ascoltare una radio che passa continuamente da una frequenza all’altra, mischiando elettronica, jazz, classica, rap, funk, lirica, reggae, pop, techno e drum and bass, con il gracchio di sottofondo anche. E a volte mi vien voglia di spegnerla. Ma non posso, ci sono in mezzo, a questo gran casino: di persone, di tutti i tipi. “Il troppo stroppia”, avrebbe detto mia madre.
Così, ogni tanto, come chi durante un’immersione ha bisogno di risalire in superficie per prendere una boccata d’aria che gli permetterà di tornare a nuotare nuovamente sott’acqua, salgo le scale, non avendo l’ascensore, vado sul tetto, uscendo da una botola, mi siedo sulle tegole rotte, tra le cacche di piccioni e le antenne delle televisioni, e guardo via Padova dall’alto. Mi metto nella posizione del loto, un fiore sul cemento. E penso che questo quartiere è sempre stato così, e che certo non sarò io a cambiarlo: anche potendo, non vorrei farlo. Mi piace com’è, ma a volte ho bisogno di prendere le distanze: fare il pieno d’ossigeno, e di polveri sottili, prima di potermi rituffare dentro.
Via Padova mi accoglie, sempre. E io mi sento accolta. C’è da dire che a volte il suo abbraccio è un po’ troppo intenso. Via Padova non è che accoglie me perché io sono io, è che via Padova ha sempre accolto tutti: lei si dà a chi la vuole. Certo la devi pagare, magari poco ma la devi pur sempre pagare: come una qualsiasi puttana. Una qualsiasi, vecchia, puttana: che oramai si deve accontentare di una strana clientela, fatta di nostalgici e di avventurieri. Mentre un tempo la volevano tutti, o quasi, perché era piena di fabbriche e di opifici che offrivano lavoro: è stato così che a poco a poco si è saturata di gente. “Chi prima arriva meglio alloggia”, avrebbe detto mia madre.
I primi a trasferirsi qui, agli inizi del ’900, sono stati i brianzoli, i bergamaschi e i mantovani. Poi, dopo la seconda guerra mondiale, c’è stata l’ondata dei meridionali e dei veneti. E alla fine, dai primi anni ’80, ci sono approdati anche gli stranieri: filippini, cinesi, egiziani, peruviani, senegalesi, romeni, marocchini e indiani, soprattutto. Loro, gli ultimi, sono i miei vicini di casa. Come me, vivono nelle abitazioni, spesso fatiscenti, di tutti quegli italiani che appena hanno potuto se ne sono andati, magari dentro le villette a schiera che punteggiano la campagna lombarda: file di cubetti gialli con i tetti marroni, circondati da giardini con qualche albero e qualche fiore e se possibile anche qualche nanetto, scarne riproduzioni di una natura possibile. I nanetti ci stanno per creare l’atmosfera da favola nel bosco, suppongo.
A Milano, infatti, la natura è un’ipotesi: la puoi rintracciare mentre stai in un fazzoletto d’erba e individui una scarna porzione di cielo. E in via Padova mi succede, quando mi siedo sulla mia panchina. Tra vecchi italiani e giovani immigrati: gli abitanti di questa riga di mondo, lunga più di quattro chilometri, che dal quasi centro ti porta all’estrema periferia, che da piazzale Loreto arriva allo svincolo della tangenziale, che dalle vetrine patinate monomarca ti immerge nei campi coltivati ad orto. Alternando con noncuranza case di ringhiera, capannoni industriali, vecchie cascine, palazzi anni ’50, buchi edilizi e ville nobiliari. Eh, già: ci sono pure le ville nobiliari. Roba esclusiva però, che davvero in pochi, in via Padova, si possono permettere.
Perché questa strada non è il paese delle meraviglie, e per entrarci non devi seguire il coniglio bianco: ti basta superare due banche, inserite ai piani terra di un palazzo a vetri e di un edificio residenziale, che stanno lì a ricordarti che Milano più che una capitale morale è una capitale economica. Anche se in via Padova puoi vivere, o sopravvivere, pure con pochi soldi. Infatti ci vivo anch’io. E rintraccio la mia ipotesi di natura mentre sto in un fazzoletto d’erba e individuo una scarna porzione di cielo, seduta sulla mia panchina. Ma non è detto che io riesca a sedermi, perché in questa zona l’ozio è possibile, anzi a volte è proprio obbligatorio, quindi la mia panchina è sempre piena. Come il mio bar.
Il mio bar assomiglia alla mia panchina che assomiglia al mio palazzo. In altri palazzi, però, si vive meglio. Questo è il peggiore, forse. “Non c’è limite al peggio”, avrebbe detto mia madre. E io faccio di tutto per deluderla, confermando i suoi motti.
Facendo del mio peggio, non faccio molto e dormo poco. “Le ore di sonno devono essere otto”, avrebbe detto mia madre. Ma vaglielo a spiegare che qui dentro è impossibile dormire il giusto. Qui il giusto ha altri parametri, altre esigenze e altri ritmi. Qui c’è sempre un andirivieni continuo, rumore non solo di voci ma anche di porte, di sciacquoni, di piatti e di passi. Di gente che abita anche in dieci in venti metri quadri: qui i letti a castello sono più gettonati dei futon e il futon si chiama semplicemente materasso per terra, e lo hanno in molti. Tutti quei molti che entrano ed escono continuamente dai loro appartamenti, e che spesso lavorano a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Io mi adeguo ai loro parametri, alle loro esigenze e ai loro ritmi. Anche se io non lavoro, vivo di eredità, con mio figlio: due in venti metri quadri, avessi il letto a soppalco staremmo anche più larghi, io sopra e lui sotto, mentre adesso io ho il futon sul tatami e lui ha il lettino su rotelle, siamo uno di fianco all’altro, accanto all’armadio, al bagno, al tavolo e alla cucina. Siamo sparpagliati sul pavimento, in mezzo agli oggetti. Non c’è privacy, nel mio appartamento.
È per questo che gli ho dato quel biglietto, perché ho bisogno di prendere le distanze. Ho bisogno del letto a soppalco che lui vuole vendermi: “Via Clitumno 11, citofonare Paola Rossi”, gli ho scritto. Solo che il citofono non funziona e io non mi chiamo Paola Rossi. In ogni caso è da irresponsabili lasciare il proprio indirizzo a uno sconosciuto qualsiasi: lasciarlo a un ragazzo egiziano incontrato per caso al Leoncavallo è da immaturi. Sicuramente. “Si è giovani una volta sola, ma si può essere immaturi per sempre”, ha detto Philip Roth.
A diciotto anni ero matura, secondo la legge, ma anche orfana di entrambi i genitori e proprietaria di un appartamento in piazza Ferravilla: quando mi hanno detto che mamma e papà erano morti in un incidente stradale ho lasciato l’infanzia, insieme alla casa della mia infanzia. Non ci abito più, perché non saprei più come viverci. Ma ci vivo, mettendola in affitto e abitando qui dentro. È un lavoro anche questo, magari non è normale, ma è legale.
E mica tutti un lavoro normale, o per lo meno legale, lo trovano. La povertà è la madre dei reati, d’altronde. È sempre stato così, in questo quartiere anche. In questa strada soprattutto.
Già negli anni ’50 via Clitumno, insieme a via Arquà che le sta attaccata, parallela e simile, veniva considerata “la via dei ladri, degli assassini e delle puttane”: una fama che si tiene ancora stretta addosso.
Beh, io non rubo, non uccido e non mi vendo, ma altri sì. Fatti loro, comunque. Anche se qui i fatti degli altri ti si appiccicano addosso, attraverso la vista, il tatto, l’olfatto, il gusto e l’udito. I cinque sensi sono sempre sovraesposti, ai fatti degli altri. Ma io gli altri non li giudico. “Chi è senza peccato scagli la prima pietra” è una delle frasi del Vangelo che preferisco, intuizione popolare più che regola religiosa. Io sono atea. Ma vedo, tocco, annuso, assaggio e ascolto. Impossibile non farlo, in questo palazzo, dove tutto si mescola.
Storie intrecciate di ottanta appartamenti di cui trenta sotto sequestro, accalcati uno all’altro e stipati oltre la loro capienza, allineati su più piani a delimitare un rettangolo di cemento, che non è un giardino: non ci sono alberi ma immondizia e non ci sono fiori ma biciclette. Dei nanetti non se ne parla neanche. Però vedo un bambolotto, dentro una voragine, provocata da un incendio e utilizzata come una discarica: tra una catasta di materassi, sedie e televisori rotti spunta la faccia rotonda di un Cicciobello nero, ha ancora il ciuccio in bocca e il vestitino addosso. Potrei prenderlo, lavarlo e regalarlo a mio figlio. Potrei ma non riesco a farlo, mi vergogno.
Mi sento piccola e incapace, mentre sto immobile al centro di questo imbuto che chiamano cortile: alzo la testa torcendomi il collo per vedere il cielo, sono circondata da muri scrostati e ballatoi cadenti, parzialmente nascosti dalle stoffe colorate dei panni stesi all’aria aperta.
Guardo le porte delle case: porte sigillate, porte cementate e porte divelte. Quasi tutte le altre, di porte, sono aperte o accostate, anche la mia lo è. Non perché lo voglia, ma perché la serratura è rotta. Spero che nessuno entri: odio che qualcuno mi venga a trovare all’improvviso. È già tutto troppo promiscuo, tra gli sconosciuti in questo palazzo, perché io possa accettare anche la promiscuità, tra i conoscenti, dentro il mio appartamento. “La discrezione sta bene anche a casa del diavolo”, avrebbe detto mia madre.
Sconosciuti e conoscenti: che poi non c’è mai nessuno che conosci veramente.
Chi sono io? “Dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei”, avrebbe detto mia madre. Io sono una che si fa chiamare Paola Rossi, che poi è il corrispettivo femminile di Paolo Rossi: solo che io non faccio l’attrice e non faccio ridere, non sono neppure bassa e stralunata, per altro.
Ma un giorno l’ho incontrato Paolo Rossi, il cabarettista non il calciatore e nemmeno un omonimo. Però non mi sembrava un cabarettista, ma solo un padre. Era l’ora dell’aperitivo, o meglio dell’happy hour: l’ora felice in cui bevi un drink e mangi degli stuzzichini, per otto euro circa. E a Milano puoi essere felice per questo. Paolo Rossi, nell’happy hour, forse non era felice, ma stava comunque al bancone di un bar, e beveva e mangiava per otto euro circa, con suo figlio piccolo in braccio. Tutto splendeva, in quel locale, l’acciaio dei tavoli e il cristallo dei bicchieri e le luci delle lampade. Loro due non splendevano, erano, quindi riuscivo a guardarli con calma, senza dover chiudere gli occhi per non restare accecata dalla loro presenza. Che mi si è impressa, addosso.
Da quel momento mi sono fatta chiamare Paola Rossi. Proiettarsi nell’altro e rubarne l’immagine, prendendo a prestito il suo nome. Deve essere quello che ho fatto.
Non ho mai fatto molto altro, del resto. Ho fatto più o meno sempre e solo questo: prendere a prestito. Non solo il nome di un altro.
Diventando orfana sono morta, vivendo di quello che mi hanno lasciato: la casa dei miei genitori e la voce di mia madre. Sono una parassita, degli oggetti e dei pensieri degli altri. Mi approprio dei loro beni, materiali o immateriali che siano. E li uso per stare al mondo, nell’unico posto in cui mi sento accolta: via Padova, quindi.
Anita Patel abita ancora in piazza Ferravilla, Paola Rossi vive da oltre vent’anni in via Clitumno 11.
Esco dal mio palazzo di tutti e vado nel mio bar di tutti. Mio è nostro: non è privato ma è sempre pubblico, in questo quartiere. Quando dici mio comunichi nostro e partecipi a un mondo. Non sempre ti piace, quello a cui partecipi, anche se ti ostini a fare lo spettatore esterno. Ma il contesto ti contamina, sempre. Se non il corpo, almeno la mente. Ed è quello che mi succede ogni volta che passo davanti all’Ambra Hard Movie, una reliquia del passato: con l’avvento di internet, delle pay tv e dei dvd non esistono quasi più i cinema porno. E invece io, tra il mio palazzo e la mia panchina e il mio bar, ce ne ho proprio uno, che non è mio: è aperto tutto l’anno, è specializzato in film gay e ha pure l’aria condizionata. Non gli manca proprio niente. Neanche la clientela, fatta di vecchi italiani e giovani immigrati. Quelli che stanno insieme anche nel mio palazzo, sulla mia panchina e nel mio bar, faticando a trovare un canale di comunicazione possibile. Ma dentro questo cinema invece, tra una poltroncina macchiata e un cesso sporco, un canale di comunicazione possibile lo trovano: solo che si chiama prostituzione. Non sono una bacchettona, è la disperazione insita in questo mercificio di corpi vecchibianchi e giovanineri ad intristirmi. Meglio l’apartheid dei rapporti, piuttosto.
Io non sono né vecchiabianca né giovanenera, sono una via di mezzo. Quarant’anni, meticcia. Un prodotto contraffatto.
Ma non sono un uomo, e non vado all’Ambra Hard Movie. Mi limito a passargli davanti tutti i giorni per andare dal mio palazzo, alla mia panchina, al mio bar: il Lord Bar. A dispetto del nome, dell’aristocrazia inglese qui non c’è nulla: e infatti tutti lo chiamano, affettuosamente, Lurid Bar. Non che sia sporco, anche se pulito non sembra. “Invano si lava il corpo, se non si lava l’anima”, avrebbe detto mia madre.
I baristi cinesi mi sorridono, mentre servono Negroni sbagliati e caffè corretti e io penso che è tutto sbagliato e niente è corretto qui dentro. Il Negroni sbagliato è del trans brasiliano e il caffè corretto è del pusher marocchino. Celebrano così la fine della loro notte di lavoro. Sono i miei vicini di casa e di panchina: ci salutiamo e ci parliamo. Mentre facciamo colazione.
Sono le sette del mattino, non è l’happy hour: bevo un cappuccio e mangio una brioche, spendendo meno di otto euro, stando al bancone del bar con mio figlio piccolo in braccio. Paola Rossi come Paolo Rossi. Solo che intorno a me non splende niente, neppure il sole. Tra poco più di un’ora qui dentro entreranno altre mamme, a fare colazione, dopo aver portato i figli alla scuola del Trotter.
Mio figlio è troppo piccolo per andarci, io ci andavo da piccola. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, prendevo un pulmino che da sotto casa mi depositava davanti al Trotter: come in un telefilm americano. La mia scuola era un enorme parco con tante casette colorate, e dentro una di quelle casette colorate c’era la mia classe: i tavoli, le sedie e la lavagna. E Francesco, il mio compagno di banco: che era anche un compagno di vacanze e pure un compagno di manifestazioni femministe. Non perché era un compagno, a sei anni, ma perché a quei cortei ci portavano le nostre mamme. Anche se le altre, di mamme, i loro bambini li portavano ai giardinetti a scendere dagli scivoli e a dondolare sull’altalena. E il compagno Francesco me l’ha poi detto, da grande, che un’infanzia passata a sentire tante donne urlare tutte insieme “L’utero è mio e lo gestisco io”, gli doveva aver creato qualche problema con l’altro sesso, da grande. Ma adesso che è grande davvero, almeno anagraficamente, perché alcuni di noi quarantenni di oggi sembra spesso che siamo rimasti impigliati intorno ai nostri quattordici anni, dunque adesso che è grande davvero ha una moglie, un figlio e un lavoro. È un uomo risolto, si direbbe. Forse è anche felice. Forse anch’io sono felice, anche se non è l’happy hour, mentre bevo un cappuccio e mangio una brioche, spendendo meno di otto euro, stando al bancone del bar con mio figlio piccolo in braccio. Parlando con il trans brasiliano e il pusher marocchino.
I trans brasiliani e i pusher marocchini c’erano anche al Trotter, un tempo: che non era il tempo della mia infanzia e non è neanche il tempo del presente. Oggi il Trotter è stato ripulito, dal disagio che comunque lo circonda, che si assiepa intorno alle sue mura di protezione e che a volte penetra nelle sue linee di confine: infiltrandosi anche dentro l’ex convitto, una stecca pericolante di cinquemila metri quadri, che divide la scuola da via Padova e che viene usata come dormitorio dai senza tetto. Dentro questa struttura, alla fine degli anni ’80, non c’erano barboni distesi tra topi, spazzatura e macerie: c’era il museo dei bambini, ideato dai bambini e realizzato da Bruno Munari. Non c’è più: a ricordo di quell’esperienza sono rimasti solo dei disegni colorati sui muri. Fanno tenerezza, quei disegni. Fa tenerezza anche la fattoria, perché ci prova ma non ci riesce, ad esserlo. Perché di solito una fattoria, almeno nelle favole, contiene animali diversi: tipo la mucca, l’asino, il cavallo e le galline, volendo. La fattoria del Trotter invece, volendo o non volendo, conteneva solo le galline: eravamo a Milano, d’altronde. E qu...