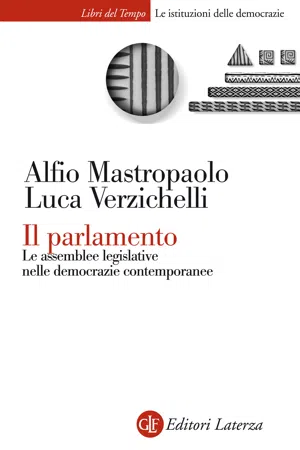
eBook - ePub
Il parlamento
Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee
- 206 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il parlamento
Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee
Informazioni su questo libro
La parabola del parlamentarismo moderno, dalla faticosa affermazione dell'istituzione ai suoi sviluppi più recenti; la fisionomia dei parlamenti contemporanei a partire da una ricognizione comparativa sul loro funzionamento in alcuni dei principali regimi democratici; il dibattito teorico sul declino dei parlamenti e le nuove sfide che li aspettano.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il parlamento di Alfio Mastropaolo,Luca Verzichelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Politica e relazioni internazionali e Politica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Politica e relazioni internazionaliCategoria
Politica1. Parlamenti e rappresentanza
1. Le premesse del parlamentarismo moderno
Stando al più prestigioso dizionario della lingua italiana, il parlamento è «negli Stati moderni con struttura politica (effettiva o anche solo apparente) di democrazia rappresentativa [...] [un] organo istituzionale fondamentale a base rappresentativa [...], che esercita in posizione di indipendenza rispetto agli altri poteri (esecutivo e giudiziario) dello Stato e spesso con una preminenza più o meno forte ed effettiva nei confronti del potere esecutivo, il potere legislativo e funzioni di controllo e indirizzo politico» (Battaglia, 1984, p. 615). Notoriamente, le definizioni proposte dai dizionari sono preziose per orientarsi. Una volta inteso però di cosa si parla, ulteriori e più impegnative domande nascono subito. Prima tra tutte, e certamente la più ovvia: dove hanno visto la luce – e in che modo – i parlamenti?
È da tempo immemorabile – da un millennio o giù di lì – che il termine «parlamento» circola per l’Europa. Se però quel termine era già in uso nell’XI secolo – nelle sue varianti latina (parlamentum) e nelle sue varianti in volgare (parlement, parliament, parlamento) – quel che con la medesima parola si denomina non è sempre la stessa cosa. Il parlamento, quale noi lo conosciamo, e quale lo si conosce da circa tre secoli, con il suo complicato corredo di procedure elettorali, di competenze decisionali, di pratiche deliberative e di rapporti con gli altri organi dello Stato, è un istituto tipicamente moderno e anzi, se stessimo alla più canonica scansione della storia – dove la storia contemporanea la si fa cominciare con la rivoluzione francese – è un istituto tipicamente contemporaneo, se non fosse per l’anticipo inglese.
Con la stessa parola si sono dunque denominate cose alquanto diverse, giacché i parlamenti che ci sono familiari sono tutt’altra cosa dai parlamenti feudali o da quelli propri dello Stato per ceti1. Inoltre, quantunque una ricognizione comparativa recente, piuttosto ardita e intrigante, abbia provato a dimostrare come le pratiche assembleari siano da sempre diffuse in contesti storici e culturali assai distanti tra loro nel tempo e nello spazio2, il parlamento rimane un’invenzione, e una tecnologia istituzionale, tipicamente occidentale, che è poi stata dappertutto imitata e adattata – invero non sempre con effetti virtuosi – com’è del resto accaduto a tantissime altre invenzioni occorse in Occidente.
Tra i parlamenti medievali e premoderni e i parlamenti moderni sussiste senza dubbio un rapporto di filiazione, suggerito peraltro dall’impiego del medesimo termine per designarli e che tuttavia non impedisce una diversità radicale tra gli uni e gli altri3. È doveroso pertanto partire dai primi per ricostruire la genealogia dei secondi, e per ragionare di continuità e di rotture, con l’avvertenza che quella dei parlamenti, tanto per cambiare, non solo non è una storia semplice, ma è una storia complicata e tutt’altro che lineare, e soprattutto soggetta a molteplici, e divergenti, interpretazioni. Adottando quest’ottica, quel che ci troviamo in primo luogo a considerare è un atto di volontà delle monarchie medievali, da cui nasce la pratica dei consigli del re, da quest’ultimo istituiti per soccorrerlo nella sua attività di governo, per informarlo circa l’andamento delle cose del regno e per assicurargli la deferenza dei sudditi mediante il loro coinvolgimento in qualche forma.
L’usanza è antica e la si fa risalire all’XI-XII secolo. Consiglio e aiuto tra il re e i suoi vassalli erano intrinseci al vincolo feudale. Già in pieno Medioevo era consuetudine che i monarchi si avvalessero di un consiglio – la cosiddetta curia regis – per svolgere la loro ordinaria attività di governo, cui partecipavano i loro collaboratori più prossimi, i loro dignitari, consiglieri e servitori. Progressivamente però le dimensioni del consiglio si allargheranno e includeranno nuovi attori. Se non altro in alcune particolari, e più solenni, circostanze i monarchi prendono così l’abitudine di adunare a corte, e attorno a sé, in assemblee più vaste i meliores et maiores terrae: l’aristocrazia feudale, l’alto clero, la bassa nobiltà, le magistrature più elevate, ma anche le elites cittadine (Howard Lord, 1980).
Lo Stato moderno, secondo la definizione weberiana, è quello che «esige per sé il monopolio della forza fisica legittima» (1967, p. 49). Storicamente il suo più che un monopolio fu in realtà un’ambizione, all’accentramento del potere e all’unificazione territoriale, coltivata dalle monarchie postmedievali, le quali dovettero perciò soddisfare un’esigenza fondamentale, che era quella di coinvolgere la popolazione, o, meglio, quella parte di essa che aveva una qualche rilevanza politica. Ciò non implicava ancora il riconoscimento, da parte del monarca, di una qualche soggettività politica concorrente con la sua, tanto meno di una qualche soggettività politica collettiva. Ma per intanto, una volta allargata, la curia regis, quantunque seguitasse a dipendere per la sua convocazione e la sua attività dalla volontà esclusiva del re e dai suoi calcoli di convenienza, diveniva curia generale, o solenne, colloquio, consiglio, e magari anche parlamentum e magnum parlamentum.
Non si trattava ancora di un organo collegiale, dotato di funzioni giudiziarie o legislative, ma era pur tuttavia un’adunanza allargata del Consiglio del re, cui concorrevano singoli e collettività, i quali col re seguitavano a intrattenere un rapporto che non era di mera sottomissione, ma era appunto tipicamente feudale, dunque personale e implicante fedeltà, collaborazione reciproca, consiglio e aiuto. Lungi dal deliberare, e dal rappresentare in senso moderno (che è concetto, il secondo, come si vedrà, alquanto ambiguo), codeste assemblee erano intese in primo luogo a conferire solennità particolare alle decisioni del sovrano. Dalla cui figura però, man mano che il feudalesimo decade, tale pratica di consultare, consolidatasi e rafforzatasi nel frattempo, verrà emancipandosi.
Basta poco del resto ad avviare un duplice processo, che si protrarrà per qualche secolo. Si tratta da una parte di un processo di aggregazione e integrazione. Convocati dal monarca, i baroni, i prelati, ma anche i cavalieri, e i notabili cittadini, erano progressivamente sospinti a costituirsi in entità collettive – i ceti, gli états, gli Stände, le cortes ecc. – che in quanto tali interagivano con il re per il tramite di rappresentanti da loro espressi (Hintze, 1980). Per parte sua la nobiltà feudale, insidiata nei suoi poteri, nel parlamento cercava uno strumento che le permettesse di resistere collettivamente alle pretese, oltre che del monarca, anche dei nuovi attori sociali emergenti, vale a dire le borghesie cittadine. A loro volta, balzate prepotentemente sulla scena, queste ultime non si contentavano affatto dei loro istituti di autogoverno urbano, bensì aspiravano, collettivamente anch’esse, a far valere i propri interessi, a intervenire negli affari del regno, a bilanciare e, se possibile, contrastare le pretese dei ceti superiori (Howard Lord, 1980, p. 107). Da ultimo, era interesse della monarchia valorizzare l’elemento cittadino in contrapposizione a quello nobiliare, onde sottrarsi alle sue pressioni e magari acquisire un ruolo arbitrale e super partes.
Al processo di aggregazione se ne accompagna tuttavia un secondo, non meno cruciale, che è invece d’erosione: il rapporto tra il re e coloro che egli convoca dinnanzi a sé è destinato progressivamente a divenire meno squilibrato. Se è il monarca che comincia a convocare adunanze solenni coi suoi vassalli e coi suoi sudditi in genere, onde porsi all’ascolto dei loro umori e registrarne l’intesa, mano a mano coloro che egli ha convocato in sua presenza non si accontentano della convocazione. Crescono politicamente e pretendono d’esser riconosciuti nella loro collegialità, e nella loro autonoma soggettività politica, estorcendo un potere che è dapprima condizionante e che poi diverrà decisionale.
All’origine del parlamentarismo moderno stava sopra ogni cosa una partita, accanitamente giocata tra il monarca e suoi interlocutori, la cui posta fondamentale era di natura fiscale e militare a un tempo. Il monarca richiedeva mezzi finanziari, di vario genere e per le più svariate finalità, ma nient’affatto immotivate, ovvero per sostenere le ambizioni d’allargamento del regno e le sue esigenze di difesa. Insieme, pretendeva uomini per i suoi eserciti. I suoi interlocutori inizieranno a negoziare con lui e ad avanzare le loro pretese, nutrendo un fondamentale obiettivo: quello di estorcergli almeno qualche quota del potere politico che egli andava accentrando.
Non che quest’ultimo fosse un obiettivo consapevole e predefinito. All’inizio si trattava unicamente di difendersi: non da pretese illegittime – il monarca assicurava dopo tutto un servizio – bensì da quelle più esose. Istituzionalizzandosi però quelle pratiche di consultazione, l’elemento feudale, quello ecclesiastico e quello cittadino sulle prime si contenteranno di avanzare petizioni e di emettere pareri, ma presto inizieranno a sollecitare l’attività legislativa, e anzi a compartecipare ad essa, seppur ufficialmente per registrare la volontà del sovrano. Ma non bisogna sottovalutare il secondo servizio che codeste forme di adunanza svolgevano: che era quello di far convergere in un’unica sede e in un unico tempo le molteplici componenti della comunità del regno, in tal modo rappresentandole, ovvero rendendole presenti tanto al sovrano, quanto a se stesse.
Non solo, ma l’uso di riunire adunanze analoghe a quelle tenute al centro prendeva piede pure in periferia, disseminandole sul territorio. È una vicenda ardua da riassumere e schematizzare, che si è dispiegata nei vari territori d’Europa con ritmi e in forme molto diversi: dal Portogallo alla Polonia, fino addirittura alla Russia, dalla Sicilia alla Svezia. E non sempre la stessa era la composizione di codeste assemblee. Nient’affatto scontato, per esempio, era il coinvolgimento dei ceti urbani: i signori feudali e i prelati tenevano non poco alla loro preminenza. Comunque sia, almeno sino a metà del secolo XIV è ancora presto per considerare tali assemblee organi rappresentativi in senso proprio.
Certo, in Inghilterra il processo si è snodato con qualche anticipo. Già alla fine del XIII secolo era entrata in circolo la formula romanistica quod omnes tangit, ab omnes approbari debetur e gli atti dei rappresentanti cominciavano a impegnare i rappresentati. Chi teneva in particolar modo a che ciò avvenisse – ovvero che i rappresentanti disponessero di plena potestas, ovvero potessero assumere impegni che vincolassero i loro mandanti – erano gli stessi monarchi, cui non conveniva logorarsi in contrattazioni estenuanti con rappresentanti che rischiavano di essere sconfessati dai loro rappresentatati. A far da discrimine sarà la collegialità dell’azione, per la quale il corpo pubblicamente si qualifica come sintesi delle sue componenti. Allorquando la si sarà conseguita, come ha suggerito chi ha approfondito la storia delle istituzioni rappresentative adottando una prospettiva continuista (non da tutti però condivisa), si sarà alfine compiuto un primo e decisivo salto di qualità: il passaggio dai «preparlamenti» ai «parlamenti», dalle assemblee prerappresentative a quelle rappresentative (Marongiu, 1980).
Sancita giuridicamente, la collegialità diverrà il tratto più tipico delle assemblee degli stati, dei ceti, degli ordini, dei corpi, le quali a loro volta, corrispondono a un deciso mutamento d’orizzonte: dall’organizzazione medievale del potere alla costituzione – è il termine adoperato da Otto Hintze – «per ceti» (dello Stato, o della società, appunto, per ceti).
Logoratesi le antiche trame di vincoli feudali, con il sorgere di nuove attività produttive e commerciali nelle città, nel cosiddetto basso Medioevo le trasformazioni che avvengono nella società investono la sfera politica e anche il modo di pensarla. Forme nuove d’azione solidale maturano proprio a partire dai centri urbani, anzitutto per ragioni di autodifesa, innescando un movimento che è destinato ad aggregare in sede politica quanti condividono la medesima condizione sociale e i medesimi interessi. Si costituiscono cioè dei nuovi potentes collettivi, dei corpi sociali organizzati, i quali non solamente rivendicano con successo il diritto ad autogovernarsi mediante proprie assemblee, ma che collegialmente si contrappongono anche al potere regale, limitandolo, come mai avevano potuto gli attori con cui quest’ultimo interagiva in precedenza. Mentre una nuova idea e una nuova simbologia del potere prendono forma, nuove istanze non più consultive, bensì rappresentative e deliberative, stanno vedendo la luce e in maniera meno incerta è possibile classificarle come parlamenti, sia pure premoderni.
Ciò che maggiormente qualifica la costituzione per ceti è il suo cosiddetto «dualismo» (Hintze, 1980, p. 86), da intendere non solo come opposizione, ma anche come collaborazione. Punto di passaggio decisivo verso lo Stato moderno, in tale costituzione manca l’unità del potere, ossia il già rammentato monopolio dei mezzi di coercizione. Sancite giuridicamente le disuguaglianze, che sono sociali e politiche insieme, sotto forma non di diritti, bensì di privilegi, il potere politico si articola in due sfere magari sovraordinate, ma distinte: quella del principe e quella dei ceti, la quale si esprime per il tramite delle sue istanze rappresentative. Ebbene, queste ultime non si limitano a contenere il potere reale, ma sono apertamente coinvolte nell’azione di governo. Esercitano il potere a livello centrale, in unione col monarca, e lo esercitano a livello periferico, disperse come sono sul territorio.
L’equilibrio non è mai lo stesso. Talora, in Francia, in Spagna e in alcuni territori dell’Impero, fu il monarca ad avere la meglio. Talaltra, ma in forme assai diverse, e al termine ancora una volta di un complicato percorso, prevalsero le assemblee cetuali: in Inghilterra (dove nacque il primo parlamento moderno), in Europa orientale, in Scandinavia. Hintze (1980, pp. 86 ss.) distingue tra parlamenti tricamerali e bicamerali e in pari tempo delinea due modelli evolutivi: l’uno orientato verso l’assolutismo, l’altro che muove invece direttamente verso il parlamentarismo.
Le tipologie e i modelli evolutivi si sovrappongono solo parzialmente. Al modello bicamerale corrisponde il caso inglese. Già nel XIII secolo da un lato vi sono i magnati, laici ed ecclesiastici, i pari del regno, in quella che si appresta a divenire la Camera dei Lords, che è grosso modo un’estensione del Consiglio del re, e, dal lato opposto, vi è quella che diverrà la Camera dei Comuni, in cui siedono i rappresentanti delle contee e dei borghi, della media e bassa nobiltà, i cavalieri, o la gentry, e la borghesia cittadina e dunque la popolazione nel suo complesso. Tricamerale è viceversa la formula che vige in Francia, dove però alla lunga l’assolutismo monarchico ridurrà i parlamenti a organi giudiziari: influenti ...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. Parlamenti e rappresentanza
- 2. Varianti del parlamento democratico.La dimensione rappresentativa
- 3. Come si strutturano i parlamenti democratici
- 4. L’azione del parlamento nei sistemi di governo democratici
- 5. I parlamenti tra crisi e rinnovamento
- Riferimenti bibliografici