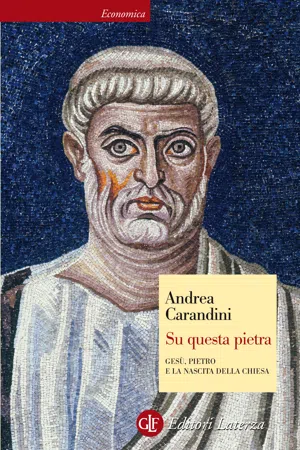1. Le idee teologiche di Gesù
Babilonia cedette al dominio dei Persiani nel 539 a.C. L’editto di Ciro dell’anno dopo lasciò liberi gli ebrei, trascinati in esilio da Nabucodonosor, di rientrare in patria. Cominciò così il ritorno, in varie ondate, in Giudea. Verso il 520, gli ebrei rientrati, guidati da Serubabel – nipote dell’ultimo re – cominciarono i lavori di costruzione del nuovo tempio a Gerusalemme, consacrato nel 516 (fig. 1).
Intanto tra sacerdoti e scribi tornati in patria si erano sviluppate idee e pratiche religiose innovative, poi consolidate in una tradizione orale, la «tradizione degli antichi», fatta di precetti degli uomini, grande parte della quale fu adottata dai Farisei. Essi volevano imporre quei precetti anche a coloro che erano rimasti in Palestina, che seguivano idee e pratiche derivate esclusivamente dalle Scritture e che non volevano saperne di superfetazioni connesse all’esilio babilonese.
Gesù si era proposto di liberare l’essenza morale della legge dalla precettistica minuziosa della tradizione degli uomini, che sembrava completare quell’essenza e che in realtà la contraddiceva: «Avete annullato la parola di Dio per la vostra tradizione»1. A Mosé e ai profeti Gesù rimaneva, invece, fedele: «Non crediate ch’io sia venuto ad abolire la legge e i profeti; sono venuto non ad abolire ma a compiere»2. Egli era giunto per purificare e perfezionare la legge antica: «un abisso... separava la sua dottrina da quella del legalismo farisaico, che in lui vedeva il prototipo dei riformatori contro la degenerazione ecclesiastica»3.
Al tempo di Gesù, c’erano giudei che credevano in un solo Dio. Altri credevano che accanto a Dio esistesse un delegato, forse un suo figlio, la cui funzione era mediare tra Dio e il mondo, redimendolo. Altri ancora credevano che la redenzione sarebbe venuta da un uomo speciale, un rampollo della casa di Davide – re di Giudea e di Israele del X secolo a.C. –, che avrebbe riportato la Palestina alla gloria che aveva preceduto i domini stranieri babilonese, greco (seleucide) e romano. Altri, infine, credevano che la seconda e la terza figura costituissero un essere unico, divino e umano al tempo stesso.
Dopo Gesù, esistevano giudei che ritenevano di poter essere tali e al tempo stesso cristiani, facendo in tal modo del cristianesimo una variante del giudaismo. Ma tra gli inizi del II secolo d.C. – quando i perseguitati a Roma furono chiamati cristiani e non più giudei – e il IV secolo d.C., soprattutto a partire dal concilio di Nicea (325 d.C.), il cristianesimo si andò sempre più separando dal giudaismo. San Girolamo (347-420 d.C.) scriveva a sant’Agostino: «Ancora oggi in tutte le sinagoghe dell’Oriente perdura fra i giudei l’eresia condannata ancora dai Farisei e detta... dei Nazareni: essi credono in Cristo..., come crediamo anche noi»4.
Per l’evangelista cui è stato attribuito il nome Marco, Gesù riteneva di essere lui il messia. Il termine ebraico «messia» (unto) – christos in greco – rimandava a un re di Giudea e Israele, che nel momento dell’insediamento sul trono veniva unto sul capo, come Saul, Davide e Salomone. Era un essere sacralizzato, adottato da Dio, e in tal senso era considerato come un «figlio di Dio» – il Cristo di Dio5 –, anche se propriamente un Dio non era. Dopo l’esilio in Babilonia, seguito al secondo assedio e alla conquista babilonese di Gerusalemme nel 587 a.C., si manifestò l’attesa nel ritorno di un novello Davide – un figlio (della casa) di Davide, come sarà Gesù e già suo padre Giuseppe, almeno secondo una versione – capace di restaurare la gloria della sua casa e del regno che Nabucodonosor aveva distrutto. Doveva essere un re di questo mondo oppure, nella forma più attenuata, un capo-pastore del popolo d’Israele6, una figura alla fine negata anch’essa da Gesù: «La mia regalità non è di questo mondo»7.
Sempre secondo il vangelo di Marco, Gesù era anche «figlio dell’uomo», definizione criptica, che ne indica, al contrario, la natura divina. Infatti, nel Libro di Daniele (165 ca. a.C.) il profeta ha la visione di due figure divine: un vegliardo e un’altra figura (giovane?): «Ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile a un figlio di uomo; giunse sino al vegliardo (seduto in trono) e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è eterno...»8. Queste due figure divine rimandavano ad analoghe entità celesti della religione primordiale d’Israele, cioè agli antichi dèi ’El, il giudice, e Ba‘al, il guerriero. Più tardi si trasformeranno nel Dio padre e nel divino suo figlio. YHWH ha rappresentato, pertanto, la fusione – avvenuta nel VI secolo a.C. – delle due divinità originarie: una fusione non perfettamente e definitivamente riuscita, tanto che il Dio giovane ha conservato la capacità di scindersi dal Dio vecchio, come appunto in Daniele. La teologia dei vangeli sembra, dunque, più che una invenzione recente, un ritorno all’antichissima tradizione teologica duale, mai completamente superata in Palestina. Se Daniele fu la profezia, i vangeli ne sono stati il compimento9.
Secondo i vangeli, il «figlio dell’uomo» sarebbe giunto nella gloria del Padre suo, insieme agli angeli e ai santi, apparendo fra le nubi del cielo, seduto alla destra della potenza di Dio – il cui regno sarebbe stato preparato fin dalla fondazione del mondo – e allora i dodici apostoli, seduti su altrettanti troni, avrebbero giudicato le dodici tribù di Israele. Quando esattamente il «figlio dell’uomo» sarebbe sceso tra gli uomini solo Dio lo sapeva, ma il momento era considerato vicino: entro una generazione, si credeva.
Le Similitudini di Henoch gettano notevole luce sul contesto culturale dei vangeli. Nel Quarto libro di Ezra, coevo del vangelo di Marco, troviamo un «figlio dell’uomo», basato su Daniele (7), ancora più simile a quello dei vangeli, perché è una combinazione del divino «figlio dell’uomo» e dell’umano messia redentore «figlio di Dio». Con Gesù le idee del messia e del Dio giovane si erano fuse definitivamente in un essere unico ed era nata così l’idea del messia redentore divino: un uomo divinizzato, oppure un dio antropizzato. L’aver Gesù riconosciuto d’essere il messia divino fu ritenuto blasfemo dal sommo sacerdote, che giudicandolo gli chiese «Sei tu il Cristo [= messia], il figlio di Dio?». – Gesù rispose «Io lo sono»10. «Io sono» è quanto Dio aveva detto di sé nell’Esodo11.
Alcuni ebrei aspettavano un messia di natura umana e divina. Questa attesa rientrava nella tradizione ebraica ed era stata ravvivata dalla diretta dominazione romana: infatti nel 6 d.C. la Giudea era diventata una provincia dell’Impero. Gesù si riconobbe sia come l’umano messia (christos), cioè come novello re Davide, sia come il divino «figlio dell’uomo», al quale Dio aveva delegato l’autorità «sulla terra» o «sotto il cielo», come si legge in Daniele12. Nel considerarsi messia (quindi un uomo adottato da Dio) e al tempo stesso «figlio dell’uomo» (quindi essere divino fin da principio) Gesù aveva posto sé stesso al di sopra della Legg...