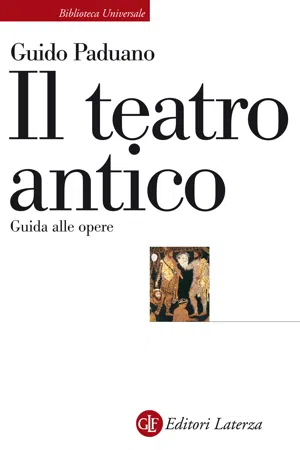
- 366 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Un'introduzione alla drammaturgia classica, attraverso l'analisi del suo nucleo fondante, la concezione del personaggio in rapporto agli altri, alla collettività, agli dei, al destino: dai Persiani di Eschilo all'Ottavia pseudo-senecana, le ottantacinque opere superstiti del teatro classico greco e latino sono presentate nella ricostruzione puntuale della trama, delle idee guida e degli spunti problematici che ciascun dramma presenta rispetto all'opera complessiva dell'autore.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il teatro antico di Guido Paduano in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Media & Performing Arts e Theatre History & Criticism. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Media & Performing ArtsCategoria
Theatre History & CriticismEuripide
ALCESTI
Apollo rievoca i suoi rapporti amichevoli con Admeto, principe di Tessaglia presso il quale fu costretto a servire per un anno come punizione inflittagli da Zeus per aver ucciso i Ciclopi, fabbricatori della folgore che aveva ucciso suo figlio Asclepio; in premio delle virtù di Admeto, gli ha concesso di non morire al momento per lui destinato, purché un’altra persona accetti di morire al suo posto.
Il sacrificio è stato promesso dalla moglie di Admeto, Alcesti. Ora che il momento è giunto, Apollo cerca di ottenere anche per lei una dilazione da Thanatos, il dio della morte, che si presenta subito dopo e intreccia un dialogo asperrimo col dio della luce, accusato di creare ingiusti privilegi. Al rifiuto di Thanatos, Apollo predice lo svolgimento felice della vicenda, che sarà opera di Eracle.
Entra il Coro dei vecchi tessali, chiedendosi il perché del silenzio che avvolge la reggia. Non ha notizie sulla sorte di Alcesti e teme che il peggio sia già avvenuto, pur notando la mancanza dei segni rituali del lutto. Domina un cupo senso di necessità inevitabile.
Le notizie sono portate da un’ancella di Alcesti, che riferisce la vigilia di morte, preparata dalla regina con ogni cura della dignità e della bellezza; racconta come abbia pregato Estia, la dea del focolare, per il futuro dei suoi figli, e come il suo controllo si sia spezzato nello straziante saluto al letto nuziale. Accanto a lei, ha visto la disperazione impotente di Admeto.
Il Coro non rinuncia a innalzare ad Apollo una disperata preghiera, ed esprime coscienza della sventura che colpisce Alcesti e Admeto, tale da ispirare una concezione pessimistica del matrimonio.
Entra, insieme ad Admeto, Alcesti, posseduta dal delirio che le pone davanti agli occhi visioni di morte. Poi recupera coscienza razionale e parla ad Admeto chiedendogli, per il bene dei figli, di non risposarsi. Admeto acconsente promettendo che tutta la casa porterà per sempre il lutto, e che una statua di Alcesti prenderà il posto di lei sul letto. Se non può scendere nell’Ade a cercarla come Orfeo, potrà però riunirsi con lei, quando sarà giunto il suo momento, nella stessa tomba. Affidando i figli al marito, Alcesti muore; il piccolo Eumelo canta sul suo cadavere una commovente monodia, e Admeto proclama il lutto per tutto il paese.
Il Coro canta le lodi di Alcesti, anche in rapporto all’egoismo dei genitori di Admeto, che hanno rifiutato di sacrificarsi, e prospetta, metalinguisticamente, un futuro di gloria poetica.
Arriva Eracle, in viaggio verso la Tracia per una delle sue fatiche: la cattura delle cavalle antropofaghe di Diomede. Con lui, Admeto lascia ambiguamente in sospeso la sorte di Alcesti, e ammette la presenza in casa sua del cadavere di una donna «non consanguinea», ma gli impedisce di andare altrove, riaffermando i valori dell’amicizia anche di fronte allo sconcerto del Coro: esso è poi pronto a convincersi e a cantare le lodi dell’ospitalità, nel ricordo del soggiorno di Apollo.
Al momento di celebrare il funerale, Admeto è interrotto dall’arrivo del padre Ferete, che porta doni per la morta; Admeto li rifiuta, e disconosce per il futuro ogni dovere verso di lui. Ferete risponde durissimamente, rivendicando la responsabilità individuale che concerne il destino di ogni uomo, e accusando a sua volta Admeto di avere assassinato la moglie. Dopo il diverbio la scena resta vuota, perché il Coro accompagna il re alle esequie.
Compare un servo che non ha potuto partecipare alle esequie stesse perché costretto ad accudire Eracle, e di questo, e della tradizionale ingordigia del semidio, si lagna. Eracle cerca di stornarlo dalla sua tristezza per portarlo a condividere il piacere, ma quando da lui finalmente apprende la morte di Alcesti, decide di affrontare Thanatos e di strappargli la donna.
Uscito Eracle, rientrano in scena Admeto e il Coro, e in una lamentazione lirica Admeto rimprovera agli amici di avergli impedito di gettarsi nella fossa della moglie e rievoca con strazio la cerimonia nuziale. Poi, in trimetri, spiega al Coro che la sua sorte è peggiore di quella di Alcesti, condannato com’è all’infelicità in una casa squallida, e fuori casa al discredito generato dal privilegio.
Il Coro canta uno sgomento inno alla Necessità: nessuna delle avventure culturali dell’uomo è mai giunta a sconfiggerla, ma Admeto deve trarre conforto dall’eroizzazione della sua sposa, cui verranno destinati onori cultuali.
Ritorna Eracle, portando con sé una donna velata che sostiene di avere vinto a una gara atletica, e chiede ad Admeto (che rimprovera dolcemente per avergli nascosto la verità) di tenerla in casa fino al suo ritorno. Admeto vorrebbe rifiutare la donna, ma cede ancora, stavolta con riluttanza, agli obblighi dell’amicizia. Oltre il velo, ritrova la sua Alcesti, che sarà muta per tre giorni, finché non le sarà tolto il sigillo della morte. Eracle si congeda e Admeto proclama la sua esultanza.
L’opinione più diffusa è che Euripide non abbia rappresentato nell’Alcesti quella grandiosa taumaturgia dell’amore, sola forza capace di superare il principio di conservazione, che vi leggeva Platone nel Simposio 179b-c. Sembra che Alcesti parli così poco d’amore che il movente del suo sacrificio è stato cercato altrove: in un obbligo discendente dall’inferiorità sociale della donna (ma Alcesti ai vv. 284-6 dice esplicitamente che avrebbe potuto vivere e risposarsi conservando intatto il suo rango); o viceversa nel desiderio dell’impresa gloriosa, che però è una forma generale del pensiero greco, non un contenuto o una finalità specifica; o infine nell’affetto materno, che è spesso e teneramente affermato da Alcesti, ma è precisamente il valore sacrificato dalla sua scelta, con la quale suo malgrado abbandona i figli (vv. 388-9). In un quadro dove si rimprovera ai genitori di Admeto di essere philoi a parole e non a fatti (logo, non ergo, secondo un’opposizione storicamente capitale), certamente Alcesti ama, al contrario, ergo, non logo: ma che il silenzio sia in lei un’altissima comunicazione poetica e teatrale lo si capisce dal suo tralucere fra le pieghe della tradizionale sessuofobia del V secolo, che all’amore concede il protagonismo solo quando è possibile marcarlo di condanna e deplorazione, mentre la valutazione positiva lo mimetizza sotto termini come «onore» (timan) o «rispetto» (presbeuein), o nella più ampia e generica solidarietà affettiva (philia).
Quando Alcesti saluta il letto nuziale, le sue parole parlano della rassegnazione a sparire, cedendo il posto a un’altra donna e limitandosi a rivendicare la tradizionale sophrosyne femminile: «un’altra donna ti possederà, non più virtuosa di me, ma forse più fortunata» (vv. 181-2). Ma le parole rinunciatarie sono smentite dall’atteggiamento gestuale, dal pianto cioè che il racconto dell’ancella mette in rilievo. Così ci stupiremo meno che le stesse parole vengano smentite poi dalla richiesta alta ed esplicita che una seconda moglie di Admeto non ci sia mai. Le esigenze di censura che abbiamo visto all’opera nella discrepanza tra gesto e parola ascrivono questa richiesta a una dimensione familiare e moralizzante (i loro figli non dovranno conoscere la figura topicamente ostile della matrigna!); ma che invece il suo vero fine sia quello di completare la sfida lanciata dall’amore alla morte, attraverso la persistenza nella vita di Admeto di un legame personale con la donna morta per lui, traspare con ogni chiarezza dalla risposta di Admeto, al quale, come maschio, è imposto un interdetto più lieve: l’accettazione piena ed entusiastica della fedeltà da parte sua non passa affatto attraverso la considerazione dei figli, ma attraverso i valori di bellezza e nobiltà riconosciuti ad Alcesti, come se in quel momento Admeto la scegliesse una seconda volta come sposa. La naturalezza delle sue affermazioni ha sortito nella critica l’effetto perverso di occultare il loro carattere culturalmente rivoluzionario (quanto la situazione che le genera, certo): anche la fedeltà più celebre, quella di Penelope – fedeltà femminile cui non corrisponde affatto, nell’Odissea, analoga fedeltà sessuale del marito –, è limitata dalla fiducia che Odisseo, contro ogni apparenza, sia vivo; diversamente, lo stesso Odisseo ha incoraggiato la moglie a un secondo matrimonio (Odissea XVIII, 70). Ed Eracle tratta da pazzo Admeto che ha accettato questo vincolo come Ferete tratta da pazza Alcesti che ha accettato di morire.
Ma nella rhesis di Admeto che precede la morte di Alcesti la fedeltà appare essere solo la condizione negativa di una mitopoiesi capace di assicurare un dialogo amoroso oltre la morte, che accetta livelli imperfetti, come la «fredda gioia» della statua (v. 353), o il colloquio fuggevole in sogno, solo nell’attesa di una nuova casa coniugale nell’aldilà: un concetto che nelle Coefore, dove Oreste condannava la madre adultera a condividere in eterno la tomba col suo spregevole amante (vv. 894-5), era solo un sarcasmo paradossale, vent’anni dopo si è evoluto a norma positiva di una nuova relazione fra i due sessi.
Dopo che la scena delle esequie ha mostrato il risvolto più doloroso e nullificante del rapporto tra amore e morte, la vita invivibile (abiotos chronos) che il beneficiario del sacrificio resta a condurre, l’epilogo riporta in primo piano la promessa di fedeltà: è proclamandola solennemente, difendendola a lungo contro le imbarazzanti pressioni di Eracle che hanno l’effetto di metterlo alla prova, soffrendo il fascino ambiguo della somiglianza tra Alcesti e la donna velata, che Admeto «merita» il ritorno prodigioso della felicità. Anche in questo caso il confronto con la cultura precedente mostra tutta la forza innovativa della strategia euripidea. Nell’Alcesti di Frinico, come mostra il fr. 2 Snell, il Coro era a conoscenza dell’impresa di Eracle, e dunque la peira della fedeltà non poteva aver luogo. Per consentirla, Euripide è ricorso al raro espediente di far uscire il Coro durante l’azione.
Peraltro, alla mitopoiesi amorosa, che ha un ruolo incalcolabile nella cultura occidentale, non corrisponde un’idealizzazione senza nubi: al contrario, Euripide ha fatto interagire con essa una scabra problematica morale, che tocca il suo culmine quando Ferete invita ironicamente Admeto, contro la sua solenne promessa, a sposare molte donne per garantirsi dalla morte (v. 720). Certo Ferete è un cinico a cui non interessa la buona fama (grave scandalo nella cultura greca), e un ipocrita che nei confronti di Alcesti passa dall’elogio convenzionale all’incomprensione sostanziale e all’insulto; ma le sue parole colpiscono a fondo un Admeto che le riecheggerà nella scena delle esequie, fondando su di esse, oltre che sulla privazione affettiva, la propria infelicità.
Il dramma non poteva non rendere problematica la lucente favola d’amore, perché in esso l’amore si qualifica non come una sorgente prodigiosa di beneficio, ma come una relazione tra persone inscritte in un campo sociale: sublime e meschino vi si intrecciano con provocatoria spregiudicatezza, suggerendo che attraverso il paradosso di Admeto ciò che si sconta è il non poter negare la colpevolezza insita nel sopravvivere, tanto più amara quanto più forte è il legame con chi se n’è andato.
MEDEA
La nutrice di Medea ricorda i fatti che vorrebbe non fossero mai accaduti: il viaggio degli Argonauti in Colchide alla ricerca del vello d’oro, la fuga di Medea, che per amore di Giasone ha tradito il padre, l’uccisione successiva di Pelia, zio e nemico di Giasone, che li ha costretti a riparare a Corinto. Ma a Corinto Giasone si appresta a sposare la figlia del re Creonte, e per questo ha abbandonato Medea, che consuma la propria disperazione nel digiuno e nel pianto. Successivamente il pedagogo porta altre notizie: a Medea e ai suoi figli si prepara l’esilio, senza che Giasone si opponga. Sul dialogo dei due servi incombe dall’interno l’urlo di Medea, che cerca la morte e maledice assieme a Giasone i figli (la nutrice li tiene prudentemente in disparte).
Entra il Coro delle donne di Corinto, che ode i lamenti fuori scena di Medea e le manifesta solidarietà, chiedendo alla nutrice di farla uscire.
Medea esce e parla. Non vuole che la sua solitudine sia interpretata come ritrosia superba, né vuole accrescere l’emarginazione, che denuncia con preciso rigore e che è, prima di tutto, radicata nella desolante condizione femminile: dopo essere stata venduta a un marito, la donna è costretta a un’esistenza asfittica. Ma questa infelicità universale è una condizione ancora migliore della sua, perché Medea è straniera e indifesa, senza una famiglia che possa prendere le sue parti; nella vendetta che si accinge a compiere la proteggano dunque, con il silenzio complice, le donne del Coro: ed esse promettono.
Arriva Creonte a pronunciare il bando ufficiale contro Medea; ha paura di lei e della sua sapienza di maga. Medea risponde con un’amara constatazione della distanza diffidente che separa il sapiente dalla collettività, e cerca di convincere Creonte che non ha rancore verso di lui. Pur non fidandosi, e con il presentimento dell’errore, Creonte cede a una richiesta apparentemente innocua: ritardare di un giorno l’esilio. Uscito il re, Medea lo investe di furente disprezzo e dichiara che in quel giorno compirà la vendetta su Creonte e sui nuovi sposi, con il ferro o, meglio, col veleno: ma ha bisogno di un asilo che, dopo, la accolga.
Il Coro canta la sua solidarietà in una violenta requisitoria contro il tradimento di Giasone, esempio di una violenza maschile che ha il privilegio dell’impunità, anche perché la poesia è monopolio dei maschi.
Entra Giasone, imbarazzato, protestando interesse alla sorte di Medea che pure considera, per la sua indole violenta, responsabile dei mali che le toccano. Medea gli ricorda la loro storia precedente, i benefici ricevuti e i giuramenti violati, e gli mette davanti agli occhi la sua insostenibile situazione: non sa più dove andare, troppi luoghi sono bagnati del sangue versato per gli interessi di lui. L’uomo si difende con cavilli, attribuisce ad Afrodite più che alla volontà di Medea la propria salvezza; sostiene di avere dato a Medea più di quanto abbia ricevuto, consentendole di abitare in Grecia e di avervi fama; infine protesta di avere voluto il matrimonio con la figlia di Creonte non per un nuovo amore ma solo in vista di una sistemazione migliore per tutti. Medea, dopo uno sprezzante giudizio sull’abilità retorica che pretende di mistificare i fatti, rinfaccia a Giasone il pregiudizio razzistico che porta a ripudiarla e rifiuta il suo aiuto.
Il Coro depreca la potenza dell’amore privo di moderazione, in cui vede la causa del tradimento di Giasone, e compiange Medea per la perdita della patria.
Appare il re d’Atene, Egeo, reduce dall’oracolo di Delfi dove ha c...
Indice dei contenuti
- Premessa
- I presupposti del teatro greco
- Eschilo
- Sofocle
- Euripide
- Aristofane
- Menandro
- Plauto
- Terenzio
- Seneca
- Bibliografia