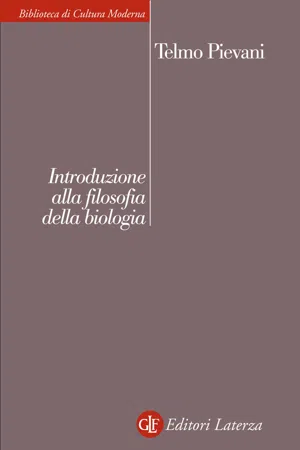
- 278 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Introduzione alla filosofia della biologia
Informazioni su questo libro
Gradualismo e puntuazionismo, geni e ambiente, adattamento e selezione, progresso e contingenza, strutture e funzioni, caso e necessità: la biologia fa della straordinaria diversità e imprevedibilità della vita il proprio oggetto di studio. Nonostante gli intriganti sviluppi conosciuti dalla disciplina negli ultimi anni, non si è ancora affermata – almeno in Italia – una solida tradizione di studi filosofici in materia. Questa introduzione alla filosofia della biologia ripercorre i grandi temi delle scienze del vivente da un punto di vista evoluzionistico, colmando un vuoto nella letteratura del settore.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Introduzione alla filosofia della biologia di Telmo Pievani in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophie e Logik in der Philosophie. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
PhilosophieCategoria
Logik in der PhilosophieCapitolo sesto. La selezione e i suoi limiti: funzionalismo e strutturalismo, progresso e contingenza
I problemi connessi al concetto di adattamento coinvolgono dunque il nocciolo teorico più profondo della filosofia della biologia. Che cos’è una funzione? Come distinguiamo quali aspetti di un organismo sono un adattamento e quali sono elementi di struttura? Cosa intendiamo quando diciamo che la selezione naturale ha favorito un certo carattere «per» svolgere una determinata funzione? Qui il ruolo dell’evoluzionismo diventa cruciale. Mentre i biologi evolutivi devono raccontare una storia per spiegare l’emergenza di un tratto funzionale, gli anatomisti e i fisiologi si limitano a fare un’analisi funzionale dell’utilità corrente di una struttura organica, in quanto «componente di fitness» attuale. Il concetto di exaptation mostra che queste due accezioni di funzione non necessariamente coincidono: una funzione storicamente importante può non essere più la causa dell’utilità attuale di una funzione (causal role function).
Una funzione biologica può essere spiegata attraverso le sue origini evolutive: si dirà che la funzione di un tratto è data dagli effetti positivi in virtù dei quali esso è stato selezionato (teoria eziologica), indipendentemente dal fatto che questi effetti siano attivi ancora oggi o no. Si tratta di un approccio tipicamente neodarwiniano centrato sul ruolo della selezione naturale come generatrice di tratti funzionali alla sopravvivenza e alla riproduzione. Ben pochi biologi sono propensi a ledere questa teoria, uscendo così dal solco darwiniano: si tratta di un’acquisizione condivisa da tutte le correnti di pensiero significative della filosofia della biologia attuale.
In una prospettiva genocentrica la definizione eziologica viene però leggermente ristretta: la funzione di un tratto coincide con gli effetti adattativi operanti che aumentano la «propensione» di un organismo a riprodursi e a diffondere quante più copie possibile dei propri geni (teoria della propensione) (Bigelow, Pargetter, 1987). Se un comportamento e un organo aumentano la propensione riproduttiva grazie a certi loro effetti, possiamo definire questi ultimi come la loro «funzione». Qui dunque esuliamo da considerazioni relative alla storia evolutiva di un tratto adattativo e ci soffermiamo esclusivamente sull’utilità attuale, evitando le incertezze delle ricostruzioni funzionali a posteriori che rischiano di trasformarsi in quelle «storie proprio così» atte a giustificare il presente (Hauser, 1996). Questo rischio viene definito «adattazionismo» ed è stato oggetto di una nota polemica in ambito evoluzionistico consumatasi nei primi anni Ottanta.
1. L’articolo sui pennacchi di San Marco
Nel 1978 Richard Lewontin fu invitato a un convegno della Royal Society di Londra per sostenere la posizione critica espressa dopo l’uscita del testo programmatico di Edward O. Wilson sulla sociobiologia nel 1975. Al genetista di Harvard fu offerto l’intervento conclusivo dell’intera manifestazione. Lewontin fu tuttavia costretto a rifiutare l’invito e propose in sua sostituzione il collega Stephen J. Gould. I due concordarono per il prestigioso appuntamento londinese un intervento che fece scalpore, suscitando non poche reazioni polemiche nell’establishment accademico britannico. In quell’occasione iniziò il lungo scambio polemico a distanza fra Gould e Richard Dawkins, che aveva pubblicato due anni prima Il gene egoista.
Il soggetto dell’intervento di Gould e Lewontin, dal titolo The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme (1979), giungeva al termine di un lungo periodo di ricerche volte a mettere in crisi l’approccio teleonomico e funzionalista ai processi adattativi. Gould aveva condotto in quegli anni con David M. Raup, Thomas Schopf e Daniel Simberloff i primi studi sui modelli stocastici nella filogenesi e alcune ricerche teoriche sulla tradizione biologica strutturalista dell’Europa continentale, contrapposta alla tradizione selezionista inglese. Era inoltre motivato da un impegno critico molto accentuato verso le teorie sociobiologiche allora diffusamente propagandate sulla stampa statunitense ed europea. Il lavoro di Lewontin in genetica, d’altra parte, puntava a delineare una concezione del processo evolutivo che, senza negare la plausibilità e la frequenza relativa dei fenomeni di adattamento, non assegnasse un campo di validità onnicomprensivo al meccanismo adattativo nella spiegazione del cambiamento.
L’intervento di Gould fu apprezzato dallo stesso John Maynard Smith come «evento culminante» dell’incontro e fu pronunciato in uno stile a tratti felicemente divulgativo e a tratti rigorosamente «accademico», tanto da essere citato dal maggiore agente letterario americano, John Brockman, come esempio migliore della nuova divulgazione scientifica «d’autore» ai confini delle due culture (Brockman, 1995). Alcuni anni dopo, fra i molti dibattiti e le polemiche sulla rilevanza dei «pennacchi» trascinate per anni (Dennett, 1995; Queller, 1995; Houston, 1997), questo episodio di storia dell’evoluzionismo fu addirittura scelto da alcuni storici della scienza e della letteratura come emblema delle capacità narrative e retoriche degli scienziati, divenendo una specie di «caso letterario» studiato nei corsi universitari (Selzer, a cura di, 1993).
Gould in quell’occasione sostenne che il programma adattazionista si manifestava come una forma di fedeltà quasi inconsapevole a un’abitudine radicata fra gli studiosi dell’evoluzione. Questo particolare stile interpretativo dei processi naturali era riassumibile in alcune proposizioni di base: 1) la selezione naturale è il meccanismo pervasivo di costruzione del progetto organico; 2) l’organismo è «atomizzato» nei suoi tratti singoli, ciascuno dei quali è poi spiegato come struttura ottimale forgiata dalla selezione naturale per la funzione attuale; 3) questa idea di ottimizzazione part by part si affianca a una concezione delle interazioni fra le parti organiche centrata sulla nozione di «compromesso» o di «equilibrio»: la selezione agisce attraverso un bilanciamento funzionale che garantisce costantemente l’ottimalità dell’organismo intero; 4) fenomeni di formazione di nuove strutture per via di meccanismi non adattativi non sono negati per principio (non si possono escludere eventi come le derive genetiche o le correlazioni di crescita allometriche), ma sono ritenuti marginali sul piano esplicativo; 5) la procedura di ricostruzione del processo evolutivo si configura nell’adattazionismo come un «riavvolgimento» temporale a partire dall’utilità attuale.
Questo modo particolare di concepire le cause del cambiamento corrisponde anche a una modalità di «raccontare le storie naturali» ritenuto da Gould infalsificabile per principio. Le tecniche argomentative adattazioniste furono così sintetizzate nel 1978: a) «se un argomento adattativo fallisce, cercane subito un altro», anziché vagliare storie alternative; b) «se un argomento adattativo fallisce, deve per forza esisterne un altro» (il paradigma legittima la propria esposizione a ipotesi non verificate); c) «in assenza di un buon argomento adattativo al momento, attribuisci le difficoltà all’imperfetta conoscenza di dove un organismo vive e di cosa fa»; d) «enfatizza l’utilità immediata ed escludi altri attributi della forma organica».
L’accusa fu dunque quella di voler operare la scelta di una gamma peculiare di «storie plausibili», a partire dal principio di selezione naturale ottimizzante come esclusiva modalità di spiegazione, sottraendosi a una reale verifica dell’ipotesi adattativa specifica. Ogni tratto utile (aptation) esiste proprio perché è utile (adaptation). In quello che ritengono lo spirito autentico del pluralismo darwiniano, cioè il rifiuto di un’omogeneizzazione dei meccanismi evolutivi sotto il criterio della selezione del più adatto, i due autori tracciarono nel 1978 una classificazione di alternative alla spiegazione selezionista ortodossa.
2. Selezione e vincoli strutturali
La classe generale degli episodi di cambiamento evolutivo riconoscibili può comprendere al proprio interno, oltre agli eventi di normale adattamento, anche altre cinque tipologie:
1) trasformazioni il cui meccanismo di consolidamento non registra né un adattamento né gli effetti della selezione naturale; è il caso delle variazioni dovute a fattori puramente casuali, come nel caso delle derive genetiche, in cui si verifica un processo stocastico di cambiamento nelle frequenze geniche;
2) trasformazioni in cui non vi è né adattamento né selezione naturale nella parte in questione: la forma della parte considerata è una conseguenza correlata agli effetti della selezione naturale su altre parti; è il caso delle correlazioni di crescita, dell’allometria, dei fenomeni di compensazione evolutiva, delle correlazioni meccaniche di sviluppo;
3) trasformazioni in cui vi è un disaccoppiamento fra adattamento e selezione; nei due sensi: selezione senza adattamento, come avviene in presenza di pressioni selettive multiple che si intrecciano fino al raggiungimento di un grado di stabilità senza necessariamente la «guida» di adattamenti primari; o adattamento senza selezione, come nei casi di «plasticità fenotipica»: un cambiamento geografico o climatico induce una trasformazione fenotipica di carattere prettamente adattativo senza che vi sia stata una pressione selettiva di lunga durata e continuativa (l’esempio citato sovente è la modificazione fenotipica delle spugne e dei coralli per adattarsi ai mutevoli regimi di flusso e correnti delle acque);
4) trasformazioni per adattamento e selezione, senza tuttavia una base selettiva per le differenze fra i vari tipi di adattamento; organismi simili possono sviluppare diverse strategie adattative come soluzione alle medesime sollecitazioni ambientali; si parla in questo caso di «picchi adattativi multipli»;
5) trasformazioni per adattamento con selezione, in cui l’adattamento è un’utilizzazione secondaria di parti formatesi per ragioni non selettive: la tipologia specifica indicata tecnicamente con il termine di exaptation nella sua accezione più radicale.
La trattazione di Gould e Lewontin sulle tipologie di azione della selezione naturale non implica dunque una sottovalutazione del ruolo e della frequenza dei fenomeni adattativi. Le trasformazioni non primariamente adattative o comunque non dettate dalla causazione lineare della selezione non sono equiparate a fenomeni «non ancora ben conosciuti» all’interno degli organismi. Gould opta per una forma di strutturalismo pluralista centrato su un’idea portante: l’opera della selezione naturale interagisce costantemente, a tutti i livelli gerarchici, con i vincoli imposti dalla struttura organica individuale. L’evoluzione scaturisce da questa interazione fra spinte selettive e resistenze strutturali.
Come scrisse lo zoologo austriaco Rupert Riedl nel 1978, questo stile «organicista» del pensiero biologico si trova in minoranza fra i teorici dell’evoluzione. Ma non si tratta, in definitiva, di negare l’azione dell’adattamento, bensì di indebolire la riconduzione unilaterale di ogni schema strutturale, divergente in qualche tratto rispetto ai simili e agli ascendenti, a una funzionalità adattativa primaria additata automaticamente come causa della divergenza stessa.
I vincoli che giustificano un’interpretazione estensiva dei principi del cambiamento naturale per Gould e Lewontin sono riconducibili a quattro categorie principali: a) vincoli filetici residuali: resistenze al cambiamento dovute all’inerzia evolutiva sedimentatasi nel passato (Homo sapiens ha ancora, per esempio, una qualche resistenza ancestrale alla postura eretta); b) vincoli filetici di tipo fisico: i limiti fisiologici che le leggi della fisica impongono al cambiamento degli individui (i molluschi non volano, gli insetti non sono grandi come elefanti e gli alberi non crescono fino in cielo – Gould, 1996); c) vincoli filetici dello sviluppo: restrizioni alle trasformazioni evolutive possibili dovute ai «canali di sviluppo» ontogenetici refrattari al cambiamento e alla manipolazione; d) vincoli ontogenetici strutturali o «architetturali»: descritti per esempio dal paleontologo tedesco Adolf Seilacher nel 1970 (che si occupò nello specifico delle strutture corporee divergenti dei molluschi e dei brachiopodi); si tratta delle restrizioni al campo dei cambiamenti evolutivi potenziali da attribuire alla struttura materiale degli organismi, cioè alla particolare costruzione e interconnessione dei componenti del piano corporeo fondamentale o Bauplan.
3. Il principio delle lunette
Il paradigma adattazionista viene definito come una «inversione della logica esplicativa»: l’effetto risultante del processo evolutivo (il «prodotto») viene inteso come causa del processo stesso. Nell’esordio del saggio del 1978 gli autori illustrano questa inversione logica attraverso un’efficace metafora architettonica.
Se la costruzione della cattedrale di San Marco prevede la sovrapposizione di una cupola circolare, divisa in quattro quadranti, su un corpo quadrato la cui sommità è costituita da quattro archi sui lati, necessariamente si otterranno ai quattro angoli degli spazi triangolari, affusolati verso il basso. Questi «pennacchi» (spandrels se bidimensionali; più precisamente pendentives se tridimensionali) saranno delimitati dagli archi di sostegno e dal bordo inferiore del quadrante della cupola. Ciascun pennacchio contiene un mosaico perfettamente adattato allo spazio disponibile: un evangelista è seduto nella parte superiore, affiancato dalle città celesti, mentre al di sotto un uomo simboleggiante i fiumi biblici versa acqua da una brocca nello spazio che si restringe fino a chiudersi ai suoi piedi. Il disegno è così armonioso che siamo tentati di vederlo come il punto iniziale di qualsiasi analisi, come la causa di tutta l’architettura circostante, notano Gould e Lewontin.
Restando nella metafora, l’argomentazione adattazionista suonerebbe così: il disegno attuale è ottimamente adattato allo spazio dei pennacchi, quindi i pennacchi sono stati concepiti e progettati per garantire la rappresentazione degli evangelisti e della profusione dell’acqua dai quattro estremi della costruzione allegorica. Una scansione logica differente riporta invece la causa come effetto della struttura preesistente: le regole architettoniche di costruzione della cattedrale impongono vincoli alla ripartizione dello spazio all’interno dell’edificio; si formano necessariamente spazi interstiziali fra le componenti maggiori della costruzione; questi spazi vengono ri-utilizzati con ingegno dai mosaicisti che trasformano la regolarità dei quattro pennacchi in una composizione allegorica; questa regolarità in base quattro, di tipo exattativo, ricade poi sull’intera struttura perché, per simmetria di composizione, altri mosaici e altre rappresentazioni dovranno essere organizzate dagli artisti in base quattro; da qui l’impressione che tutto l’impianto espositivo sia stato studiato appositamente in questo modo fin dall’inizio e quindi che i pennacchi stiano lì «proprio per» ospitare i quattro evangelisti. I pennacchi sono una conseguenza collaterale di un’architettura complessiva, strutture «non adattative» poi cooptate per alloggiare opere d’arte all’apparenza «perfette per» quegli spazi. In altri casi (Gould cita, in 2002, trad. it., p. 1569, la chiesa di San Fedele a Milano), l’exaptation artistico non sembra altrettanto ben riuscito, svelando la sua sub-ottimalità di fondo.
L’inversione adattazionista è particolarmente evidente, secondo i due autori, quando in causa sono spiegazioni evoluzionistiche di comportamenti umani. Non necessariamente deve esistere un solo significato adattativo e sostenere che qualcosa nasce come «effetto secondario» in un contesto già organizzato non implica né una sottovalutazione di principio dell’effetto stesso né una rinuncia alla sua intelligibilità. Inoltre, l’adattazionismo della sociobiologia non presuppone soltanto la stabilità adattativa di contro a ogni cambiamento ambientale, ma anche una stabilità fenotipica oggi messa in discussione da vari studi: secondo la DST, lo sviluppo dipende da una matrice complessa di risorse e non solo dai geni, quindi il cambiamento ambientale e sociale cambia i processi di sviluppo e può dare origine a fenotipi fisicamente diversi. Ciò vale a maggior ragione se ci riferiamo ad aspetti comportamentali del fenotipo odierno.
In occasione della stesura del testo collettaneo di Brockman citato prima, George C. Williams, a tutti gli effetti uno dei padri nobili del programma adattazionista, commentò l’intervento di Gould sul concetto di exaptation con un’obiezione arguta, di tipo semantico: se un’ala, prima di diventare tale, era un arto e prima ancora una pinna e si è poi accidentalmente rivelata utile per fare tutt’altro, allora essa sarà alternativamente un exaptation se riferita al camminare e al nuotare, un adaptation se riferita al volare. Dipende da quale funzione scegliamo, arbitrariamente.
Il ragionamento di Williams si sottrae ai due argomenti svalutativi dell’exaptation sostenuti da Maynard Smith: sottovalutazione sperimentale e sottovalutazione della novità. Williams accetta che gli eventi di exaptation siano la norma in natura. Ritiene tuttavia che non sia necessario sostituire il termine adaptation: è sufficiente conce...
Indice dei contenuti
- Introduzione. Frustrazioni di un collezionista di francobolli
- Ringraziamenti
- Capitolo primo. Le scienze del vivente fra gradualismo e puntuazionismo
- Capitolo secondo. Micro e macroevoluzione: l’eredità contesa della Sintesi Moderna
- Capitolo terzo. Replicatori e interattori: il selezionismo genico e la teoria gerarchica dell’evoluzione
- Capitolo quarto. L’impero genocentrico e i suoi ribelli: la teoria dei sistemi di sviluppo
- Capitolo quinto. La dialettica tra forme e funzioni: i concetti di adattamento e di «exaptation»
- Capitolo sesto. La selezione e i suoi limiti: funzionalismo e strutturalismo, progresso e contingenza
- Capitolo settimo. L’evoluzione del comportamento umano: sociobiologia, psicologia evoluzionista ed ecologia
- Conclusione. La filosofia della biologia oggi: consenso riduzionista e strategie pluraliste