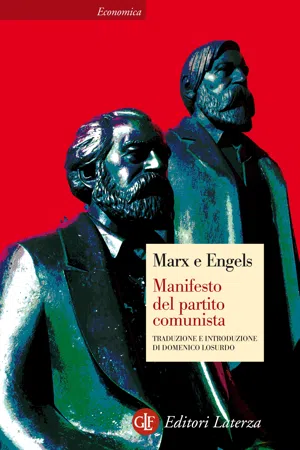
- 114 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Manifesto del partito comunista
Informazioni su questo libro
Tra le varie edizioni del Manifesto del partito comunista questa si distingue sia per l'autorevolezza dei traduttore, che non è solo un grandissimo esperto della lingua tedesca e del marxismo, ma è anche affermato saggista, sia per la chiarezza dello stile. L'ampia Introduzione suggerisce una nuova lettura del grande classico. Il prezzo è competitivo rispetto a quello delle edizioni più accreditate.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Manifesto del partito comunista di Friedrich Engels,Karl Marx,Erdmut Bielmayer in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Political Philosophy. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
PhilosophyCategoria
Political PhilosophyIntroduzione
1. Schiavitù antica e schiavitù moderna, natura e storia
Nel rileggere il Manifesto del partito comunista a oltre centocinquant’anni dalla sua pubblicazione, proviamo a interrogarci sulle fondamentali novità teoriche e politiche apportate dal testo di Marx e Engels. Esse non risiedono tanto nella presa di coscienza dell’asprezza del conflitto sociale tra proletariato e borghesia, e neppure nell’affermazione che tale conflitto è stato storicamente preceduto dalla lotta di classe tra schiavi e proprietari di schiavi e tra servi della gleba e feudatari. Alcuni anni prima, nel corso del suo viaggio in Inghilterra, Tocqueville è così colpito dallo stridente contrasto tra la spaventosa miseria di massa e l’opulenza di pochi da lasciarsi sfuggire un’esclamazione assai significativa: «Di qui lo schiavo, di là il padrone, di là la ricchezza di alcuni, di qui la miseria del più gran numero»1. In altra occasione, il liberale francese mette persino in guardia contro il pericolo delle «guerre servili»2, cioè di sollevazioni di schiavi analoghe a quelle verificatesi nell’antichità classica. Lo «spettro del comunismo» evocato dal Manifesto sembra assumere in Tocqueville le sembianze terrifiche di una sorta di Spartaco proletario e moderno.
La condizione operaia del tempo viene così paragonata alla schiavitù: prima ancora che in Marx e Engels, questo motivo attraversa in profondità, in modo consapevole o inconsapevole, la tradizione liberale. Locke non ha difficoltà a constatare che «la maggior parte dell’umanità» è «resa schiava» (enslaved) dalle condizioni oggettive di vita e di lavoro. Mandeville non ha dubbi sul fatto che la «parte più meschina e povera della nazione» è destinata per sempre a svolgere un «lavoro sporco e simile a quello dello schiavo» (dirty slavish Work)3; essa è impegnata, per dirla questa volta con Burke, in occupazioni non solo «mercenarie» ma anche «servili» (servil), cioè – come subito chiarisce la versione del traduttore tedesco – «proprie dello schiavo» (sklavisch)4.
Ma tutto ciò non incrina la buona coscienza delle classi dominanti e della borghesia liberale del tempo, la quale si libera del problema rinviandolo a una sfera extra-politica. «L’Inghilterra – osserva Marx nel 1844 – trova il fondamento della miseria nella legge naturale, per la quale la popolazione deve costantemente superare i mezzi di sussistenza» e spiega il «pauperismo» con la «cattiva volontà dei poveri», incapaci di resistere all’incontinenza sessuale5. Il riferimento polemico è a Malthus, il quale, a sancire la restrizione della sfera politica, chiama paradossalmente l’economia politica. Una volta che essa sia divenuta «un oggetto di popolare insegnamento», i poveri comprenderanno che devono attribuire alla natura matrigna o alla loro individuale debolezza o imprevidenza la causa delle privazioni che soffrono; «l’economia politica è la sola scienza di cui possa dirsi che dall’ignorarla sono a temersi non solo privazioni, ma mali positivi e gravissimi»6.
Questa è anche l’opinione di Tocqueville, il quale ritiene necessario
diffondere tra le classi operaie […] qualche nozione, tra le più elementari e più certe, dell’economia politica, che faccia loro comprendere, ad esempio, ciò che di permanente e necessario vi è nelle leggi economiche che reggono il tasso dei salari; perché tali leggi, essendo in qualche modo di diritto divino, in quanto scaturiscono dalla natura dell’uomo e dalla struttura stessa della società, sono collocate al di fuori della portata delle rivoluzioni7.
I poveri – incalza più tardi John Stuart Mill – devono essere dissuasi dal contrarre matrimonio e rientra tra i «poteri legittimi dello Stato» imporre un vero e proprio divieto8.
I Manoscritti economico-filosofici del 1844 ironizzano sull’economia politica così intesa: questa «scienza della mirabile industria» e della «ricchezza» si rivela come una «scienza di ascesi» e di «rinuncia»; il suo ideale è «lo schiavo ascetico ma produttivo»9. Duro è il giudizio espresso su siffatti «economisti» anche dal Manifesto (infra, p. 42). Ma ora assistiamo a un ulteriore sviluppo della critica. La pretesa di mettere sul conto della natura matrigna la permanente miseria di massa ignora del tutto le crisi di sovrapproduzione che caratterizzano e investono il capitalismo. Su di esse conviene invece concentrare l’attenzione:
Durante le crisi commerciali viene regolarmente distrutta una gran parte non solo dei prodotti finiti, ma persino delle forze produttive già create. Durante le crisi scoppia un’epidemia sociale che in ogni altra epoca sarebbe apparsa un’assurdità: l’epidemia della sovrapproduzione. La società si trova improvvisamente ricacciata in uno stato di momentanea barbarie; una carestia, una guerra generalizzata di annientamento sembrano averle sottratto tutti i mezzi di sussistenza; l’industria, il commercio sembrano distrutti, e perché? Perché la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio (infra, pp. 13-14).
Se in Smith la celebrazione della «ricchezza delle nazioni» annuncia la fine dell’antico regime, nel Manifesto l’inno sciolto all’impetuoso sviluppo delle forze produttive stimolato dalla borghesia è anche e soprattutto un epitaffio per un ordinamento che, proprio grazie agli straordinari successi da esso conseguiti, fa apparire politicamente e moralmente inammissibile la miseria e l’insicurezza di massa su cui, nonostante tutto, esso continua a fondarsi. Siamo in presenza non di una costrizione naturale, ma di un problema politico; e il problema politico risiede non già nella penuria ormai sconfitta, bensì in una «ricchezza delle nazioni» che non riesce a divenire reale ricchezza sociale.
Una sorta di oggettiva polemica a distanza sembra istituirsi tra gli autori del Manifesto da un lato e Tocqueville (e la tradizione politica di cui egli è eminente rappresentante) dall’altro. Nel fare il bilancio degli sconvolgimenti e della catastrofe del ’48, il liberale francese li mette sul conto del socialismo, cioè delle «teorie economiche e politiche» le quali vorrebbero far «credere che le miserie umane siano opera delle leggi e non della provvidenza, e che si potrebbe sopprimere la povertà cambiando l’ordinamento sociale»10. È per l’appunto la tesi sostenuta, alla vigilia della rivoluzione, dal Manifesto, il quale intende in primo luogo chiamare i «proletari» a prendere consapevolezza della dimensione eminentemente politica del loro dramma. Ma voler intervenire in questa sfera significa per Tocqueville intaccare l’ordinamento naturale della «società», facendo «a pezzi le basi su cui essa riposa»11. In realtà, replicano Marx e Engels:
Voi condividete con tutte le classi dominanti tramontate la concezione interessata in base alla quale trasformate i vostri rapporti di produzione e di proprietà, da rapporti storici quali essi sono, che appaiono e scompaiono nel corso della produzione, in leggi eterne della natura e della ragione. Ciò che voi comprendete riguardo alla proprietà antica, ciò che voi comprendete riguardo alla proprietà feudale, non riuscite più a comprenderlo riguardo alla proprietà borghese (infra, p. 31).
L’anno prima, così, Miseria della filosofia aveva criticato gli «economisti»: per essi «c’è stata storia, ma ormai non ce n’è più»12.
Agli occhi di Tocqueville, è proprio l’illusione che ci sia un politico «rimedio contro questo male ereditario e incurabile della povertà e del lavoro» a provocare gli «esperimenti» e le «rovine» che caratterizzano l’incessante ciclo rivoluzionario francese sfociato nel socialismo. Siamo in presenza di un’ideologia visionaria, di un «errore funesto» che bisogna assolutamente liquidare13. Per il Manifesto, il socialismo non è l’elaborazione, folle o geniale che sia, di un intellettuale o gruppo di intellettuali, bensì l’espressione teorica di bisogni e possibilità reali: «Le posizioni teoriche dei comunisti non poggiano affatto su idee, su princìpi inventati o scoperti da qualche apostolo salvatore del mondo. Esse sono soltanto espressioni generali dei rapporti effettivi di una lotta di classe già in atto, di un movimento storico che si sta svolgendo sotto i nostri occhi» (infra, p. 26). Faticosamente, tra tentativi ed errori, i proletari prendono coscienza del fatto che le «catene» che gravano su di loro, la «schiavitù» (infra, pp. 57 e 22) che essi subiscono, rinviano a un ordinamento politico-sociale storicamente determinato che si tratta ora di mettere in discussione.
2. Estensione della sfera politica e «condizioni sociali e politiche»
Se non alla limitatezza delle risorse disponibili e alla dabbenaggine o imprevidenza dell’individuo, il quale, lasciandosi trascinare dai sensi, non tiene conto del «principio di popolazione» caro a Malthus, la miseria di massa rinvia comunque a una sfera che è da considerare privata. Dopo tutto – argomenta l’ideologia dominante – il livello dei salari e le condizioni di lavoro rinviano a un contratto liberamente pattuito tra le parti. È dunque un rapporto tra privati. La società borghese – osserva Engels già nel 1845 – così replica all’operaio che si lamenta e recrimina:
Voi eravate libero di decidere, ness...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Nota biografica
- Karl Marx Friedrich EngelsManifesto del partito comunista
- I. Borghesi e proletari
- II. Proletari e comunisti
- III. Letteratura socialista e comunista
- IV. La posizione dei comunisti rispetto ai diversi partiti d’opposizione