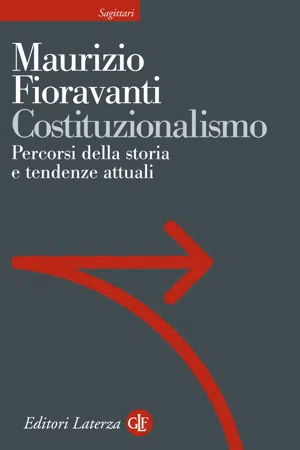1. Il costituzionalismo: un profilo storico
1. Premessa
Il costituzionalismo è un movimento di pensiero fino dalle sue origini orientato a perseguire finalità politiche concrete, essenzialmente consistenti nella limitazione dei poteri pubblici e nell’affermazione di sfere di autonomia normativamente garantite. Il costituzionalismo appartiene integralmente all’età moderna, anche se nelle sue strategie sono ricorrenti problematiche che risalgono a epoche precedenti, a matrici antiche e medievali. Più precisamente, si può affermare che il costituzionalismo nasce e si afferma nel contesto del processo di formazione dello Stato moderno europeo. Se consideriamo lo Stato moderno europeo come una figura storica complessa, si può dire che accanto al suo primo lato, su cui si colloca il principio di sovranità e si svolge il processo di concentrazione del potere pubblico sul territorio, si pone un secondo lato, su cui opera proprio il costituzionalismo, sul versante della pluralità, dei limiti, delle garanzie, e anche della partecipazione. Per questo motivo, si può affermare che il costituzionalismo nasce insieme allo stesso Stato moderno, al fine di controllare, limitare, ricondurre a regole quei poteri pubblici, che iniziarono a porsi in posizione di centralità sui territori a partire dal Quattordicesimo secolo. In altre parole, ciò che caratterizza la storia costituzionale europea è il fatto che il processo di concentrazione dei poteri pubblici sul territorio, del potere di chiamare alle armi, di esigere le imposte, di amministrare la giustizia, è accompagnato fin dall’inizio dall’esigenza di fissare regole e limiti, anche in forma scritta, e anche attraverso lo strumento delle assemblee rappresentative, Parliaments, o Landtage, o Cortes, o altro ancora.
È questo il ‘costituzionalismo delle origini’, che è già ‘costituzionalismo’, perché già orientato allo scopo fondamentale della limitazione del potere a fini di garanzia, ma che non conosce ancora una dimensione che risulterà in seguito decisiva, ovvero il principio di uguaglianza1. I limiti non si pongono dunque a protezione di diritti individuali attribuiti a soggetti assunti come tra loro uguali, come nel paradigma giusnaturalistico moderno, ma a tutela di libertà e sfere di autonomia, essenzialmente di carattere corporativo e cittadino, che hanno il loro fondamento prima di tutto nella storia. E la ‘costituzione’, che questo costituzionalismo propugna, presuppone un corpo politico articolato e complesso, fatto di corpi distinti, di equilibri e di commisurazione fra poteri distinti e nello stesso tempo coesistenti.
Il principio di uguaglianza, che era stato solo formulato sul piano teorico dalle dottrine di diritto naturale della metà del Diciassettesimo secolo, irromperà nella vicenda storica del costituzionalismo solo più tardi, praticamente alla vigilia della rivoluzione francese. La data in questo senso emblematica è quella del 1762, della pubblicazione del Contratto sociale di Rousseau. In quel torno di tempo tutto cambia nella storia del costituzionalismo, nel senso che la costituzione non potrà più essere raffigurata solo come la norma fondamentale di un corpo politico, garante dei suoi equilibri interni e della giusta commisurazione di tutti i poteri in esso operanti, com’era nel costituzionalismo delle origini fino a Montesquieu, e inizierà a essere considerata piuttosto come un atto, espressione esso stesso di sovranità, istitutivo di poteri chiamati, come nel caso della rivoluzione francese, a demolire l’antico regime, e conseguentemente a costruire una società nuova, fondata proprio sul principio di uguaglianza.
Come sappiamo, le cose si porranno in modo parzialmente diverso nel caso dell’altra rivoluzione, quella americana, che non aveva da distruggere alcun precedente antico regime, e in cui si conservò quindi in modo più netto il costituzionalismo dei limiti e degli equilibri. Ma nel loro complesso, le rivoluzioni rappresentano comunque un momento di svolta nella storia del costituzionalismo, per il prodursi per il loro tramite di costituzioni scritte, frutto di espliciti poteri costituenti, istitutive di poteri dotati di sovranità. Ma ciò che determina la grande differenza sul piano storico nel costituzionalismo delle rivoluzioni rispetto al costituzionalismo delle origini rimane pur sempre e comunque il principio di uguaglianza, elaborato a partire dalle moderne dottrine giusnaturalistiche, in versioni più estreme, come nella linea che da Hobbes conduce a Rousseau, o più moderate, come nella linea che da Locke conduce a Kant. Da tali differenti versioni deriveranno anche diverse soluzioni costituzionali, rispettivamente più orientate a sottolineare la garanzia insita nella volontà generale e nel primato della legge generale e astratta, o a sviluppare forme di governo moderate e bilanciate, o comunque tecniche di limitazione dei poteri, ispirate da una logica di fondo di carattere antidispotico. Il costituzionalismo delle rivoluzioni è dunque in sé complesso e diversificato. Ma le diverse soluzioni proposte sono comunque differenti strumentazioni, come tali concepite in funzione di un obiettivo, che è comune: la garanzia dei diritti individuali e la realizzazione del principio di uguaglianza.
Il costituzionalismo delle rivoluzioni non è però affatto, a sua volta, il costituzionalismo che dominerà la scena in Europa nei secoli successivi, e in particolare nel corso dell’età liberale. All’inizio del Diciannovesimo secolo inizia infatti a prodursi un’ulteriore trasformazione, che muove proprio dalla critica al costituzionalismo delle rivoluzioni. Il fronte della critica è duplice. Da una parte, il costituzionalismo rivoluzionario viene accusato di aver troppo confidato sulla volontà generale, sulle virtù del politico e della legge stessa quale necessario strumento di garanzia dei diritti. In questa linea, il nuovo costituzionalismo liberale, pur non negando affatto il valore primario della legge, né operando in concreto per una vera e propria opposizione della costituzione alla legge, pone il problema di un fondamento più sicuro delle sfere di autonomia degli individui. Il costituzionalismo in questa prima prospettiva opera per il valore fondamentale del limite. Ci sono qui le figure di Constant e di Tocqueville in Francia, ma c’è anche tutta l’elaborazione inglese sul primato delle laws of the land, e del rule of law, a partire dalla nota e feroce critica di Burke alla rivoluzione.
Ma c’è anche un secondo fronte, come precedentemente si diceva. In questa seconda prospettiva, che all’inizio prende campo soprattutto in Germania, con la grande riflessione di Hegel, l’eccesso della rivoluzione che più si teme ha in un certo senso un segno opposto: quello di una rivoluzione che non aveva espresso un politico troppo forte e minaccioso, ma al contrario troppo debole, perché esclusivamente fondato sulla mutevole volontà degli individui, su un contratto sociale continuamente rinnovabile. Da questo punto di vista, il costituzionalismo del Diciannovesimo secolo tende a riaprire la ricerca di un forte principio di sovranità, per garantire maggiore stabilità alla società liberale e alle sue istituzioni. In questa linea, il valore fondamentale che anima il costituzionalismo è quello della tenuta dell’ordine sociale e politico, da cui tutto deriva, compresi i diritti, che solo nella legge dello Stato sovrano, rappresentativo di quell’ordine, possono trovare un’effettiva tutela.
Riprendiamo ora i due aspetti, che caratterizzano insieme il costituzionalismo dell’età liberale, ovvero il costituzionalismo degli Stati nazionali del Diciannovesimo secolo, che sarà dominante fino alla nuova grande cesura degli anni Venti del secolo scorso. Come abbiamo visto, quel costituzionalismo si costruisce allontanando una duplice minaccia: quella di un dominio incontrollato della volontà generale sulla società, ma anche quella di un altrettanto incontrollato rinnovarsi del contratto sociale e del potere costituente. Il costituzionalismo dell’età liberale ricerca il limite e la garanzia, ma anche la sicurezza e la stabilità. Tale ricerca assumerà forme diverse nelle diverse esperienze nazionali, ma non potrà non svilupparsi su entrambi i versanti. In questo senso, si può affermare che nella seconda metà del Diciannovesimo secolo esisteva in Europa una comune cultura costituzionale, che in forme diverse tentava di far coesistere garanzia dei diritti e principio di sovranità politica, ricercando in questo senso un punto di equilibrio sufficientemente fermo, ovvero una garanzia dei diritti che non mettesse in discussione il principio di sovranità, e viceversa. Quando quell’equilibrio inizierà a rompersi, inizierà il declino del costituzionalismo dell’età liberale. Si aprirà una nuova e diversa fase, anche drammatica, con i regimi totalitari. Ma il costituzionalismo ritroverà successivamente la propria via, con le Costituzioni democratiche del Novecento2.
2. Il costituzionalismo delle origini
Nel costituzionalismo delle origini c’è dunque una costituzione da affermare e da difendere, ma questa non presuppone alcun potere sovrano che rappresenti nella sua interezza la comunità politica cui la costituzione si riferisce, né è chiamata a garantire i diritti agli individui secondo il principio di uguaglianza. Tutte queste grandezze, come ‘sovranità’, ‘diritti individuali’, ‘uguaglianza’, sono sconosciute alla realtà politica e sociale entro cui prende forma il costituzionalismo delle origini. Ma, allora, com’è rappresentabile la costituzione di questo tempo storico, ovvero dei primi secoli dell’età moderna, precedenti le rivoluzioni di fine Settecento?
Direi che è rappresentabile prima di tutto con riferimento a uno spazio politico e territoriale entro il quale opera un complesso di forze, che possono essere di origine feudale o corporativa, ma che possono essere anche le forze economiche e dei mestieri presenti sul piano cittadino. In quello spazio, quelle forze sono tenute in equilibrio secondo regole consuetudinarie, ma anche scritte, in genere contrattate con il signore, con colui il quale occupa una posizione di preminenza in quel determinato territorio, nello spazio di quella determinata città. L’insieme di quelle regole, e degli equilibri che ne risultano, è la costituzione. La costituzione così intesa sta in piedi, e si mantiene nel tempo, non in virtù di un principio di sovranità che la affermi dall’alto, e neppure sulla base di un principio democratico che la legittimi dal basso, ma per la sua capacità effettuale di garantire la pace e un equilibrio ragionevole tra le forze presenti sul territorio o nella città, che comprenda il riconoscimento dei loro diritti e delle loro libertà.
Questi ultimi, ovvero i ‘diritti’ e le ‘libertà’, che possono essere sia quelli più risalenti nel tempo, di stampo medievale, in concreto esistenti come privilegi di luoghi, o di ceti, o quelli nuovi, che si agitano all’interno della civiltà comunale, sono la ‘materia’ di cui si occupa il costituzionalismo delle origini. Per riconoscerli, e per garantire a essi uno spazio proprio, pur all’interno di una comune esistenza politica, è necessario che il governo del territorio, o della città, assuma una forma temperata o moderata, che nella cultura politica e costituzionale della prima età moderna è pensata con riferimento ai grandi modelli dell’antichità: la miktè politéia dei greci e la res publica dei romani.
Una testimonianza preziosa in questo senso rimane quella di Niccolò Machiavelli (1469-1527), in particolare con i suoi Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, composti fra il 1513 e il 1519. In queste pagine, il nostro costituzionalismo trova un suo primo principio fondamentale, che è contenuto nel concetto machiavelliano di ‘civile equalità’3. L’equalità di Machiavelli deriva dalla aequabilitas che si ritrova in Cicerone4, e non ha nulla a che fare con il principio di uguaglianza che si affermerà successivamente su base giusnaturalistica. L’equalità non si impone infatti fra gli individui, ma nel governo delle forze che operano all’interno di un territorio o di una città, in modo da riconoscere a ciascuna di esse uno spazio proprio, equo e commisurato, ed evitare così che esse si fronteggino in modo minaccioso, tale da compromettere l’integrità e la stabilità della res publica, della comune esistenza politica. Governare secondo equalità significa dunque governare con moderazione, facendo prevalere l’interesse a coesistere sulla tentazione di affermare in modo unilaterale le proprie pretese.
Governare in modo moderato, secondo il principio di equalità, è dunque produttivo di pace e di concordia. È funzionale all’affermazione, e al mantenimento, di una costituzione territoriale, o cittadina, entro cui siano previst...