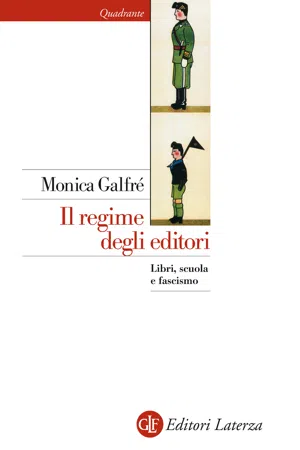
- 272 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
L'alleanza tra editoria e regime fascista ha nella scuola il suo terreno privilegiato: negli anni in cui nasce la moderna industria editoriale, produzione e diffusione dei libri di testo riflettono non solo ambizioni e limiti del totalitarismo, ma anche caratteristiche e dinamiche del mercato librario italiano. Attraverso la ricchissima documentazione di archivi editoriali e istituzionali, il volume ricostruisce una realtà vasta, frammentata e poco conosciuta, che vede la larga partecipazione del mondo della cultura. Un settore cruciale, nel quale gli interessi dell'imprenditoria privata si compenetrano con quelli statali, fino a incidere sulla politica scolastica e sugli equilibri editoriali complessivi.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il regime degli editori di Monica Galfré in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Contabilità e budget. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Contabilità e budget1. Riforma Gentile e riforma dell’editoria
I mercanti e il tempio
Negli anni Trenta Attilio Vallecchi rievocò gli inizi della sua attività di editore scolastico, coincisi con l’arrivo di Giovanni Gentile alla Pubblica istruzione, nei termini di una battaglia culturale priva di ritorno economico:
Bene scrisse, dunque, Formìggini, nel suo Chi è?: «la riforma della scuola è costata la camicia a Vallecchi!». E dire che un imbecille, evidentemente impastato di vecchi vizi del passato regime, un giorno, mentre il senatore Gentile parlava della riforma alla Camera Alta, ebbe la sfrontatezza di gridare: «Vallecchi, Vallecchi», come se in quel nome avesse voluto indicare espressione di cupidigia o quanto meno di convenienza!1
Più che avvalorare l’immagine disinteressata dell’editore tanto cara a Vallecchi, la sua polemica dava la misura della posizione controversa in cui venne a trovarsi tutta l’editoria scolastica – e non solo quella più vicina all’entourage gentiliano – nel periodo compreso tra la marcia su Roma e il Concordato.
Il problema dei libri di testo incise pesantemente sull’impopolarità della riforma Gentile, la cui attuazione si intrecciò con il processo di fascistizzazione della scuola. Ne costituiva una riprova eloquente lo spazio concesso dalla satira politica al cosiddetto carolibri. Nell’autunno del 1925 «Il becco giallo» uscì con una serie di vignette raffiguranti padri di famiglia scalzi o in mutande in atto di acquistare testi dai prezzi esorbitanti, simbolo della rapacità degli editori. Già l’anno prima una rivista come «I diritti della scuola» non aveva trovato niente di meglio dei toni sarcastici da cui era di solito aliena. «Tu devi pensare – diceva La zia a Totò – a tutti noi che ti vogliamo bene e a papà tuo specialmente che [...] quest’anno o batte i denti o va col soprabito rattoppato, perché quello nuovo ha dovuto versarlo alla cassa del libraio che ti ha fornito i testi dell’obbligo»2.
Con un po’ di esagerazione, nel maggio 1925, Luigi Credaro denunciò in Senato le «centinaia di milioni che è costata la riforma degli studi alle famiglie italiane». Secondo la stima offerta dallo stesso ministero della Pubblica istruzione, la spesa per i testi dei corsi elementari aumentò in soli tre anni da 22 a 60 milioni3. Solo in parte si trattava di una novità. Per quanto riguardava l’editoria del settore, i limiti di compatibilità tra libero mercato e interesse generale erano apparsi evidenti già all’indomani dell’Unità. Il costo dei libri non aveva certo favorito la frequenza scolastica, finendo col vanificare i vantaggi della sua gratuità sul processo di alfabetizzazione e di nazionalizzazione4. Era stata tuttavia proprio tale gratuità a rendere tollerabile questo stato di cose: in Italia, a differenza degli altri paesi europei, i testi costituivano veramente l’unica spesa per accedere agli studi primari, e di fatto anche a quelli medi, dove le tasse d’iscrizione erano irrilevanti.
Ma a partire dalla riforma Gentile la portata e l’impatto della questione si accentuarono, assumendo i termini di un’emergenza sociale. La lotta contro l’analfabetismo, indicata come una delle priorità del primo governo Mussolini, insieme all’innalzamento dell’obbligo a 14 anni, approfondirono le contraddizioni e la distanza tra legge e realtà. La stessa Associazione degli editori fu costretta a riconoscere che nel caso dell’istruzione primaria i prezzi dei testi erano diventati «un problema di interesse generale». Nel complesso tutto il convulso processo di adeguamento dei libri di testo, tanto radicale quanto repentino, assunse agli occhi di molti i contorni di una vera e propria speculazione5.
Gentile e i suoi collaboratori erano del resto ben consapevoli che «riformare i programmi è inutile senza riformare [...] gli editori, o meglio la produzione dei libri». Nella scuola media l’insegnamento fu incentrato sulla lettura delle opere in edizione integrale o quasi, e l’elenco degli autori registrò modifiche sostanziali, in base alla rilettura della tradizione nazionale compiuta dal neoidealismo. Anche i programmi di Giuseppe Lombardo Radice, direttore generale dell’istruzione primaria durante il ministero gentiliano, resero inservibili molti dei testi in uso, di cui da tempo si lamentava il livello assai basso; la rivalutazione della cultura regionale comportò inoltre l’introduzione di nuove tipologie di testi come l’almanacco regionale, il manuale di traduzione dal dialetto e il canzoniere.
Le commissioni per l’approvazione dei testi per l’istruzione primaria riuscirono a regolamentare per la prima volta il settore che, con «la bellezza di quattro milioni di clienti obbligati, irreggimentati da più che novantamila maestri elementari», costituiva il «campo ricco dell’industria libraria»6. Ma il numero dei libri previsti dalla riforma apparve subito eccessivo: alla Camera il deputato popolare Antonino Anile ironizzò sul fatto che ogni alunno avrebbe dovuto leggere 550 pagine in terza elementare, 900 in quarta, 1000 in quinta7. La libertà d’insegnamento, riaffermata in entrambi gli ordini, rafforzava inoltre la funzione dei libri di testo e l’autonomia di scelta da parte degli insegnanti, da cui derivò un ulteriore aumento dei titoli in commercio. Di fatto la moltiplicazione dei testi innescata dalla riforma Gentile vanificò i continui sforzi rivendicati dall’Associazione degli editori per tenere bassi i prezzi.
Il ricambio della produzione scolastica ebbe l’effetto di riaprire la lotta per la spartizione del mercato. Antonio Vallardi, allora presidente di quell’associazione, ricordò anni dopo che l’avventura dello scolastico apparve improvvisamente seducente a molti editori che fino ad allora se ne erano tenuti lontani8. La speranza in «chi sa quali straordinari e fantastici guadagni» fu «tale e tanta da far nascere, e anzi pullulare vertiginosamente serie di nuove ‘collane’ di libri di testo», scrisse Luigi Ventura, professore di liceo e tra i più importanti animatori della «Rivista pedagogica». Nei carteggi degli editori si trovano molte testimonianze di una concorrenza che un’autrice di casa Bemporad non esitò a definire «spietata». In privato Vallecchi si lamentò spesso dell’aggressività delle altre case editrici, «attaccate come piovre alla scuola»9. Colpiscono, nel linguaggio usato, le parole e le metafore belliche – lotta, combattere, battaglia –, comuni nella società del dopoguerra, ma comunque indicative dell’asprezza del confronto cui obbligava il mercato. Le campagne scolastiche si rivelarono infatti delle corse sul tempo, visti anche i ristretti margini concessi per preparare i testi.
Che la riforma Gentile avesse inaugurato un periodo d’oro per l’editoria scolastica è provato dal numero di uomini e di donne di scuola che furono incoraggiati a cercarvi un’occupazione fissa. Era il caso, tra i più noti, di Vincenzina Battistelli, insegnante, libero docente di pedagogia e collaboratrice dell’«Educazione nazionale» di Lombardo Radice: «le condizioni che mi fa Bemporad sono tali da permettermi di lasciare la scuola», scrisse a Codignola nel 1924. Un’altra ispettrice e autrice destinata a divenir famosa, Oronzina Quercia Tanzarella, si compiaceva per il fatto che i suoi fortunati corsi per la scuola elementare pubblicati da Mondadori le avrebbero consentito di lasciare l’impiego al ministero; anche se il vantaggio che l’una attività sembrava trarre dall’altra la convinse a non compiere questo passo10. Molti erano anche gli scrittori e i giornalisti affermati a non disdegnare un impegno collaterale prodigo di soddisfazioni economiche. Giovanni Capodivacca detto Gian Capo, ex collaboratore di Vamba al «Giornalino della domenica», dal 1927 direttore del «Secolo», si affermò come uno degli autori di punta di casa Bemporad. Erano del resto da capogiro i compensi accordati anche da Mondadori a scrittori di richiamo prestati allo scolastico come Virgilio Brocchi. «Evviva dunque i pedagoghi e i pedagogisti! Speriamo che ti facciano guadagnare un po’ più dei letterati», scriveva nel 1925 Giovanni Papini a Vallecchi, non senza una punta di risentito snobismo11.
Posta la questione in questi termini il carolibri, che si riapriva all’inizio di ogni anno scolastico, tendeva ad apparire come una responsabilità in larga parte imputabile all’affarismo degli editori. Era diffusa e radicata l’idea che il problema dei prezzi dipendesse esclusivamente dalla loro «buona volontà», tanto che «se non più di otto (diciamo otto) editori di libri scolastici – i maggiori, ben s’intende – si riunissero intorno ad un tavolino [...] molte delle piaghe che affliggono questo speciale ramo dell’editoria sarebbero facilmente sanate». Già nel dicembre del 1923 Giuseppe Prezzolini si era sentito in dovere di intervenire in loro difesa sul «Corriere mercantile», sottolineando che le proteste dei padri di famiglia erano dovute, più che altro, «all’antipatia inveterata del nostro bel Paese per il libro»12.
La strategia difensiva degli editori oscillò, non senza contraddizioni, tra il rivendicare il carattere particolare della produzione scolastica, assurta a una «delicatissima funzione morale», e il ricordare le necessità che la accomunavano a tutte le altre industrie. In mezzo a difficoltà imparagonabili a quelle di qualsiasi altra – puntualizzava Vallardi – era la sola attività economica a conciliare «l’equo frutto del capitalismo con gli interessi del pubblico e dell’economia nazionale»13. I «più poveri» degli industriali rinfacciarono più volte il loro spirito di sacrificio, che fu pubblicamente riconosciuto anche dagli artefici della riforma: intervenendo nel novembre 1926 all’assemblea romana dell’Aeli, in cui non si mancò di accennare alle difficoltà dell’editoria scolastica, l’ex ministro Gentile confessò di sentirsi parte in causa14. Lombardo Radice, nel 1925, parlò dello sforzo compiuto da questa «gagliarda razza di industriali»: era un «piccolo miracolo» se «così grande rimescolio di interessi, in un paese sospettoso e scandalofilo come il nostro, si poté dominare senza polemiche, senza clamori»15.
Le opinioni degli editori sulle cause del carolibri divergevano significativamente da quelle agitate con demagogica periodicità dalla stampa. «Il prezzo dei libri! – esclamò Franco Ciarlantini in un’intervista rilasciata alla ‘Voce di Bergamo’ – Ecco una questione sulla quale si fanno troppe chiacchiere con poca conoscenza della verità». In effetti, il prezzo dei singoli testi, che risultava inferiore a quello degli altri paesi, non era rincarato al pari del costo della vita e del costo di produzione, come documentavano gli stessi studi statistici di Giuseppe Fumagalli, più volte richiamati dal «Giornale della libreria»16.
I modesti aumenti verificatisi dopo l’abolizione del controllo dei prezzi, nel novembre 1922, costituivano per gli editori la migliore riprova della responsabilità della categoria e della capacità di a...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. Riforma Gentile e riforma dell’editoria
- 2. Libera iniziativa, mercato protetto
- 3. Crisi e razionalizzazione editoriale
- 4. Bonifica imperiale e unificazione del mercato
- 5. I limiti della defascistizzazione
- Note