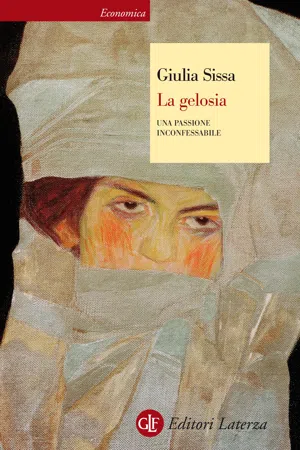Capitolo I.
Medea sono io!
Gli Antichi conoscevano molto bene – ed è dir poco – l’esperienza di perdita e di fitta dolorosa, di umiliazione e di violenza, causata dalla volubilità sessuale di una persona molto amata: una defezione che ci mette, nostro malgrado, in una condizione di rivalità e, in definitiva, di sconfitta. Questa reazione appassionata era uno dei motori narrativi più potenti. Solo che, per ritrovare «le parole e la cosa», non dobbiamo cercare tra i termini che potremmo tradurre con «gelosia». Il problema non è di tradurre, bensì di comprendere. Occorre immergersi nei racconti, nei poemi, nelle opere teatrali e nelle teorie amorose, in Grecia come a Roma. Bisogna riconoscere la foga agonistica della passione d’amore, certo, ma soprattutto la sua coerenza affettiva e narcisistica in tutti quei testi che la menzionano, la tratteggiano e l’analizzano. Si scopre, allora, che in Grecia la gelosia, quella seria, non è nient’altro che collera. Una collera in cui eros, l’amore sensuale, ha un ruolo cruciale. Una collera erotica.
Aristotele, come spesso accade, fa il miglior lavoro di interpretazione culturale. Egli mette a punto una definizione illuminante della collera. Orghé è la percezione di una offesa ingiustificata, che fa soffrire ma di cui si progetta la vendetta. È un dolore profondo, perché la ferita nell’amor proprio che ci viene inflitta ci abbassa al livello di esseri trascurabili, che valgono poco o nulla. Ed è anche un piacere, perché si reagisce nella speranza di rendere pan per focaccia. Passiva e attiva, dolorosa e gradevole, negativa e positiva, questa passione all’apparenza impetuosa esige, di fatto, una concatenazione complessa e drammatica di pensieri e di risposte. È una passione razionale e, soprattutto, nobile. Se è vero che gli individui irascibili esagerano, per Aristotele le persone che non si offendono mai meritano un rimprovero sferzante: non danno prova di un carattere placido, ma di un’attitudine servile. Questa definizione spiega i grandi furori che vediamo esplodere nella poesia greca.
Pensiamo all’Iliade, il grande poema arcaico: l’azione inizia nel momento in cui Achille, il più valoroso dei Greci, si vede sottrarre dal re Agamennone una donna che aveva fatto prigioniera. Achille si arrabbia. La sua menis (altro termine per designare l’ira) è la prima parola del poema. Ed è l’oggetto del racconto. Ora, l’Iliade non è sicuramente un romanzo d’appendice, ma non per questo la carica erotica di quella collera è meno significativa. È un punto d’onore, certo. Una ripicca. Ma il contesto guerriero, aristocratico e competitivo che rende intollerabile questo tipo di offesa non annulla la tonalità soggettiva di questo dolore. La giovane Briseide non è certo un’amante vezzeggiata, evocata con un linguaggio pieno di sentimento e idealità, ma non è nemmeno un tripode di bronzo. Achille soffre perché ama davvero quella giovane donna. È una sposa cara al suo cuore, dice. La ama (philéin), appassionatamente, con il suo thymós1, cioè con la componente affettiva della sua personalità. Ma il thymós è anche la molla che fa scattare sia il coraggio che l’ira.
L’Iliade ci offre il primo esempio della passione che si scatena dopo una delusione d’amore. Nel V secolo, la tragedia ateniese mette in campo tutta una gamma di scenari e di sfumature. Sulla scena tragica incontriamo Deianira, la moglie di Eracle, che, turbata dal ritorno dello sposo in compagnia di una giovane prigioniera con la quale si pensava che condividesse il letto, offre al suo uomo un filtro d’amore che, alla fine, lo ucciderà. Vediamo Clitennestra, sposa di Agamennone, ritrovarsi in una situazione analoga e, con un senso di dispetto reso più forte dal suo risentimento di madre per il sacrificio della figlia Ifigenia, tendere al suo uomo un tranello fatale. E soprattutto conosciamo Medea, la divina principessa della Colchide, che massacra i propri figli nati dal matrimonio con Giasone, l’uomo adorato che voleva abbandonarla per un’altra.
Tutte queste donne si vantano – direbbe La Rochefoucauld – di proclamare la propria dignità erotica sotto forma, per l’appunto, di collera. Una varietà di parole – thymós, cholos, orghé – esprime la rabbia provocata dalla fierezza ingannata. Achille è in collera, Clitennestra e Medea sono in collera. Il carattere erotico dell’oltraggio non modifica in nulla la struttura della passione. La collera d’amore corrisponde a quello che i Greci intendevano con «collera»: il sentimento di aver ricevuto un affronto, letteralmente un atto che ci diminuisce, ci sminuisce, ci rimpicciolisce (oligoría). È ingiusto, perché disattende un’aspettativa di rispetto. È ingiustificato, perché annulla uno scambio. È, soprattutto, un affronto che fa male, ma che ci fa bruciare dalla voglia di riparare. E la riparazione sarà mirata. Si soffre? Bene, allora si farà soffrire. In amore come in guerra, cioè in modo valoroso e scaltro.
Nella tragedia, dunque, una moglie che si vede sostituita nel letto coniugale da un’amante o da un’altra sposa riceve un’offesa che non sopporta e che vuole sanare. Di qui l’abbattimento, la prostrazione, il crollo, ma anche la lucidità, la sagacia e la determinazione ad agire. Detto alla greca, insomma, la rabbia. Davanti a uomini che non esitano a fare i propri comodi, queste donne raccolgono la sfida: per cominciare, gridano alto e forte che non è giusto. Perché, dicono, una cosa che le colpisce nel luogo deputato all’amore erotico – il talamo in cui si consuma il matrimonio, il letto stesso dove si svolgono le tenzoni d’amore – è una ingiustizia bella e buona2. Perché c’è, nel cuore del loro eros, un’aspettativa di gratitudine. Queste donne possono rivelarsi pericolose – senza con ciò voler ergere a modelli donne assassine. Su questo punto il coro, nelle tragedie, è formale: l’assassinio (volontario o involontario, del marito infedele o dei figli innocenti) non è cosa buona3. Ma queste donne non hanno da sfidare l’interdetto della gelosia né, soprattutto, l’imperativo di tacere. Non hanno vergogna della loro tristezza profonda. Soprattutto, non si fanno scrupolo di confessarla. Soffrono; e se ne vantano.
Medea, ovvero la più grande delle donne gelose
In questo quadro, ammettere la sofferenza non è cosa ignobile. Tutt’altro. Così, la più grande delle donne gelose, Medea, la rivendica e se ne compiace: «La pena è mia, di altre non ho bisogno»4. Sì, perché dire i propri tormenti significa denunciare l’oltraggio, la mortificazione, l’ingiustizia – per reclamare il riconoscimento da parte dell’altro. È necessario sciorinare tutto l’elenco dei danni subìti – a cominciare dal corpo disfatto, dal viso emaciato, «afflitto»5; poi la sensazione bruta, espressa in grida inarticolate; infine le frasi che spiegano, in dettaglio, cosa succede, cosa tutto ciò provoca – per dare la misura dell’esperienza vissuta, in tempo reale. Medea urla. «Disgrazia! Sconvolta, annientata dai dolori. Disgrazia per me, per me! Come morire?». Tutti sentono la sua voce (phoné) e il suo grido (boá) e il suo canto (mélpein)6. Il teatro di Dioniso avrà risuonato dei suoi ió! Aiái!.
Medea non prova vergogna. È scossa da tante passioni: la paura, l’amore (eros), la tenerezza materna. Tra tutte queste passioni non v’è la minima traccia di vergogna e, ancor meno, della «vergogna di confessare». La massima di La Rochefoucauld non avrebbe alcun senso per lei. Nella lingua dei sentimenti della Grecia antica, la vergogna (aischýne) è una afflizione causata da «mali» – cioè da azioni e vizi come la viltà, l’adulazione, la mollezza, l’avarizia – che comportano disonore7. Medea non ha fatto nulla di simile. Al contrario, il suo ruolo è quello della vittima innocente, fiera del proprio dolore. È la sua parola che fa avanzare il dramma, perché quello che lei ne dice conferisce peso all’atto di Giasone. È dalle sue parole che emerge la gravità di quell’atto, la sua imperdonabile gratuità, il suo impatto doloroso e infine i motivi per reagire. Ecco quello che ho subìto, ed ecco le conseguenze! Non ha nulla da rimproverarsi Medea, se non di aver troppo amato il marito. Il biasimo è tutto per Giasone. Lei non manca di sbatterglielo in faccia senza reticenze8. Tutto quello che Medea prova diventa discorso.
Nessun silenzio imbarazzato, dunque; al contrario, un’esplosione di collera. Medea si lamenta di «mal sopportare» molte cose: la rottura del «contratto» da parte di Giasone, che rinnega promesse e giuramenti; il fatto che questi si è dimenticato del grande atto di fiducia simbolizzato dal gesto rituale della stretta di mano; l’ingratitudine di un uomo che, dopo tutto quello che lei ha fatto per aiutarlo, la gratifica con questa bella ricompensa. Giasone, insomma, ha disatteso più impegni: il giuramento e la promessa, la gratitudine e la reciprocità. Giasone si è tirato indietro. Tutto ciò ha a che fare sia con la delusione amorosa sia con la disintegrazione sociale: Giasone è colpevole di una violazione che va a toccare le profondità più intime della sensualità e dell’amore9, e disonora Medea agli occhi del mondo10. La giustizia del letto è stata cancellata. La rivendicazione di Medea, pertanto, ha un contenuto morale e sociale che va al di là di un evento solo affettivo e sessuale. Sono in gioco giustizia, onore e amore carnale, tutto insieme.
Osservato attraverso la lente aristotelica, questo scena...