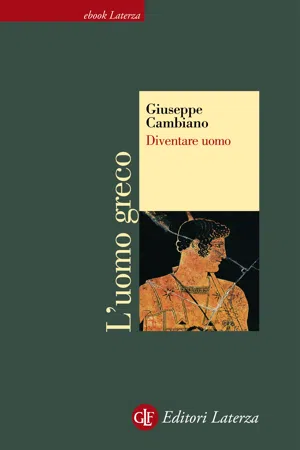Diventare uomo
«Qual è l’essere dall’unica voce che ha due, quattro, tre piedi?» Con la risposta «l’uomo» Edipo aveva risolto l’indovinello della Sfinge. Il mutare dei modi di locomozione appariva contrassegno evidente delle tre tappe cruciali della vita umana: l’infanzia, la maturità e la vecchiaia. La statura eretta, che molti filosofi da Platone e Aristotele in poi avrebbero considerato un tratto distintivo essenziale tra l’uomo e gli altri animali, segnava anche il primato dell’uomo adulto e la distanza che il neonato, così vicino alla situazione animale del quadrupede, doveva percorrere per diventare realmente uomo. Naturalmente la prima condizione era sopravvivere, sfuggendo alla mortalità, non infrequente nella Grecia antica, per parti prematuri o irregolari e poi a malattie derivanti anche da alimentazione inadeguata o cattiva igiene, alle quali si aggiungeva l’impotenza terapeutica di buona parte della medicina antica. A Eretria, tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C., la distanza tra il bambino e l’adulto era anche sottolineata dal fatto che fin verso i sedici anni i defunti erano sepolti in tombe a inumazione, mentre gli adulti erano incinerati, sottoposti dunque a un processo che sanciva il loro passaggio dalla natura alla cultura.
Ma non era soltanto la natura a operare come selettore di sopravvivenza. Nascere in buone condizioni fisiche consentiva di sfuggire all’eliminazione, alla quale non si esitava a ricorrere in casi di deformità, percepiti dai genitori e dall’intera comunità come una sorta di punizione divina di cattivo auspicio. A Sparta la decisione di far vivere il neonato era riservata ai membri più anziani della tribù (phylè) di appartenenza del padre. Il neonato che appariva deforme o gracile poteva essere abbandonato presso il Taigeto. Ad Atene e in altre città si ricorreva al metodo dell’esposizione del neonato, in un vaso di coccio o altro recipiente, lontano dalla casa, sovente in luoghi incolti, fuori città, dove poteva morire di fame o dilaniato dalle fiere, se non veniva raccolto da qualcuno. Non erano soltanto bimbi deformi a essere esposti, ma anche talvolta neonati in buone condizioni fisiche. Gli spettatori delle rappresentazioni tragiche o delle commedie di Menandro non raramente potevano vedere sulla scena casi di bimbi esposti e poi ritrovati: lo stesso Edipo aveva subito questa sorte. Per limitare le nascite Aristotele avrebbe preferito l’aborto all’esposizione, ma avrebbe ribadito la necessità di una legge che proibisse di allevare figli deformi. Ad Atene la decisione di esporre il figlio competeva al padre, mentre nella città cretese di Gortina si prevedeva che una donna di condizione libera, se aveva un figlio dopo il divorzio, dovesse portarlo, in presenza di testimoni, alla casa dell’ex marito; se questi lo rifiutava, diventava di sua pertinenza la decisione se esporlo o allevarlo. Anticamente ad Atene il padre avrebbe avuto il diritto di vendere i propri figli per sanare i suoi debiti. Questa pratica sarebbe stata vietata da Solone e l’esposizione sarebbe diventata uno strumento alternativo soprattutto per i più poveri. Nella Perikeiromene di Menandro un padre raccontava di aver esposto il figlio e la figlia, nel momento in cui la moglie era morta di parto ed egli si era trovato improvvisamente povero per l’affondamento di un carico nell’Egeo.
Non esistono dati numerici sicuri, ma è possibile che la maggior parte dei bambini esposti fossero illegittimi, più che legittimi in soprannumero, ossia bastardi nati da genitori di nazionalità mista o fuori da un matrimonio regolare, in particolare figli di schiave. È difficile, anche tra i poveri, che l’esposizione riguardasse il primo figlio legittimo maschio, mentre maggiore dovette essere l’esposizione di neonati di sesso femminile. Non si deve dimenticare che in Atene le figlie per trovare uno sposo dovevano ricevere una dote, diversamente da quanto avveniva nelle rappresentazioni omeriche e tra le famiglie aristocratiche dell’età arcaica, dove era il futuro sposo a offrire doni al padre della sposa. L’esposizione era anche un modo per evitare un eccesso di nubili, che avrebbero continuato a gravare economicamente sulle spalle del padre. Soprattutto in età ellenistica, con l’aumento della denatalità, alla quale Polibio avrebbe attribuito la decadenza della Grecia, e con una famiglia tipo costituita da un solo figlio, l’esposizione delle femmine avrebbe assunto maggiori dimensioni. Verso il 270 a.C. il poeta Posidippo affermava: «Ognuno, anche se povero, alleva un figlio maschio; una figlia, anche se ricco, la espone».
Il bambino esposto poteva essere raccolto da altri, che avevano facoltà di trattarlo da libero o da schiavo; trattarlo come libero non significava però adottarlo come figlio. Nel diritto attico l’adozione era una transazione fra l’adottante e il padre o il tutore dell’adottato, solitamente allo scopo di garantirsi un erede maschio. La pratica più diffusa probabilmente riduceva l’esposto in condizione di schiavitù, per tenerlo al proprio servizio – in caso di femmine, anche per avviarle alla prostituzione – oppure per venderlo al tempo opportuno. Eliano menziona una legge di Tebe che avrebbe vietato ai cittadini di esporre i propri figli, prescrivendo ai padri poveri di portare il neonato, maschio o femmina, dai magistrati, i quali lo avrebbero affidato a chi fosse disposto a sborsare una somma minima stabilita. A compenso delle spese di allevamento l’acquirente avrebbe poi potuto utilizzarlo come schiavo.
Nella Grecia antica diventare uomo non equivaleva semplicemente a diventare adulto. La condizione dei genitori era essenziale per decidere chi poteva e chi non poteva diventare veramente uomo. Non solo le aristocrazie, ma anche le democrazie greche poggiavano su una chiusura numerica del corpo civico in cui il criterio d’inclusione era la nascita. In Atene ciò era stato sanzionato da una legge proposta da Pericle nel 451-50 a.C., secondo cui solo chi era figlio di genitori entrambi ateniesi poteva godere del diritto di cittadinanza; una legge ristabilita nel 403-402, dopo un periodo di allentamento durante la guerra del Peloponneso. Già Adam Smith fece dipendere le restrizioni ateniesi nel concedere il diritto di cittadinanza dall’esigenza di non ridurre le quote dei vantaggi economici derivanti dai tributi che Atene ricavava da altre città. Ovviamente anche gli schiavi avevano genitori, ma non avevano diritto a una parentela riconosciuta. In gran parte essi provenivano da paesi barbari, ma era possibile che anche liberi di origine greca diventassero schiavi. La guerra soprattutto poteva essere fonte di asservimento: la pratica diffusa, nelle città conquistate, era di uccidere i maschi adulti e di rendere schiavi donne e bambini. Così durante la guerra del Peloponneso aveva fatto Atene con gli abitanti di Mitilene, di Torone, di Scione e di Melo. A volte la conclusione di accordi di pace prevedeva la restituzione dei bambini resi schiavi. Ma l’invito di Platone o Isocrate ai Greci a non asservire altri Greci conferma che questa pratica non era scomparsa nel IV secolo a.C. Già in secoli precedenti bambini e ragazzi di bell’aspetto delle città ioniche conquistate dai Persiani avevano la prospettiva di diventare eunuchi. Erodoto raccontava di Periandro, tiranno di Corinto, che per vendetta aveva inviato a Sardi da Aliatte 300 ragazzi, figli dei primi cittadini di Corcira, per essere evirati. Ma in una tappa del viaggio, a Samo, questi erano stati salvati dagli abitanti dell’isola e ricondotti in patria. Sorte meno felice doveva toccare ai fanciulli che cadevano nelle mani del mercante di schiavi Panionio di Chio, di cui sempre Erodoto racconta che procedeva a evirarli personalmente, per portarli poi a Sardi o Efeso e venderli ai barbari a caro prezzo.
Nelle città greche essere schiavi significava essere esclusi dalla partecipazione alla vita politica, da molti diritti civili e da buona parte delle feste religiose della città, ma anche dalle palestre e dai ginnasi, nei quali avveniva l’educazione dei futuri giovani cittadini. Diventare adulto non comportava per uno schiavo un salto qualitativo né una preparazione graduale, come avveniva per i figli dei cittadini liberi. Se l’aggettivo andràpodon, uomo piede, usato per designare lo schiavo, tendeva ad assimilarlo alla condizione dei quadrupedi, tetràpoda, il termine pais, con cui era frequentamente chiamato, sottolineava la perenne condizione di minorità dello schiavo. Come dice Aristofane nelle Vespe, «è giusto chiamare pais chi prende percosse, anche se è vecchio». Ad Atene si potevano legittimamente impartire pene corporali soltanto a schiavi e bambini, non a adulti liberi. Forse solo gli schiavi pedagoghi, che accompagnavano i figli del padrone dal maestro, potevano indirettamente apprendere a leggere e scrivere, assistendo alle lezioni. Ma in linea di massima l’unica istruzione che uno schiavo poteva ricevere era legata al tipo di lavoro e di servizio che egli svolgeva per il padrone, in una gamma che andava dai meno duri servizi domestici al lavoro durissimo nelle miniere, riservato esclusivamente agli schiavi e in cui anche bambini erano impegnati, non solo nelle miniere della Nubia, di cui racconta Diodoro Siculo, ma anche in quelle ateniesi del Laurio. Aristotele menziona un ...