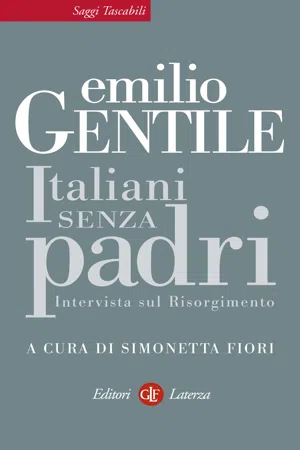Perché abbiamo un cattivo rapporto con le nostre origini
D. Quando è cominciata la «morte della patria» e dunque la dispersione dell’eredità risorgimentale? Alcuni studiosi, Renzo De Felice ed Ernesto Galli della Loggia, l’hanno collocata nel 1943, nella catastrofe segnata dall’8 settembre.
R. È una formula molto efficace, di grande impatto emotivo, per descrivere lo stato d’animo di molti italiani dopo lo sfascio dello Stato nazionale, ma non può essere una categoria interpretativa per studiare il rapporto tra gli italiani e lo Stato nazionale. Io sono persuaso che il declino dell’idea di una patria comune degli italiani sia iniziato molto prima, durante il fascismo, e ancor prima con il processo di «ideologizzazione della nazione», accaduto in Italia nel decennio tra il 1912 e l’avvento di Mussolini: la patria cessa d’essere ciò che era stata nell’aspirazione nazionale del Risorgimento e dell’Italia liberale – ossia una patria comune per tutti gli italiani indipendentemente dalle loro convinzioni religiose o politiche – per divenire monopolio solo di uno specifico movimento contro gli altri. Nel decennio che precede la Grande Guerra assistiamo a un confronto sempre più serrato tra vecchi e nuovi credenti del mito della nazione, ciascuno dei quali propone un proprio ideale di nazione e di Stato condannando quello degli altri come falsa espressione della nazione o addirittura «antinazione»: una costante che si ripeterà nella storia d’Italia e che allora culminò nella violenta contrapposizione fra neutralisti e interventisti, nel «biennio rosso» e poi nella vittoria del fascismo. La «ideologizzazione della nazione», ossia la pretesa di una parte degli italiani di incarnare la vera Italia – pretesa diffusa in tutti gli schieramenti, nell’Italia cattolica, nell’Italia socialista, nell’Italia imperialista – rappresentò la prima vera rottura dell’eredità risorgimentale, completata dal fascismo che pretese di avere il monopolio del patriottismo, dando l’ostracismo a tutti coloro che non riconoscevano e non si piegavano ad accettare l’identificazione della patria con il regime di Mussolini.
D. Lei sta dicendo che l’8 settembre non fu la causa della morte della patria, ma rivelò una frattura già presente nella coscienza degli italiani...
R. ...almeno fin da quando Mussolini giunto al potere stabilì che si era veri italiani e veri patrioti solo se si era fascisti. Non bisogna dimenticare che, fin dall’inizio della seconda guerra mondiale, gli italiani antifascisti – trattati dal fascismo come nemici della nazione, costretti all’esilio fuori d’Italia o in una sorta di esilio interiore – furono indotti a invocare la sconfitta della loro patria in guerra pur di liberarla dalla dittatura fascista. E particolarmente dolorosa fu la lacerazione che questa scelta comportò per gli antifascisti educati secondo l’etica risorgimentale a porre la salute della patria al di sopra di tutto. Il diario di Benedetto Croce ne è una dolorosa testimonianza. «A guerra dichiarata e irrevocabile», disse il filosofo al primo Congresso dei partiti antifascisti tenuto a Bari il 28 gennaio 1944, «un più terribile travaglio fu vissuto da noi nei nostri petti; perché una severa educazione civile ci aveva reso assiomatico il principio che, quando si ode il primo colpo di cannone, un popolo deve far tacere i suoi contrasti e fondersi in unica volontà per la difesa e la vittoria della patria, la quale, abbia essa ragione o torto, è la patria. E a questo principio solenne noi riluttavamo ad obbedire, e la riluttanza non era di ribelle passionalità, ma di una voce interiore, di un senso di verità che ci faceva avvertire che l’osservanza dell’antica massima sarebbe stata questa volta un impossibile sforzo, una brutta ipocrisia verso noi stessi». Il travaglio interiore condiviso allora da molti antifascisti documenta bene la lacerazione della patria che precede non di poco lo sfascio della nazione dopo l’armistizio.
D. Nella Grande Italia lei ritrae un’Italia affamata e disperata, «in fuga dalla storia», tra il 1943 e il 1944.
R. Le testimonianze di personalità diverse per ispirazione culturale e politica ci restituiscono concordemente una nazione in frantumi, una terra di nessuno dove infierivano la guerra tra eserciti stranieri e la guerra civile tra gli italiani, che combattevano in nome di due Stati e due Italie. All’indomani dell’8 settembre Pietro Nenni scriveva: «Le giornate di ieri e di oggi segnano il crollo di ciò che restava dell’organizzazione dello Stato dopo il 25 luglio». Croce si tormentava col pensiero che «tutto quanto le generazioni italiane avevano da un secolo in qua costruito politicamente, economicamente e moralmente è distrutto irrimediabilmente». E ancora, nel settembre del 1946, scriverà: «Vedere la distruzione dell’Italia che gli uomini del Risorgimento avevano creata e nella quale noi ci eravamo educati, crescendo con essa, è cosa alla quale non riesco a rassegnarmi». Stesse inquietudini in un uomo come Ugo La Malfa, il quale annotava: «L’Italia come grande Stato nazionale ereditato dal Risorgimento è stata distrutta». Il crollo dello Stato unitario mandò in frantumi l’identità nazionale. Fino agli accenti biblici di Salvatore Satta, che nel suo De profundis tramandò la «visione sconsolata di un’Italia che muore». «La morte della patria», scrive Satta, «è certamente l’avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita dell’individuo».
D. Il giurista sardo non poteva certo immaginare che alla fine del secolo la storiografia italiana avrebbe dibattuto furiosamente sulla morte della patria.
R. Sì, la formula fu ripresa in sede storica da Renzo De Felice in Rosso e nero, un dialogo con Pasquale Chessa uscito nel 1995. Lo storico vi faceva ricorso per restituire il significato del disfacimento della nazione dopo l’8 settembre e dopo una guerra civile che avrebbe lasciato ferite mai risolte nella coscienza collettiva. In realtà ve n’era già un accenno nel volume sulla guerra civile, Mussolini l’alleato, che uscirà postumo a cura mia, di Mario Missori e Luigi Goglia. Nel 1996, Ernesto Galli della Loggia sviluppò il tema in La morte della patria. Ma già nei primi anni di quel decennio la questione era dibattuta. Può essere curioso ricordare che in un convegno triestino su Nazione e nazionalità, nel settembre del 1993, Galli della Loggia e io intervenimmo proprio sull’argomento con due diverse tesi. Io sostenevo appunto che il declino dello Stato nazionale era iniziato con il fascismo e per opera del fascismo stesso, fin dal momento in cui il partito milizia si era sovrapposto alla nazione identificando l’italianità con la propria ideologia. Galli della Loggia partì invece dal De profundis di Satta, collocando la morte della patria nel biennio terribile alla fine della guerra. Ma da questa diversità di interpretazioni non scaturì allora alcun dibattito. A questo proposito vorrei però precisare che la mia interpretazione non era influenzata dai nuovi movimenti leghisti né dalla cosiddetta «fine della Prima Repubblica», ma risaliva a oltre un decennio addietro.
D. Al suo lavoro Il mito dello Stato nuovo?
R. Già nel 1982, in quel libro, osservavo che la disfatta dell’Italia nella seconda guerra mondiale aveva scrollato «fino alle fondamenta lo Stato creato dalla rivoluzione del Risorgimento: poiché il fascismo aveva proclamato la guerra anche in nome degli ideali nazionali, la sconfitta non solo distrusse il fascismo ma diede anche un colpo gravissimo al prestigio dell’ideologia nazionale, che era stata alla base dello Stato unitario e ne aveva garantito la legittimità storica». Ciò era accaduto – spiegavo – perché il fascismo, associando la nazione al mito dello Stato totalitario e alla distruzione delle libertà politiche, «aveva inquinato il patrimonio risorgimentale e contribuì alla sua decadenza. L’Italia repubblicana fu creata, in gran parte, da forze politiche e sociali che si ispiravano a valori estranei alla tradizione risorgimentale, e che non si identificavano interamente con lo Stato nazionale, anche se confermarono l’intangibilità dell’unità politica e il rispetto dei valori patriottici». Da questo punto di vista – proseguivo – «la nascita dello Stato repubblicano, dopo la riconquista delle libertà politiche e la restaurazione della democrazia parlamentare, segnò una svolta importante nella storia dell’Italia contemporanea: fu la fine di un’epoca della cultura e della coscienza politica italiane e l’inizio di un periodo nuovo di travagliata vita democratica in cui ‘Stato’ e ‘nazione’ non costituivano più le categorie politiche fondamentali della vita collettiva». Quel mio libro ebbe molte recensioni, ma nessuno prestò allora attenzione alle considerazioni che ho citato e che anticipavano di un decennio le polemiche sulla «morte della patria». Si vede che allora questo tema non inquietava gli intellettuali e gli storici italiani.
D. Più tardi, lei collocherà i prodromi dell’estinzione della patria e dunque dell’eredità risorgimentale nel decennio tra il 1912 e il 1922. Ora però voglio chiederle: ma la fragilità del sentimento patriottico non ha una radice ancora più antica? Non fu lo stesso Mazzini a definire il neonato Stato italiano «menzogna d’Italia»? Non dobbiamo risalire ancora più indietro, ossia alle polemiche sugli esiti risorgimentali immediatamente successive all’Unità?
R. Allora non fu in discussione il Risorgimento, ma il risultato ottenuto da un movimento complesso, che raccoglieva componenti diverse e antagonistiche pur nella condivisione di un comune obiettivo, ossia l’indipendenza e l’unità per costruire una patria degli italiani. Gli italiani si divisero non sulle finalità del movimento nazionale, ma sul modo in cui era stata raggiunta la comune meta e sul modo in cui in concreto era stato realizzato il comune desiderio. Per il liberalismo di Cavour la rigenerazione degli italiani era compito dello Stato monarchico liberale: un’operazione lunga e laboriosa, da condurre attraverso un processo graduale. Per la democrazia repubblicana di Mazzini, la rigenerazione degli italiani doveva essere opera degli stessi italiani, doveva essere il risultato di un’iniziativa rivoluzionaria del popolo che animato dalla fede nella religione della patria rigenerava se stesso attraverso la lotta e anche il martirio. Vinse il Risorgimento di Cavour, che Mazzini liquidava come mera unificazione territoriale conseguita dalla monarchia sabauda con arte machiavellica. Alla nazione italiana così com’era stata realizzata mancava «l’alito fecondatore di Dio».
D. Con Mazzini cominciò quell’idea di un Risorgimento incompiuto che attraverserà anche il secolo successivo.
R. Sì, da Mazzini e dai mazziniani deriva un motivo fondamentale che animerà la contestazione dello Stato liberale e della sua classe dirigente: quella che potremmo compendiare nella formula del Risorgimento tradito o Risorgimento incompiuto. Secondo questo approccio, l’Italia unita era stata cucita insieme da una legislazione autoritaria e centralizzatrice, che sostanzialmente negava il fervore religioso di una nuova italianità consapevole. Secondo Mazzini e i suoi seguaci, in sostanza, era mancata la rigenerazione intellettuale e morale degli italiani, necessaria dopo secoli di servitù.
D. Un Risorgimento senza rigenerazione.
R. Il principio del Risorgimento – l’abbiamo detto anche all’inizio della conversazione – è sempre coniugato con quello della rigenerazione, una parola che ricorre frequentemente negli scritti dei patrioti dell’epoca. L’idea è quella espressa nel 1866 da Massimo d’Azeglio, il quale non scrisse mai – come erroneamente si crede – che «fatta l’Italia bisogna fare gli italiani», ma sosteneva che gli italiani così com’erano fatti erano fatti male, perché frutto di secoli di decadenza, asservimento, corruzione. Bisognava dunque rigenerare gli italiani, cambiarli radicalmente, perché gli italiani erano i primi nemici d’Italia. «L’Italia da circa mezzo secolo s’agita, si travaglia per divenire un sol popolo e farsi nazione. Ha riacquistato il suo territorio in gran parte. La lotta collo straniero è portata a buon porto, ma non è questa la difficoltà maggiore. La maggiore, la vera, quella che mantiene tutto incerto, tutto in forse è la lotta interna. I più pericolosi nemici dell’Italia non sono i Tedeschi, sono gli Italiani. E perché? Per la ragione che gl’Italiani hanno voluto fare un’Italia nuova, e loro rimanere gl’Italiani vecchi di prima, colle dappocaggini e le miserie morali che furono ab antico la loro rovina; perché pensano a riformare l’Italia, e nessuno s’accorge che per riuscirci bisogna, prima, che si riformino loro [...] Il primo bisogno d’Italia è che si formino Italiani che sappiano adempiere al loro dovere, quindi che si formino alti e forti caratteri».
D. Fatta l’unificazione, dunque, fu subito polemica. L’Italia nacque male.
R. Non c’è dubbio, e può far sorridere l’accusa rivolta oggi alla storiografia italiana di non aver fatto una vera storia del Risorgimento cedendo all’apologia e all’agiografia. I primi a raccontarla nelle sue controverse origini e conclusione furono gli stessi patrioti che vi avevano partecipato senza poi riconoscersi nello Stato realizzato con l’unificazione monarchica. Possiamo dire che l’Unità d’Italia fu il risultato di un travaglio lungo e doloroso, che dopo il 1861 non fu affatto accettato pacificamente. L’Italia unita ha dovuto poi lottare per unificarsi moralmente, culturalmente e politicamente: un dramma che ha accompagnato il paese fino ai nostri giorni.
D. Ma fin dal principio si cercò di nascondere queste lacerazioni con la creazione di un’epica nazionale che celebrava il sodalizio armonioso tra i diversi protagonisti del Risorgimento.
R. All’indomani dell’Unità, la classe dirigente del neonato Stato italiano s’impegnò nell’elaborazione di una nuova «religione della patria» che armonizzasse le fratture ideologiche del Risorgimento. Una retorica patriottica imperniata sulla triade di Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele II, contro cui si opponeva la retorica teologica di Mazzini, animato da spirito religioso laico. Per diversi decenni, la sua immagine faticherà a entrare nel nuovo culto nazionale, da qui anche quel tratto polveroso e luttuoso che ne opacizza la figura al cospetto del più solare e popolare Garibaldi. Ma, detto questo, bisogna aggiungere che gli artefici dell’unificazione non ignorarono e non nascosero che questa era avvenuta su basi controverse, e perciò fragili, e che la costruzione materiale e morale dello Stato nazionale, della patria comune, era impresa ardua, che aveva di fronte a sé ostacoli formidabili. Era Francesco De Sanctis – grande figura di patriota risorgimentale, più volte ministro della Pubblica istruzione dopo l’Unità – che nel 1869 scriveva che l’Italia, dopo il Cinquecento, «per più secoli scomparve dalla storia con sì profonda caduta, che anche oggi è dubbio se la sia risorta davvero». Ed era ancora De Sanctis – cultore della religione della patria ma allergico a retorica e agiografia, e tutt’altro che entusiasta del misticismo politico di Mazzini – che nel 1874, facendo lezione sul fondatore della Giovine Italia e sulle correnti democratiche del Risorgimento, commentava: «L’Italia rimane ancora oggi qual era innanzi. Fatta l’unità politica, manca l’unità intellettuale e morale fondata sull’unità religiosa». E concludeva: «L’unità politica è vana cosa senza la redenzione intellettuale e morale; vana cosa è aver formato l’Italia, come disse il d’Azeglio, senza gli Italiani. Questo programma non fu dato a lui, non è dato alla generazione contemporanea di compierlo; rimane affidato alla nuova generazione». E ciò che De Sanctis intendeva dire, quando parlava della rigenerazione intellettuale e morale (riconoscendo a Mazzini la «vera gloria» di esserne stato il precursore), non era una marcia trionfale, ma il camminare, un passo ogni giorno, «nella via della libertà e dell’eguaglianza», «nella via dell’emancipazione religiosa», «nella via dell’educazione nazionale».
D. Nella costruzione di una nuova religione laica, Francesco Crispi fu il più convinto pon...