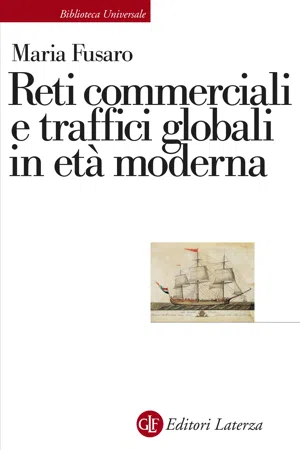
- 186 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Reti commerciali e traffici globali in età moderna
Informazioni su questo libro
Una originale lettura dell'età moderna quale fase d'avvio di una sempre più diretta interazione tra i continenti e che fa dello sviluppo commerciale europeo l'innesco di quel circolo virtuoso che lanciò l'Europa alla conquista di un lungo e indiscusso predominio sul resto del mondo.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Reti commerciali e traffici globali in età moderna di Maria Fusaro in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Geschichte e Moderne Geschichte. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1.
Il commercio internazionale
alla vigilia delle scoperte geografiche
Whosoever commands the sea commands the trade; whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world, and consequently the world itself.
Sir Walter Raleigh, A Discourse of the Invention of Ships, Anchors, Compass, &c. (1615 ca.)
Il commercio di lunga distanza ha una storia lunga e appassionante. Fin dai tempi più remoti alcune merci di grande valore – prime fra tutte le pietre preziose – viaggiavano dall’Asia verso l’Europa, e i grandi imperi dell’antichità crearono tutti una vasta rete di relazioni commerciali che si estendeva sull’intero continente eurasiatico. Per lungo tempo, tuttavia, si era pensato che nel periodo che seguì la caduta dell’impero romano questi commerci fossero scomparsi dall’Europa per riprendere solo con le Crociate. Studi recenti hanno invece rivelato che anche nei secoli dell’alto Medioevo, in cui si riteneva che il commercio fosse limitato a quello di brevissima distanza, quello di lunga distanza non fu mai completamente interrotto e si mantenne anzi piuttosto vitale. Nel Novecento sono stati gli archeologi, più che gli storici, a trasformare radicalmente le nostre conoscenze su quest’argomento. In scavi compiuti nella città vecchia del Cairo sono stati ritrovati numerosi frammenti di ceramiche cinesi a un livello che corrisponde al IX secolo. Sempre grazie all’archeologia, sappiamo ora che la Spagna araba (al-Andalus) era in contatto commerciale diretto con l’Iraq, il quale a sua volta ridistribuiva verso l’Europa prodotti provenienti dall’India e dalla Cina. Nell’Europa del Nord, dove esiste una forte tradizione di scavi archeologici per l’alto Medioevo, è stato anche rivalutato il ruolo svolto dai Vichinghi come commercianti sulle lunghe distanze, sfatando così quell’immagine tradizionale che li descriveva solo come pirati e guerrieri sanguinari.
Michael McCormick ha dimostrato come durante l’alto Medioevo gli scambi di lunga distanza non fossero mai cessati del tutto anche nella parte centrale e mediterranea dell’Europa, evidenziando come soprattutto la conquista carolingia della penisola italiana (774) avesse contribuito all’integrazione dei vari mercati regionali europei. La concessione, da parte dei re franchi, di frequenti esenzioni doganali sui territori da essi controllati è, per McCormick, una ulteriore prova dell’esistenza di un vivace commercio interregionale. All’epoca in Francia si svolgevano già dei grandi mercati periodici dove si incontravano, per concludere affari, mercanti provenienti da diverse regioni europee. Particolarmente frequentata sembra essere stata la fiera di Saint-Denis nella valle della Senna, alla quale affluivano mercanti anglosassoni, frisoni, lombardi, spagnoli, provenzali ed ebrei. Si trattava di una fiera in cui si scambiavano più che altro merci di lusso (incenso, spezie, pellicce, tessuti pregiati, spade, schiavi). Non bisogna dimenticare, infatti, che fino al Cinquecento il commercio sulle lunghe distanze era economicamente efficiente solo per merci di alto valore e, possibilmente, di poco volume.
A partire dal IX secolo anche l’espansione islamica agì come stimolo per il commercio di lunga distanza, con la creazione di un vasto mercato comune che si estendeva dall’Asia centrale alla penisola iberica passando lungo le rive meridionali del Mediterraneo. All’inizio del Novecento, grazie al ritrovamento di una grande quantità di documenti medievali nei magazzini di un’antica sinagoga (Geniza) del Cairo, siamo venuti a conoscenza di come reti di mercanti ebrei e reti di mercanti musulmani fossero particolarmente attive, e collaborassero strettamente, nei commerci che collegavano l’Asia con l’Europa fra il IX e il XII secolo.
La prima fase dell’espansione europea
Negli stessi secoli iniziava anche il movimento delle popolazioni europee verso Occidente. La frontiera dell’Atlantico veniva lentamente spostata verso ovest dalle flotte di pescatori inglesi, francesi e baschi che seguivano i banchi di merluzzi verso le coste dell’Islanda. Anche la produzione della canna da zucchero contribuì ad allargare gli orizzonti commerciali europei: introdotta dagli Arabi nel Sud della Spagna fin dal IX secolo, a partire dal Duecento questa coltura si era estesa a Cipro e in Sicilia dove erano state create grandi piantagioni per la sua coltivazione. Si trattava di veri e propri impianti protoindustriali che utilizzavano schiavi come manodopera. Fra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento, sia i portoghesi che gli spagnoli cominciarono a muoversi verso occidente alla ricerca di nuovi territori adatti alla coltivazione della canna da zucchero. Colonizzando dapprima Capo Verde e le Canarie, poi Madeira, oltrepassarono quelle colonne d’Ercole che fin dall’antichità avevano segnato il confine del mondo conosciuto. Se prendiamo come punto di osservazione il movimento della coltivazione della canna da zucchero, possiamo quindi vedere l’espansione europea come un continuum di lungo periodo, anche se non si può negare il salto di qualità e di quantità che la fine del Quattrocento fece compiere a questo fenomeno.
L’evoluzione del credito, dei contratti commerciali e dell’organizzazione dei traffici
A partire dall’XI secolo il miglioramento della produttività agricola fu alla base di una crescita demografica generalizzata in tutto il continente europeo. Come immediata conseguenza si verificò, fra il XII e il XIII secolo, un risveglio generale della vita urbana che favorì i processi di crescita economica specie nel Centro-Nord della penisola italiana e nelle Fiandre, le quali presto divennero le zone più urbanizzate del continente. Questo risveglio urbano e commerciale è stato definito il «rinascimento del Duecento». Vista la decisa accelerazione degli scambi commerciali in tutta Europa, alcuni storici, fra cui Roberto Lopez, hanno ipotizzato per quest’epoca l’esistenza di una vera e propria rivoluzione commerciale. Senza dubbio in questo periodo ci furono profonde innovazioni in campo finanziario, dal momento che divennero indispensabili nuovi strumenti per far fronte all’accresciuto volume dei traffici e ai problemi che ne derivavano. Il completamento di transazioni economiche che si estendevano in tutta l’Europa richiedeva infatti strutture societarie flessibili in grado di raccogliere sufficiente capitale, consentendo al tempo stesso ai mercanti imprenditori di controllare meglio i rischi e i costi inerenti al commercio su larga scala. Si resero inoltre necessari sia strumenti finanziari sia metodi contabili che rendessero possibile gestire la crescente complessità di queste transazioni.
L’antica societas ereditata dall’impero romano era rimasta da allora il contratto più diffuso. Aveva però un grande inconveniente: tutti i soci condividevano, senza un tetto massimo, la responsabilità per i debiti contratti da ciascuno di essi anche separatamente; si trattava quindi di un tipo di associazione assai rischioso. In questo periodo la societas fu superata dalla creazione di nuove strutture societarie, come la fraterna, la compagnia, il prestito marittimo e, soprattutto, la commenda (o colleganza). Le innovazioni principali contenute in questi nuovi tipi di contratti furono la durata limitata nel tempo e una maggiore distribuzione del rischio fra i partecipanti.
La fraterna, molto in uso a Venezia, consisteva nell’amministrazione comune del patrimonio familiare e della gestione del suo impiego per fini commerciali, da parte di due o più fratelli. La compagnia era invece una sorta di societas più flessibile: la responsabilità restava illimitata per tutti i soci, ma erano limitate sia le somme investite sia la durata dell’associazione, un aspetto che la rendeva poco adatta al commercio marittimo in cui i rischi oggettivi erano altissimi. In questo settore divenne invece piuttosto popolare il cosiddetto prestito marittimo, una sorta di antenato delle assicurazioni da cui venne col tempo infatti soppiantato quando, a partire dal Trecento, il commercio marittimo entrò in una plurisecolare fase di espansione. Il prestito marittimo era un vero e proprio prestito che veniva fornito dall’investitore al mercante per la durata di un singolo viaggio. Aveva la peculiarità di non dover essere ripagato in caso di naufragio o di perdita del carico a causa di un attacco di pirati, e quindi si trattava di un’operazione rischiosa per il prestatore, ma che forniva al mercante una buona protezione verso i pericoli più comuni di questo genere di commercio.
La forma di associazione economica più diffusa divenne però ben presto la commenda (detta anche colleganza), che per secoli ebbe grande fortuna. Era un tipo di contratto molto flessibile che comportava, nella sua definizione più semplice, la creazione di una società per un tempo limitato fra un partner attivo (commendatarius) – di solito un mercante, che viaggiava e conduceva gli affari a nome di entrambi i soci – e uno passivo (commendator), che si limitava a investire capitale in una specifica transazione commerciale in cambio di una percentuale sugli utili, che gli veniva pagata al completamento della transazione. Per il mercante, il vantaggio principale di questo tipo di società era la possibilità di avere a propria disposizione un capitale maggiore con cui operare; per l’investitore, la commenda rappresentava invece l’opportunità di poter investire del capitale senza essere attivamente coinvolto nell’operazione commerciale e inoltre senza incorrere nel peccato di usura. Il rischio insito in questa sorta di investimento, infatti, rendeva i profitti incerti e pertanto accettabili da parte della Chiesa, che per lunghi secoli continuò a considerare come usurari tutti i guadagni ottenuti senza un impegno diretto dell’investitore.
All’inizio del Duecento nelle aziende toscane apparvero i primi esempi di contabilità a partita doppia, che si diffuse rapidamente nel resto dell’Italia e rese molto più semplice la gestione dei libri di conto delle società commerciali. Nello stesso periodo cominciarono a essere assai comuni le lettere di cambio. Il ritorno alla monetazione aurea (Genova e Firenze 1252, Venezia 1285) aveva senza dubbio facilitato il pagamento di grosse cifre, ma i rischi connessi al trasferimento fisico dei metalli preziosi continuavano a rappresentare un serio impedimento al commercio di lunga distanza. L’adozione della lettera di cambio risolse questi problemi e rimase per secoli il modo più efficiente di trasferire capitali senza dover muovere fisicamente il denaro. Tramite una lettera di cambio il contraente riceveva dal socio denaro in valuta locale e prometteva di ripagarlo, alla scadenza prefissata, in un’altra valuta e in un altro luogo, di solito a una delle fiere che a intervalli regolari si svolgevano in giro per l’Europa e che funzionavano da camere di compensazione del mercato internazionale del credito. Oltre a consentire il movimento di capitali fra i vari centri commerciali europei, la lettera di cambio divenne presto anche un sofisticato strumento speculativo poiché favoriva un’espansione del credito e al tempo stesso consentiva di nascondere dietro il rapporto di cambio fra le due valute l’esistenza di un vero e proprio interesse sul prestito, ancora una volta in modo da non incorrere nel peccato di usura.
Nel Duecento i mercanti di alcune fra le principali città del Nord Europa si associarono nella cosiddetta «Hansa dei mercanti» per coordinare più efficacemente i propri commerci nel Mar Baltico e nel Mare del Nord; questa associazione fra mercanti si trasformerà poi alla metà del Trecento in una vera e propria associazione di città, la Lega Anseatica (Hanse). All’inizio dello stesso secolo Venezia avviò il collegamento regolare, tramite flotte mercantili appaltate dal governo e gestite da imprenditori privati, con gli empori orientali di Costantinopoli, Cipro, Alessandria d’Egitto e con la Siria. Alla fine del Duecento Genova istituì un sistema simile che la collegava direttamente con le Fiandre e con l’Inghilterra e, poco dopo, anche Venezia seguì il suo esempio sulle medesime rotte. Nel Trecento cominciò ad aumentare la quantità del commercio su lunga distanza che si svolgeva sul mare, un fenomeno che si rafforzò nei secoli successivi in quanto i trasporti marittimi si andavano dimostrando più veloci, economici e sicuri di quelli terrestri. Già nel XIV secolo era preferibile raggiungere Cracovia dall’Italia viaggiando via mare fino al Mar Nero e risalendo poi il corso del Dnestr via Leopoli, pittosto che sulle vie di terra attraverso le Alpi e l’Europa centrale.
I progressi della tecnologia
Siamo abituati a pensare alla tecnologia come a un portato della modernità, ma in realtà lo sviluppo tecnologico ha sempre giocato un ruolo molto importante nello sviluppo economico di ogni società. In Europa gli sviluppi della tecnologia navale nel tardo Medioevo e i passi avanti compiuti nello stesso periodo dall’astronomia furono le premesse fondamentali che resero possibili le esplorazioni geografiche. La rilevanza di queste innovazioni tecnologiche era ben chiara anche ai contemporanei. Francesco Bacone dichiarò che le tre invenzioni più importanti della sua epoca erano la bussola, la polvere da sparo e la stampa. Da allora, molto inchiostro è stato usato dagli storici nel commentare come queste tre colonne portanti del successo globale europeo paradossalmente fossero state tutte inventate in Cina. La bussola era giunta in Europa nell’ultimo quarto del XIII secolo e fu un ausilio indispensabile per rendere possibile la navigazione in alto mare in assenza di punti di riferimento sulla terraferma. Progressi continui nelle costruzioni navali e nel disegno delle velature permisero inoltre l’aumento della stazza e il miglioramento della manovrabilità del naviglio.
Un altro fattore decisivo fu la produzione di armi sempre più sofisticate grazie a invenzioni che resero trasportabile l’artiglieria sulle navi e permisero la creazione di cannoni che utilizzavano polvere da sparo. Anche quest’ultima era stata originariamente scoperta in Asia e fu, per suprema ironia, una delle principali armi con cui gli europei riuscirono a imporsi negli spazi commerciali asiatici.
Grazie alle innovazioni tecnologiche l’efficienza del naviglio europeo migliorò considerevolmente. Dal punto di vista economico, uno degli effetti fu in questo periodo la costante diminuzione del rapporto fra consistenza numerica degli equipaggi e tonnellaggio delle navi, con la parallela diminuzione delle spese di investimento e di gestione del commercio marittimo; un altro elemento, questo, che diede agli europei un grosso vantaggio relativo sul mare. Il calo dei costi del trasporto marittimo ha fatto parlare di una «rivoluzione dei trasporti» nella prima età moderna; ma secondo molti studiosi non è possibile parlare di una vera e propria «rivoluzione» per il periodo precedente all’introduzione dei motori a vapore nell’Ottocento. Nuovi studi ci portano ora a pensare che a migliorare decisamente in questi secoli fu la possibilità di contenere i costi della remunerazione degli equipaggi e di accrescere quindi la produttività del naviglio come mezzo di trasporto.
Se sul mare la supremazia degli europei fu da subito evidente, sulla terraferma essi rimasero a lungo assai vulnerabili. Per molto tempo riuscirono a controllare i mari e gli oceani, fondamentali per il commercio di lunga distanza, ma non a stabilirsi sui territori, ad esempio in Asia, se non occupando piccoli avamposti sulle coste che si dimostrar...
Indice dei contenuti
- Introduzione. Perché il commercio internazionale?
- 1. Il commercio internazionale alla vigilia delle scoperte geografiche
- 2. Le scoperte geografiche e la riorganizzazione dei traffici
- 3. Il Mediterraneo
- 4. L’Oceano Atlantico e il Mar Baltico
- 5. L’Oceano Indiano e il Pacifico
- 6. Le vie di terra
- 7. Le strutture finanziarie
- Conclusioni. Una «protoglobalizzazione»?
- Bibliografia
- Cronologia