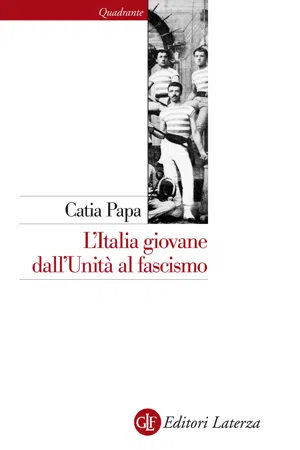Comunità maschili
1. I goliardi alpinisti
Nell’Italia di fine Ottocento l’alpinismo giovanile costituiva una raffinata estensione del più tradizionale percorso formativo delle giovani generazioni appartenenti agli strati medio-alti della società. La passione delle ascensioni veniva coltivata e trasmessa in famiglia e l’affiliazione parentale garantiva l’impronta cetuale di questa particolare attività ricreativa. I modelli educativi, gli stili di vita e i codici valoriali delle classi dirigenti cominciavano a irradiare un’area sociale meno ristretta ed esclusiva, ma la pratica alpinistica rimaneva un’esperienza largamente élitaria.
La celebrazione delle virtù pedagogiche dell’alpinismo aveva accompagnato e legittimato la creazione del Cai all’indomani dell’Unità. L’insieme di interessi naturalistico-scientifici connessi alla modernizzazione aveva mosso larga parte dei suoi fondatori, declinandosi però sempre in termini patriottici, di potenziamento della cultura scientifica nazionale, di valorizzazione storica e politica del territorio alpino, di perfezionamento fisico e morale di una gioventù studiosa altrimenti esposta a vaniloqui letterari e dissolutezze goliardiche. Sin dal principio quindi la pratica alpinistica era stata proposta come uno stimolo all’emersione di una coscienza nazionale e come un necessario corroborante della tempra giovanile. Elevazione culturale e patriottica, rigenerazione del corpo, scuola di ardimento e abnegazione: l’alpinismo non era un semplice sport, quanto piuttosto una vera e propria «palestra della nazione».
I primi tentativi d’inserire il Cai nel circuito scolastico ebbero luogo a Torino e Milano alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, quando singoli esponenti del sodalizio, maestri e professori, cominciarono a organizzare «carovane scolastiche» in montagna. Nel 1893, in occasione della nomina ministeriale della Commissione per la riforma dell’educazione fisica nelle scuole, la direzione della società provò quindi a far includere la pratica dell’alpinismo, o meglio delle escursioni in montagna gestite dai suoi circoli, nei programmi scolastici. La proposta non ebbe successo e negli anni seguenti il coinvolgimento del corpo studentesco nelle attività del Cai rimase sporadico e occasionale. Intanto però nei regolamenti dei circoli cittadini, e poi anche negli statuti nazionali, iniziò a figurare la nuova categoria di soci aggregati, inizialmente aperta soltanto ai parenti d’ambo i sessi di un socio ordinario. Il regolamento nazionale prevedeva l’associazione delle donne come soci ordinari, e tuttavia la presenza femminile, al pari di quella giovanile, per anni risultò mediata dai rapporti di parentela. Le donne e i giovani figuravano essenzialmente come familiari di un socio maschio e adulto, come membri di quella comunità organica familiare ordinata dal Codice civile italiano. Le riforme statutarie di fine secolo sancirono infine anche per i minorenni e gli studenti la possibilità di associarsi a titolo individuale, benché ancora come soci aggregati, i quali non godevano dei diritti statutari, non potevano essere eletti negli organi direttivi e non ricevevano le pubblicazioni sociali. Nel tempo, comunque, la quota d’iscrizione venne addirittura diminuita per facilitare l’accesso della gioventù studiosa nei ranghi della società.
La nuova politica d’attenzione verso il corpo studentesco non si tradusse però mai nella pratica dell’iscrizione collettiva di classi o istituti ai circoli del Cai, come invece avveniva di frequente nella Dante Alighieri. Ancora in età giolittiana, il proselitismo giovanile rimaneva fedele ai codici ideali delle origini: l’associazionismo montano costituiva un segno di distinzione morale e civile e doveva quindi discendere da una scelta individuale, per quanto filtrata da rapporti familiari e accademici preesistenti. La sollecitazione di un parente, l’esempio di un professore, l’adesione a un’associazione goliardica guadagnata al gusto della montagna: così si delineò il nucleo fondativo della Stazione universitaria del Cai (Sucai). Una struttura d’avanguardia nel panorama associativo borghese, perché ordinata su un criterio generazionale e organizzata su basi nazionali, a testimonianza della maturata consapevolezza, tanto nei padri quanto nei figli, dell’opportunità di aggiornare forme e contenuti degli itinerari di nazionalizzazione della gioventù.
Anche la Sucai prese forma nell’ambiente studentesco milanese. Alla fine del febbraio 1905, mentre le città venivano invase dalla consueta «gazzarra del carnevale», il circolo di Monza del Cai organizzò una gita di studenti medi e superiori al Gran San Bernardo, che ebbe luogo nella seconda settimana di marzo. All’escursione parteciparono le associazioni goliardiche di Milano e Pavia e il fascino dei «silenzi divini dell’alta e nevosa montagna» fece tanta presa sui giovani goliardi da indurli a promuovere un’autonoma sezione universitaria. Così il racconto di uno dei sostenitori della Sucai nella primavera successiva, di fronte alla platea del primo congresso internazionale alpinistico studentesco. In realtà, il nucleo promotore dell’associazione era già stato conquistato alla pratica dell’alpinismo e annoverava giovani ormai in procinto di laurearsi. L’ideatore riconosciuto era il ventiquattrenne Gaetano Scotti, originario di Monza, avviato alla montagna da precedenti escursioni studentesche progettate dal circolo locale e all’epoca iscritto all’ultimo anno di università a Pavia. Dal 1906 le cronache del Cai potevano registrarne le ambiziose scalate effettuate insieme ai fratelli Romano e Angelo Calegari e a due loro cugini, i fratelli Romano e Antonio Balabio, tutti soci della prima ora della Sucai. Le relazioni personali restavano il principale veicolo di diffusione dell’alpinismo giovanile. Quando la sezione di Monza si rese disponibile a istituire nel suo seno uno speciale gruppo di soci studenti (e studentesse), le associazioni goliardiche di Milano e Pavia rivolsero un appello d’adesione alle consorelle di tutta Italia, ma solo un serrato carteggio individuale strinse intorno al progetto alcuni universitari degli atenei di Padova, Bologna, Parma, Firenze, Pisa, Genova e Roma. Il regolamento della sezione fu pronto alle soglie del nuovo anno accademico e la Sucai sorse ufficialmente nel novembre 1905.
Lo statuto dell’associazione prevedeva l’elezione di un consiglio, composto da almeno quattro membri, in ogni sede universitaria e ciascun ateneo doveva esprimere un delegato al direttivo nazionale della Sucai, incaricato di coadiuvare la direzione ordinaria del circolo di Monza nella gestione della Stazione studentesca. Dove fu possibile i comitati universitari furono ospitati presso i circoli cittadini del Cai, altrove i giovani si diedero convegno in case private. Nel gennaio 1906 avevano eletto il proprio delegato al direttivo della Sucai le università e gli istituti superiori di quasi tutte le città coinvolte, tranne i gruppi ritardatari di Roma e Parma ma con l’aggiunta del consiglio di Torino. Le finalità della Sucai rispecchiavano quelle della società madre, benché declinate a misura dell’universo studentesco. Il sodalizio si proponeva infatti
di diffondere la nobile passione pei monti fra la parte più intelligente della gioventù italiana, distogliendola da altri generi di sports che esercitano quasi esclusivamente le facoltà fisiche dell’individuo. I giovani dediti agli studi scientifici e letterari troveranno certamente nel razionale esercizio alpino un campo assai vasto per esercitare le loro menti [...] concorrendo altresì coi loro svariati studi sulle montagne a fare vieppiù conoscere e apprezzare il nostro Bel Paese.
Questa vocazione pedagogico-nazionale sovrastava largamente l’interesse per la promozione della vera e propria pratica alpinistica fra gli studenti. Alcuni soci della Sucai erano o divennero alpinisti provetti, ma il vero obiettivo del sodalizio era favorire l’educazione di giovani destinati a raccogliere le sfide della modernizzazione del paese, a guidarlo nei cimenti economici e politici con la stessa energia che li avrebbe portati a scalare le cime alpine. Da qui l’insistenza sulla specificità della pratica alpinistica rispetto ad altri sport, il rifiuto di ogni inclinazione agonistica, la predilezione per le gite e le escursioni. La Sucai era un’organizzazione di propaganda culturale e patriottica tra il ceto studentesco: una «stazione di passaggio» all’età adulta, uno spazio in cui apprendere ed esperire le virtù civiche necessarie a esercitare una futura funzione dirigente. L’alpinismo, in quanto tale, poteva rinviarsi a tirocinio concluso, al momento dell’iscrizione ai circoli ordinari del Cai.
Che si trattasse di una élite in formazione risultava evidente dalle attività ordinarie prefissesi dal sodalizio, votato alla ricerca scientifica nei campi della geologia e mineralogia, della zoologia e botanica, della topografia ed etnografia, dell’economia delle vallate alpine. Ognuna di queste materie veniva seguita da apposite commissioni, che lavoravano sotto la supervisione di un consiglio scientifico composto da professori e personalità competenti. Tra i compiti della Stazione rientrava anche l’indizione di concorsi annuali su tematiche legate alla montagna e all’iniziativa di alcuni suoi soci si dovette la creazione di un archivio fotografico della Sucai, anch’esso implementato da concorsi nazionali. Ancora su proposta della Stazione universitaria, nel 1906 il Cai deliberò la creazione della collana «Guida dei Monti d’Italia», mentre l’anno successivo vide la luce il primo vademecum della società che conobbe varie riedizioni.
Il manuale, agile e stringato, era rivolto ai giovani alpinisti alle prime armi che avessero voluto partecipare alle escursioni promosse dall’associazione. Ogni consiglio locale poteva e doveva organizzare gite in montagna, ma la vocazione pedagogica della Sucai trovava pieno compimento nella predisposizione di occasioni di socialità giovanile che superassero gli storici localismi italiani, che offrissero agli universitari delle diverse regioni del pa...