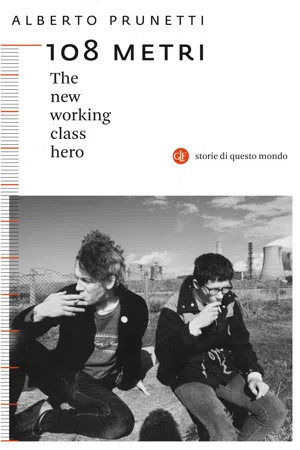That is the question
Alla povera gente non è adatta la tragedia
che è roba di re e principi in ogni caso di gente altolocata,
a noi poveracci si addice il comico, l’irrisione dello strazio
e in certi illustri casi a noi si addice l’epica.
A noi si addice il comico anche per i rocamboleschi sistemi
messi in pratica per la sopravvivenza.
Luigi Di Ruscio, La neve nera di Oslo
Noi dovevamo stare più attenti, avevamo antiche ferite da sanare, antiche ingiustizie cui porre rimedio.
Tommaso Di Ciaula, Tuta blu
Ma adesso torniamo indietro. Aeroporto di Pisa. Banco del check in. Tipi eleganti e formali in giacca e cravatta e gli occhi dei miei vecchi piantati sulle spalle. L’orrendo borsone in plastica blu della Tupperware, privo di rotelle, sale a fatica sulla bilancia. Strano. Renato, il mi’ babbo, aveva insistito per portarlo lui e non mi sembrava che fosse così pesante: l’ultima volta che l’avevo sollevato, i manici non mi segavano le mani. Tutto il personale della compagnia aerea mi guardava strabiliato: ero tre volte sopra il limite e non sapevo cosa fare. Mi spiegarono che dovevo togliere qualcosa… anzi, quasi tutto. Aprii il borsone e a quel punto si mise Renato di mezzo: era stato lui a infilare in borsa a tradimento un pappagallo da idraulico e un serratubi da tre chili. E non solo. C’era una raspa da maniscalco che per lui valeva un tesoro e la mi’ mamma aveva messo anche un ferro da stiro per le camicie. Bello scherzo. Ma al check in scoppiò un tumulto. Quando io tolsi martello e raspa dalla borsa, Renato impugnò gli attrezzi facendoli mulinare sopra il bancone e dando dei pisani – “Cazzo guardate? Tornatevene a Navacchio” – agli stewart della British Airways che dal banco vicino erano venuti tutti sorridenti a godersi la scena pittoresca. La cosa degenerò presto e Renato se la prese con me, quasi fosse colpa mia: “Lo vedi, gli attrezzi non li vole più nessuno… hanno paura di sudà! Hanno! Gli fa schifo lavorà! Non lo mettevo mica in mano al Principe Carlo, il martello, eh! Cacciavite e tenaglie erano per il mi’ figliolo, eh!”. Renato stava quasi per martellare il banco del check in, mentre io lo trattenevo per un braccio. Ovvai, s’è fatto l’ennesima figuraccia, lo sapevo che era meglio se non li facevo venire per quello che ai loro occhi era un addio. Insomma, bisognava capirli, i miei vecchi: mi avevano infilato in borsa i ferri del mestiere per la prima sopravvivenza. Non si sa mai. Solo che i tempi erano cambiati. Ci avevano detto che il lavoro era smaterializzato, che non avremmo sudato più, che mai più avremmo usato le mani. Alla fine arrivarono quelli della Security che condussero Renato fuori dall’area partenze. Lui sdrammatizzò subito e si mise a fumare una sigaretta con uno di quei gorilla con le radioline. Per levarmi di torno, al bancone mi dettero sbuffando una carta d’imbarco e mi spiegarono che dovevo passare attraverso i controlli di sicurezza. Prima però bisognava salutare Francesca, la mi’ mamma, che era già in lacrime. Renato lo vidi attraverso le vetrate che si sbracciava a sindacalizzare dei facchini. Uscii per raggiungerlo. Ma appena mi vide riattaccò il disco: “Hai visto, Alberto? Gli attrezzi, non li vole più nessuno. Martello e tenaglie, non te li fanno portà in Inghilterra. Meno male che le chiavi so’ già inglesi, dé. Quelle le compri anche a Londra”. “Meno male”, replicai. E lui: “Dé, hanno paura di sudà questi incravattati che pesano le borse di quell’altri, eh? Hanno paura di puzzà, dé”. Ora sorrideva. Io tagliai corto. “Dai, io devo andà…”. “O bimbo… ora voli… guardala dall’alto la torre di Pisa, che questi ‘un so nemmeno boni a mette’ in bolla un cantiere edile e l’han fatta storta… diglielo all’ingresi, dé… salutami anche la regina, ce l’avessi io i su’ vaini…”. Insomma, diceva bischerate per camuffare il disagio, lui non aveva mai volato… “Ovvia, vai... se ‘un si va...” disse lui. E io, subito, a contrasto: “…se ‘un si va ‘un si vede”. Empiricamente confortato da questa verità pragmatica e da una paterna manata sulla schiena che anticipava il decollo, superai i controlli ed entrai per la prima volta in un aereo.
Oltre alla valigia, sulla bilancia del banco delle partenze gravavano una serie di fallimenti. Un carico di pesi che mi trascinavo dietro come zavorra. Ero un provinciale che non sapeva nulla del mondo. Una promessa fallita del calcio di seconda categoria e della classe operaia maremmano-labronica. Un titano ribelle che aveva puntato tutto sul cavallo sbagliato: la laurea. Un figlio delle officine che aveva indossato ali intellettuali di cera stearica, cera che si scioglieva in prossimità di quel sole che bacia i ricchi. Certo, dovevo dar retta a mio padre. Lui non aveva dubbi. L’educazione operaia aveva un ciclo di lavorazione ferreo. La militanza calcistica nelle giovanili locali, poi il professionale nell’industria o l’iti e alla fine il doppio turno: acciaierie di Piombino e catenaccio totale in qualche formazione calcistica di dopolavoristi. Il ragazzo ha fisico, bisogna vedere se avrà grinta. C’è stoffa, ma va temprato. Quante volte avrò sentito questi commenti dai vecchi? Se è bravo, andrà in Eccellenza o addirittura in Interregionale. Per me non c’era niente di meglio, a 12 anni. Giocare nel fango dei campetti delle giovanili e dei dilettanti, farmi le ossa e il fisico, prepararmi al mestiere. Tirare fuori la grinta, come si diceva allora, pensando a John Wayne con una benda nera sull’occhio. Poi, con lo stesso urlo di esultanza di Tardelli dopo il gol alla Germania nella finale dei mondiali del 1982, girare i tornelli per entrare in fabbrica a Piombino, dove ci sono le acciaierie e dove sono nato. Nascere, lavorare e morire all’ombra dei pinnacoli dell’altoforno.
Io invece ho pensato che la carta mangiasse la forbice, ho puntato tutto sulle pagine stampate e sull’inchiostro. Un figlio d’operaio lo danno 35 a uno, se esce dal seminato della fabbrica. Ma io testardo, tarlato dall’ansia di sapere cosa ci fosse oltre le colonne di Gibilterra del cancello dell’Ilva, sono andato avanti, un passo alla volta, allontanandomi pian piano dalle acciaierie. Anche perché tutto mi riusciva facile, tra i banchi quasi non riuscivo a sbagliare. Sapevo la lezione anche se non studiavo. Sembrava che i concetti mi fluissero nella mente come l’olio in un motore, senza fare schiuma, asportando fuliggine da cilindri e pistoni. Le mie idee sui banchi di formica si distendevano sulla pagina come la coppale stesa dal falegname sul legno appena carteggiato con la carta abrasiva: senza fare grumi, senza colare.
Intendiamoci: non ero certo toccato dalla magia o dalla genialità. La faccenda era semplice. È che dalle mie parti un collettivo di gesuiti, vicini ai cattolici del dissenso, negli anni Settanta aveva creato prima un doposcuola per i figli degli operai, poi un istituto medio sperimentale. Uno di quei gesuiti nel 1968 aveva addirittura occupato la basilica di San Pietro ed era stato sgomberato dai lanzichenecchi. Anche se negli anni Ottanta gran parte dei gesuiti se n’erano già andati, in città rimanevano gli educatori formati col metodo della pedagogia degli oppressi. E così nel pomeriggio ci mandavano nei quartieri a fare inchieste operaie e a stampare e ciclostilare i nostri giornalini. Ci avevano insegnato a fare fin da piccoli sociologia della classe dei lavoratori, a esigere curiosità e chiarezza dai nostri insegnanti. Loro dicevano che serviva a diventare protagonisti della storia, che alla domanda cosa vuoi fare da grande la risposta giusta non era l’ingegnere o l’architetto ma da grande voglio cambiare il mondo. A dire il vero, noi ci si accontentava di non farci fregare dai quattrinai, che erano poi gli amici e i soci di questo fantomatico padrone di cui i nostri babbi parlavano sempre: non l’avevamo mai visto girare tra i nostri campetti di periferia, ma nessuno dubitava della sua esistenza. E allora occhi aperti e rispondere alle ingiustizie colpo su colpo. Che poi voleva dire fare, con le parole, quello che ci dicevano i nostri vecchi: culo a muro se ti chiamano signore e se la vita ti dà un colpo, te ridagliene due. Ma erano colpi diversi, dicevano gli educatori, voi usate la testa. E infatti al doposcuola partimmo con le testate nelle gengive e loro pazienti, ripulendo le bocche rotte, ci spiegarono che ci sono cose che si chiamano metafore. Sicché noi a forza di cercà metafore prima stempiammo un po’ di bimbi, poi insomma cominciammo a fare inchiesta, a leggere e studiare, coi nostri modi da adolescenti impulsivi.
Se Renato non ostacolò la mia passione per la carta stampata e le metafore, Francesca, la mi’ mamma, ne era invece entusiasta. Certo, lui non leggeva libri ma comprava ogni giorno il quotidiano e lo consumava partendo dalle pagine dello sport, mentre lei era una lettrice onnivora e della mia passione per la lettura fu la prima animatrice e complice. Nessuno si meraviglia così quando nei giorni del mio apprendistato scolastico le maestre dicono che sono “portato per gli studi”. Anche se nessuno mi vede mai fare i compiti. “Solo che c’ha sempre un libro in mano, questo bimbo”, aggiungono. Vero però che anche mamma ha sempre un libro in mano e da qualcuno avrò preso. Dopo le maestre, anche i professori alle medie dicono che sono “portato”, che ho la “memoria fotografica” e la “sintesi”, anche se “a volte il bimbo copia” dal librone dei temi. Ci rimango male, smetto di copiare e comincio a fare giochi strani col vocabolario. Gonfio le frasi. Mi porto a scuola il dizionario dei sinonimi e dei contrari e per ogni parola semplice ci metto una parola difficile, di cui spesso non capisco il significato. I temi diventano illeggibili e privi di senso: la mia idea, ingenuamente, è che le parole difficili son quelle che stanno in bocca alle persone importanti e che le persone importanti sanno tante parole difficili che le rendono incomprensibili ai poveracci come noi. Allora la professoressa delle medie mi spiega che bisogna saper usare le parole semplici per dire cose complesse. Così smetto questo gioco e comincio a scrivere facendo il verso ai libri che leggo. Ora è più divertente. Leggo di continuo, soprattutto Dumas e Stevenson. Inizio presto con la fantascienza e mi divoro quasi tutto Asimov. E scrivo temi pieni di robot e pirati e moschettieri, e la mi’ mamma quando torna dai ricevimenti è tanto contenta perché in italiano è proprio bravo, dice la prof, e quanta fantasia c’ha questo bimbo, signora. Ma non c’ho fantasia e basta, c’ho anche tanta fame. La mia è bulimia di libri. Manducazione coatta fomentata dai gesuiti del dissenso. Fame atavica di conoscenza di chi è stato dispossessato da generazioni di ogni strumento culturale. Insomma, da adolescente sono un insetto xilofago. Gli altri ragazzini leggono, io prendo a morsi i libri col cervello, li metabolizzo e li trasformo in cose, in attrezzi, in metafore, in un’officina di idee come quella, fatta di utensili materiali, che Renato ha in garage. Le professoresse dicono che sarebbe un peccato se io andassi al professionale o al minerario. Comunque a mamma faglielo presente. Che cosa? Della scuola, che dovresti andare al liceo. E io glielo dico. A babbo aspetto, perché sento che non è il caso. Va bene leggere, ma studiare nelle scuole alte è un’altra faccenda. Oddio, anche lui si è rimesso a studiare, perché i suoi colleghi incalzati dal sindacato si sono iscritti alle 150 ore e lui che la terza media ce l’ha già, vorrebbe prendersi il diploma professionale da adulto e si è comprato un corso di diploma per posta per operai, una roba tipo il corso di elettronica di Radio Elettra. Ma dopo un po’ si rompe le scatole, soprattutto con l’italiano, e io gli dico, babbo, te lo scrivo io il tema, che lui c’ha poca passione per la letteratura ma mamma dice che è normale, è stanco, appena prende un libro si addormenta perché per farvi studiare a te e a tua sorella sta fuori casa anche dieci giorni di seguito e torna con una borsa di tute da metalmeccanico piene di polvere grigia.
Ma intanto Renato vuol prepararmi alla fabbrica e sento che non posso dirgli quella cosa del liceo. Infatti comincia a insegnarmi i primi rudimenti della meccanica dei metalli, nei rari fine settimana in cui, di ritorno dalle raffinerie del nord, la pioggia gli impedisce di portarmi a vedere le partite di calcio locale, sui campetti senz’erba della prima categoria. Però su quell’argomento mi ci porta a sbattere proprio lui, senza volerlo, per strada, lungo l’Aurelia, una volta che diventa serio, abbassa il volume mentre ascoltiamo Tutto il calcio minuto per minuto e mi chiede che voglio fare da grande. Io rispondo il calciatore. Lui fa: “parlo sul serio”. Io dico il saldatore alle acciaierie. Faccio una pausa e poi aggiungo: “Però dopo il liceo”.
Lui ribatte: “Lo so. Mamma me l’ha detto, che vuoi fare il liceo. Lo scientifico, vero?”
“Non sono io, è mamma che vuole mandarmi al liceo”, replico. “E anche la professoressa d’italiano e il prof di storia. Comunque dicono che andrei bene anche al classico”.
“Il classico ‘na bella sega”, mormora pian piano tra sé, ma si fa sentire.
“Se vai al liceo scientifico”, (ha già fatto la scelta), “dopo devi andare all’università. Sei sicuro di farcela? Nessuno di noi s’è mai laureato”.
Io rimango zitto. Poi torno all’attacco.
“Ma al classico…”.
Ribatte: “Il classico non se ne parla neanche” (lui adora la meccanica e la tecnica).
A quel punto mi blocco. Ho paura di chiedere un giocattolo troppo costoso.
“No, macché liceo. Voglio andare alle acciaierie. Davvero. Faccio il chimico, o il minerario. O l’Ipsia. Non lo so”.
“C’è tempo”, fa lui, “sentiamo i risultati delle partite alla radio. Te controlla la schedina”.
E rialza il volume. “Scusa Ameri… Scusa Ameri…”.
Due settimane dopo ritorna dalla solita trasferta nelle raffinerie tra le risaie del Vercellese e le Alpi del levante ligure.
“Vieni con tu pa’ a vedè le partite”.
Contento, rispondo di sì. Con mipà. Questa del pà è una cosa buffa. Dalle mie parti si dice babbo. Papà è un francesismo da ricchi in Toscana. Tupà, invece, proferito senza iati, tupà, e accompagnato a tumà, si può dire e io penso che se lo dice lui è vernacolo livornese. Invece pare che forse sia ligure, ma l’ho saputo solo qualche tempo fa, quando mipà non c’era già più. Era una delle sue forme linguistiche di ibridazione dialettale da tubista in trasferta: parole affettive e improperi, in corrente alternata sulle sue labbra con una precisa scansione ritmica, venivano estratte da un contesto geografico, rifuse come rottami nell’altoforno che teneva in petto e trasformate nel nostro lessico famigliare.
“Da’ retta a tupà”.
“Sì babbo”.
“Cosa voi fa’ dopo la terza media”.
Non era interrogativa. Era un’affermazione, come un punto all’ordine del giorno di un’assemblea sindacale tra padre e figlio che si svolgeva nella vecchia audi 80, lungo l’Aurelia, di ritorno da Rosignano Solvay, satolli dei meravigliosi crostini al fegato di nonna e con le orecchie sintonizzate sulle radiocronache di calcio.
Stavolta non volevo fare la figura del figlio di papà che dice “vorrei fare l’architetto, o l’ingegnere o l’avvocato”. Ora, un vicino m’aveva detto: se vuoi continuare a studiare, perché non fai l’accademia navale a Livorno? Non costa nulla ai tuoi genitori e così fai gli studi. C’è anche chi va all’università.
Io non sapevo cosa fosse l’accademia, però sembrava un modo per far risparmiare i miei. Non costa nulla e allora perché no? Vado all’accademia navale, dico.
E adesso in auto lo ripeto anche a Renato negli ultimi chilometri d’Aurelia, il pezzo d’asfalto dove ci diciamo le cose personali. È qui che mi ha raccontato di quando distrusse la bici del mi’ nonno e fu l’unica volta che il vecchio prese la cintola, o di quando nonno per non andare al fronte fece una cosa eroica e bellissima, durante la seconda guerra mondiale. L’avevano mandato in cavalleria, a lui che era un muratore mezzo contadino, e nonno saltò sulla sella, chiuse gli occhi e si buttò a babbo morto dal dorso del quadrupede sopra un roveto. Lo tirarono fuori pieno di spine e lo mandarono all’ospedale. Lontano dal fronte dell’esercito del duce. Disse che la bestia l’aveva disarcionato. Fu brutta, ma sempre meglio di quel suo amico che si tolse i denti da solo per non andare in guerra. E ogni volta che passo da quel pezzo d’Aurelia io ripenso a questa storia di nonno Santi e del suo amico che si tolse i denti da solo. Ma stavolta quel pensiero è interrotto da una domanda che tradisce un filo d’ansia:
“Allora, hai deciso cosa voi fa’ dopo la terza media?”
E io gli dico quello che mi ha detto il giorno prima un vicino:
“Voglio andà all’accademia navale a Livorno”.
Renato incassa un colpo alla milza che sembra sganciato dal campione dei pesi medi dell’epoca, Marvin “Marvelous” Hagler. Ha la faccia come una lastra di marmo. Non dice nulla. Non fa nulla. Per trecento metri. Poi di scatto mette una freccia, sterza e inchioda lungo la striscia bia...