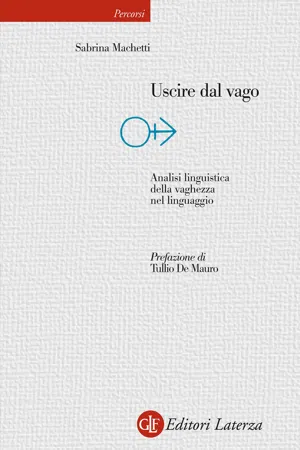1. La vaghezza tra semiotica e linguistica
Definire cosa la vaghezza sia e quali siano le sue manifestazioni e i suoi effetti è operazione tutt’altro che scontata. Anche l’aver optato per una collocazione del problema nell’ampio universo della semiosi, e con essa del linguaggio e delle lingue, non sembra esserci, almeno per il momento, di grande aiuto. A complicare il tutto si aggiunge il fatto che la tradizione degli studi linguistici e semiotici che percorre gli ultimi anni dell’Ottocento e tutto il Novecento, studi da cui sarebbe legittimo aspettarsi almeno qualche indicazione, appare carente di ricerche in grado di offrire, se non ricostruzioni organiche, almeno brevi ricognizioni del problema1. Per la verità, per simili difficoltà non manca una spiegazione: la maggior parte dei linguisti e dei semiologi si occupa infatti poco o niente di vaghezza e, se lo fa, non rende mai questa proprietà il nucleo centrale della propria riflessione.
Tuttavia, l’aver collocato la vaghezza tra i problemi del linguaggio e delle lingue storico-naturali ci obbliga a ripercorrere la strada tracciata dalle relative discipline. Il risultato, lo si è già detto, non sarà una ricostruzione organica, e neppure rispettosa di un ordine rigidamente cronologico, ma l’indicazione di un percorso dai labili confini, al contempo preparatorio alla definizione, a cui è dedicato il capitolo 2, del concetto di «vaghezza» e alla descrizione delle sue manifestazioni. In ciò, tenteremo di tenere insieme autori e riflessioni a volte molto diversi tra loro, in apparenza anche distanti dall’oggetto della nostra discussione, nella convinzione che la vaghezza abbia molto da guadagnare se analizzata in un contesto di ravvicinato contatto tra ambiti di ricerca difformi, ma aventi tutti come proprio principale oggetto la lingua. Obbligato, seppur di necessità sintetico, è uno sguardo a quella che potremmo definire la storia logico-filosofica della vaghezza.
1.1. La vaghezza dei logici e dei filosofi: un fastidioso ostacolo
Nella storia del pensiero occidentale, i logici e i filosofi sono stati di certo fra i primi a trovarsi a fare i conti con la vaghezza. Per coloro che ne hanno intravisto i legami con il linguaggio, si può dire che la vaghezza abbia sempre e sostanzialmente rappresentato un ostacolo piuttosto fastidioso: le loro discussioni, per la maggior parte legate alle teorie della verità e del riferimento, hanno infatti rischiato di arenarsi di fronte ai problemi creati da questa proprietà non, si badi bene, per il linguaggio generalmente inteso, ma per il solo significato di termini, espressioni, proposizioni, anche all’interno di linguaggi almeno teoricamente perfetti, lontani dalla sregolatezza del linguaggio naturale2. L’obiettivo è dunque stato quasi sempre quello o di eliminare la vaghezza, o di governarla nel migliore dei modi possibili, sempre attraverso un trattamento di tipo logico-formale. Mai o solo raramente ci si è occupati della sua definizione, forse per evitare problemi e controversie di difficile soluzione, o forse perché, direbbe ironicamente Hans Blumenberg (1987), anche la vaghezza fa parte di quelle cose tutte teoriche che non si vedono, difficili da far corrispondere a concetti dai confini chiari e stabili.
I primi tentativi di «gestione» della vaghezza risalgono certamente al mondo antico e a una serie di paradossi attribuiti da Diogene Laerzio, nelle Vite dei filosofi, al logico megarico Eubulide, un contemporaneo di Aristotele: primi tra tutti, il paradosso dell’Uomo Calvo, phalakros, e quello del Mucchio, sorites, da soros, «mucchio»3. Per simili puzzle, e per l’idea che ad essi soggiace, e cioè che certe proprietà appartengono a una determinata categoria solo quando certe condizioni hanno superato una determinata soglia, la vaghezza dei termini che indicano tali proprietà sembrerebbe in grado di condizionare pesantemente la possibilità di determinare con esattezza a cosa la suddetta soglia corrisponda. Ed è evidente come ciò rappresenti un problema di difficile soluzione.
Dai paradossi in poi, alla vaghezza si lega comunque in filosofia l’immagine di un continuum di base caratteristico di termini, espressioni, proposizioni, continuum lungo il quale si verificano costantemente impercettibili cambiamenti. Si tratta di un’immagine destinata a sopravvivere per millenni, accolta fino ai giorni nostri da un gran numero di logici e filosofi del linguaggio4. Tra questi non manca chi, cercando ancora una soluzione agli antichi paradossi, spinge le proprie ricerche verso logiche e semantiche alternative, riprendendo ma anche superando ampiamente sia la nota posizione di Gottlob Frege (1848-1925) – che guardava alla vaghezza come a un difetto del linguaggio naturale e per questo teorizzava l’adozione di un linguaggio artificiale in cui ciascun predicato fosse caratterizzato da assoluta precisione – sia quella, altrettanto nota, di Bertrand Russell (1872-1970) – che legava la vaghezza al linguaggio naturale, ma non per questo la considerava un difetto da eliminare5. Solo per fare qualche esempio, all’interno di tali logiche e semantiche c’è chi ha ipotizzato l’esistenza di veri e propri «buchi» nel valore di verità delle proposizioni vaghe, considerando come proprio le proposizioni contenenti termini vaghi siano tali da non potersi dire in alcun modo né vere né false, visto che il loro valore di verità è in pratica nullo; accanto ad essi, non pochi sono i sostenitori del cosiddetto «terzo valore di verità», appunto attribuibile, perché neutro, indeterminato o indefinito, a espressioni contenenti termini vaghi; oppure coloro che ritengono, come i seguaci della cosiddetta logica fuzzy, che alle espressioni contenenti termini vaghi sia possibile riferirsi attraverso uno spettro di valori di verità intermedi («gradi del valore di verità»), compresi cioè tra 0 e 1, in cui 0 = «completamente falso» e 1 = «completamente vero»6.
Va però detto che il ricorso a logiche e a semantiche alternative non rappresenta attualmente l’unica via per trattare la vaghezza. Non manca infatti tra i filosofi chi sostiene, come Timothy Williamson, che la vaghezza risulti paragonabile a una sorta di ignoranza, dovuta ai limiti del nostro conoscere, tali da non consentirci di stabilire quali siano realmente i confini dei predicati vaghi, per natura netti e precisi. La vaghezza non è dunque una proprietà che riguarda necessariamente il significato; anzi, a livello di significato, l’esistenza di confini netti per i predicati vaghi è tale da rappresentare un’ottima garanzia per il mantenimento della semantica classica, almeno fino a quando non si riusciranno a trovare buone ragioni per dimostrare il contrario7.
Del tutto distante dalle precedenti, e dunque anche lontana dal problema dei paradossi, è infine la posizione di coloro che tentano di trattare la vaghezza classificandola tra i problemi non linguistici: secondo un ristretto numero di filosofi contemporanei, non sarebbe infatti il linguaggio a essere vago, ma, al contrario, sarebbero gli «oggetti» – siano essi condomini, gatti, colline o anche entità della fisica quantistica – a presentare confini spaziali e temporali indefiniti, sfumati, evanescenti. Di conseguenza, il linguaggio di cui ci serviamo per descrivere simili oggetti non è in se stesso vago, ma lo diverrebbe in virtù della vaghezza dell’oggetto descritto8.
1.2. Un concetto propriamente linguistico: Peirce
La nostra storia semiotica e linguistica della vaghezza – una storia, lo abbiamo detto, dai confini incerti – inizia da colui che in molti indicano come l’inventore della semiotica, ma, al contempo, come grande logico e più in generale studioso delle scienze del linguaggio: Charles S. Peirce (1839-1914)9. La ragione di questo inizio non è casuale, perché è proprio a Peirce che si deve non solo quella che è una formulazione esplicita della definizione di «proposizione vaga», che sottintende un legame forte tra la vaghezza e il linguaggio, ma anche quella che al contempo rappresenta una definizione con cui, forse per la prima volta, si tenta di elaborare concettualmente il problema. Va detto che si tratta anche di una risoluzione «matura», piuttosto distante cioè da cenni alla vaghezza presenti in precedenti lavori di Peirce in cui, solo per fare un esempio, la dimensione dell’uso non godeva della forza di cui sembra dotarsi proprio a partire dai primi anni del Novecento.
Nella voce redatta per il Dictionary of Philosophy and Psychology di Baldwin (1901, 2.748), la vaghezza è infatti una caratteristica linguistica in virtù della quale la comunicazione tra i parlanti si svolge e funziona con successo anche mediante proposizioni per le quali è impossibile decidere, a causa della loro intrinsic indeterminacy, se i fatti a cui fanno riferimento sono affermati o negati da esse:
Una proposizione è vaga quando sono possibili stati di cose per i quali è intrinsecamente incerto stabilire se colui che parla, dopo averli contemplati, li considera affermati o negati dalla proposizione. Con intrinsecamente incerto noi intendiamo non incerto come conseguenza dell’ignoranza di colui che interpreta, ma a causa del fatto che sono indeterminate le abitudini linguistiche del parlante; in modo che un giorno egli ritiene che la proposizione esclude, un altro giorno che ammette quegli stessi stati di cose. E questo deve essere posto in riferimento a ciò che si potrebbe dedurre da una conoscenza perfetta del suo stato mentale: ma proprio perché queste condizioni non si danno, o non si danno frequentemente, le abitudini linguistiche di chi parla restano indeterminate (nostra traduzione).
La definizione prosegue oltre, ma è certo questa prima parte a destare maggiore interesse. Essa ruota attorno ad alcune assunzioni fondamentali: vi sono espressioni che fanno riferimento a fenomeni borderline, a cui Peirce guarda come a stati di cose che l’applicazione di una particolare espressione non può né affermare né negare; queste espressioni equivalgono a proposizioni vaghe e ad esse si associa un carattere di intrinseca incertezza che non può essere fatta risalire a un difetto di conoscenza da parte del parlante, poco o male informato su un particolare stato di cose. Al contrario, al parlante sembrerebbe attribuibile il possesso di una perfetta conoscenza del proprio stato mentale, anche se questa condizione normalmente non si dà o si dà solo raramente. Infatti, del patrimonio linguistico di ciascun parlante fanno parte usi ampiamente incerti, abitudini linguistiche indeterminate e così destinate a rimanere, tali cioè che l’incertezza ad esse intrinseca non potrebbe neppure risolversi attraverso un’operazione di accrescimento delle informazioni provenienti dal mondo esterno.
Come si diceva, la definizione va avanti e, sintetizzando molto, vede Peirce impegnato ad esempio nel distinguere la vaghezza da una proprietà consimile, la generalità: se «generali» sono proposizioni del tipo Man is mortal, vaghe possono dirsi, all’opposto, proposizioni quali This month a great event is to happen (ivi, 5.505). Le proposizioni vaghe sono quelle che mancano cioè di specificazione: infatti l’esempio appena citato si limita a dirci che un qualche evento accade in questo mese, ma non specifica di quale evento si tratti; anzi, se specificazione ci sarà, essa sarà nelle mani del solo emittente, a differenza di quanto accadrebbe se lo stesso emittente avesse di fronte proposizioni generali, la cui specificazione è normalmente compito del destinatario.
Pur se alla definizione di Peirce continuerà a far riferimento gran parte dei linguisti e semiologi contemporanei – sia per aver sottolineato, seppur tra le righe, come la vaghezza sia caratteristica non solo dei segni del linguaggio, ma anche di sensazioni e immagini in quanto segni del pensiero, sia per aver esplicitamente legato la vaghezza non alla sola semantica ma anche a una situazione di incertezza di tipo pragmatico –, ciò non toglie che essa presenti limiti che di certo non ne favoriscono il pieno distacco da posizioni più classiche, quali quelle che abbiamo visto accomunare molti logici e filosofi del linguaggio. Peirce guarda infatti all’esistenza di espressioni vaghe e alla situazione di incertezza pragmatica ad esse legata come a dati di fatto ineliminabili, forse perché costitutivi dell’essere stesso della semiosi verbale; ma ciò non gli impedisce di dare un giudizio decisamente negativo proprio su tali espressioni. Esse popolano il linguaggio, ma ciò non significa che rappresentino anche un vantaggio per i parlanti.
1.3. Un probabile intoppo applicativo: Black
Dopo Peirce, il percorso semiotico e linguistico tracciato in queste pagine, forse per non tradire la sua liminarità, ci porta curiosamente a incontrare Max Black (1909-1988), logico e filosofo. Lo inseriamo nella nostra storia della vaghezza e gli attribuia...