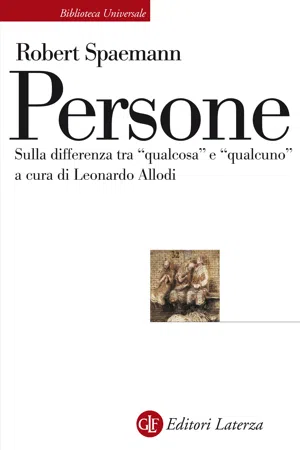
- 272 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
«Le persone, tra tutto ciò che esiste, hanno una particolare posizione. Per sapere se abbiamo a che fare con "qualcosa" o con "qualcuno", è per noi necessario sapere prima di che tipo di essere si tratta. Che cosa intendiamo quando parliamo di "qualcuno", dunque di una persona, e in tal modo gli accordiamo il diritto a uno status particolare?» Spaemann ripercorre l'evoluzione del concetto di "persona", dei suoi presupposti e mutamenti. Un contributo essenziale al dibattito contemporaneo sulla fondazione dei diritti e sulla dignità dell'uomo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Libertà
I
L’idea di persona è strettamente associata a quella di libertà. Più esattamente, essa offre al concetto di libertà una nuova dimensione, la cui fondatezza è stata sempre di nuovo messa in discussione, la dimensione cioè della «libertà del volere». Chi attribuisce all’uomo la libertà del volere, intende con questo affermare che l’uomo è il fondamento «stesso» del proprio-agire-così-e-non-altrimenti. E certamente non solo in modo che questo agire sia la conseguenza necessaria di condizioni antecedenti sottratte alla sua possibilità, ma in modo che l’uomo stesso porti una responsabilità per il suo essere-così, nella misura in cui questo essere-così è plasmato dalle sue azioni e nella misura in cui le decisioni su determinate azioni sono, al tempo stesso, decisioni su ciò che qualcuno cerca di essere come uomo.
Per poter intendere e valutare questa radicalizzazione del concetto di libertà, dobbiamo chiederci innanzitutto che cosa intendiamo quando parliamo di libertà. «Libertà» è un concetto riflessivo, non designa uno stato di fatto che si possa mostrare positivamente, ma riflette sull’assenza di tale stato e certamente, di solito, sull’assenza di un danno. Un uomo è libero dalla febbre o da una mania, una regione è libera dalla malaria, un popolo è libero da un dominio straniero o da un tiranno. Affinché una tale assenza venga espressamente percepita, ciò che esercita una costrizione deve essere vissuto innanzitutto come possibilità reale. O deve essere stato effettivamente presente in precedenza, oppure deve apparire come minaccia, oppure ancora deve essere percepito come realtà in altri, e di certo in altri con i quali si confrontano quanti non hanno subito tale danno. Definiamo «libera dalle cimici» una camera se in essa non vi sono cimici. Di «liberi» si parla in relazione a società nelle quali non esiste la servitù o la schiavitù. Libertà è sempre un «essere liberi da» qualcosa. Diversamente si tratta di una parola vuota.
Lesioni di tale libertà, così come una riflessione sulla loro assenza, esistono soltanto per esseri che tendono per se stessi verso qualcosa. Libertà è perciò sempre libertà di sviluppare una tendenza propria. Per gli animali esistono «riserve libere». Parlare di «caduta libera» è un modo di dire aristotelico, che presuppone la «tendenza» di un corpo a cadere verso il basso, a cui può essere opposta una resistenza. È propria della libertà la possibilità di dispiegarsi in accordo con la propria specie. Una rondine nell’acqua o una trota sulla riva non sono libere.
Tuttavia, non vale per ogni tendenza immanente il fatto che la sua possibilità di sviluppo significhi libertà. La mania, ad esempio, è una tendenza interna, ma seguirla ci rende schiavi. Perché? Perché essa è innaturale. Perché la chiamiamo «innaturale»? Liberi o non liberi possono essere soltanto esseri che possiedono una «natura», dunque – nella definizione di Aristotele – il fatto di avere «il principio del riposo e del movimento in se stessi»1, esseri che tendono da se stessi a qualcosa: innanzitutto e soprattutto che tendono a rimanere nell’essere. Ora, la natura dell’uomo è plastica in modo incomparabile e possiede un margine molto vasto di possibili «movimenti». Questo spazio di libertà viene strutturato dall’educazione, dalla lingua, dai costumi e dalle abitudini, dunque da ciò che chiamiamo «seconda natura». Poter vivere in conformità a questa seconda natura, dunque all’abitudine, per i Greci del VI secolo avanti Cristo coincideva con l’eleutheria, con la libertà. Tiranno era colui che impediva questo all’uomo. Non fu l’antica norma di dare sepoltura al fratello a privare Antigone della propria libertà, ma il nuovo divieto di farlo imposto da Creonte.
Solo con i sofisti emerge una nuova riflessione di tipo emancipatorio poi approfondita da Platone, cioè l’idea che anche i costumi possono privare della libertà, e precisamente quando la seconda natura venga contrapposta alla prima. E questo addirittura vale quando un uomo ha già interiorizzato così profondamente questa seconda natura da non percepire più la tendenza della prima. In questo caso proprio perché egli, anche interiormente, è divenuto schiavo, non per il fatto di essere divenuto libero. Per essere liberi, si deve poter fare ciò che si vuole; tuttavia, per fare ciò che si vuole si deve sapere che cosa si vuole. La non libertà non deve consistere necessariamente nella determinazione estranea. Si può agire per un volere proprio «improprio», come ad esempio fa il tossicomane. Secondo Platone, alla base di tale volere improprio si trova una percezione deformata della realtà e di ciò che sia desiderabile.
Il criterio per la valutazione dei differenti costumi, cioè per riconoscerli come di volta in volta realmente appartenenti a me, si chiama per i Greci «natura». Il naturale, inteso come «ciò che è conforme all’uomo», rende possibile una comprensione emancipatoria della libertà. Rende possibile l’emancipazione della prima natura dalla seconda, o per lo meno, come in Aristotele, la valutazione della seconda natura in ragione della sua armonia con le condizioni della prima.
Ma una tale verifica non è insensata? Se, in generale, ha senso parlare di qualcosa come della natura dell’uomo, non si dovrà chiamare «natura» ciò che si impone da sé rispetto a tutte le abitudini e i motivi secondari? I sistemi secondari – il «software» – si possono stabilire e conservare soltanto se sono compatibili con la natura plastica dell’uomo – lo «hardware».
L’obiezione manca il segno perché la natura di tutti gli esseri viventi superiori non si trova di fronte all’alternativa tra respingere ciò che è dannoso o caderne vittima. Gli esseri viventi superiori sono caratterizzati, come dice Aristotele, da una differenza tra mera vita e vita buona2. Esistono per essi diminuzioni della vita che non coincidono con la sua immediata distruzione. Il tossicomane vive, ma vive male. La sua salute soffre, la portata dei suoi interessi si restringe, la sua dipendenza aumenta. A differenza delle abitudini che chiamiamo virtù, i vizi, cioè le «cattive abitudini», sono tali che, anziché renderci capaci, ci impediscono di fare ciò che noi stessi, indipendentemente dall’abitudine, faremmo volentieri a partire da una nostra intellezione. La «seconda natura» può evidentemente trovarsi in un rapporto armonico o disarmonico con la prima. Noi possiamo chiamare «liberi» gli uomini nei quali questo rapporto è armonico, in modo che la prima natura non sia soffocata dalla seconda, ma venga disciplinata in modo da potersi sviluppare corrispondentemente alla propria intellezione e possa raggiungere una determinata forma storica.
Lo stesso vale per il nomos sociale. Per un concetto «naturalistico» del «naturale», ogni ordinamento sociale deve essere sempre naturale, in quanto è sempre conseguenza di un naturale «parallelogramma» di forze, dunque espressione del naturale istinto di potere dei più forti, che si servono dei più deboli o li eliminano. Per l’antilope essere divorata dal leone non è una morte naturale, ma violenta. Tuttavia, divorare l’antilope per il leone è naturale. E definiamo «naturale» anche un sistema ecologico nel quale i leoni divorano le antilopi. Tutti i rapporti di dominio sono, così sembra, tanto naturali quanto il loro sovvertimento. Natura è «il modo in cui tutto si comporta»3.
Ora però, appartiene alla natura dell’uomo il fatto di potersi porre in rapporto con il modo in cui tutto si comporta – considerare processi naturali come il divorare e l’essere divorato tanto dal punto di vista del leone quanto da quello dell’antilope – e infine, quando sono implicati gli uomini come agenti, di determinare i criteri del giusto. Questa capacità deriva dalla proprietà della persona di stabilire un rapporto con la propria natura, con il proprio essere-così, un rapporto che abbiamo determinato come un «avere». La propria natura, il proprio essere-così, tuttavia, non è determinabile senza una relazione con tutto il resto che è come è. Relazionarsi con la propria natura significa pertanto relazionarsi con il mondo come tutto. Gli stoici hanno considerato l’identificazione con il cosmo la soluzione del problema della libertà. L’accettazione di ciò che in ogni caso accade libera l’uomo dal suo ruolo di vittima. Egli, per così dire, «interpreta» soltanto la vittima. Il vero interesse del saggio consiste nel buon esito della parte nel tutto. Dunque, se io armonizzo la mia volontà con il destino e allargo il mio interesse naturale all’autoconservazione verso un tutto la cui consistenza non è mai in ogni caso in pericolo, allora nulla accade contro la mia volontà.
La liberazione dello stoico dalla particolarità dei propri limiti naturali non è un atto di libertà, né il risultato di una libera conversione della direzione della motivazione, ma la conseguenza di una conoscenza: conoscenza della necessità, ovvero «saggezza». È il saggio, e solo il saggio, che raggiunge la libertà. La libertà dunque non è il risultato di una decisione libera per parte sua. Non la libertà personale, ma soltanto la ragione è la condizione della possibilità della liberazione.
Solo con il cristianesimo appare l’idea di una conversione al mondo, che non è la conseguenza di una nuova conoscenza, ma la sua condizione. Paolo rivolge espressamente questa idea contro la saggezza stoica. «Se io avessi tutta la saggezza – così egli scrive – se io distribuissi i miei averi ai poveri e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, non sono nulla»4. Lo stoico è pronto a tutto ciò a cui è pronto il cristiano, ma egli non ha bisogno di nessuna conversione di fondo della volontà. È la volontà naturale di autoaffermazione che alla fine, guidata dal discernimento, porta alla dilatazione cosmica del sé, al superamento della particolarità della propria natura. L’amore, al contrario, nel senso neotestamentario di agape, non significa una dilatazione cosmica dell’oikeiosis, un appropriarsi del mondo da parte del sé, ma un radicale mutamento del punto di vista, che Paolo designa con il concetto di «morte»5. Questo cambiamento significa che l’altro in quanto altro – dunque non come «parte del mio mondo» – diventa per me tanto reale e importante quanto io lo sono per me stesso. Qui sorge la possibilità di un conflitto. L’atteggiamento cristiano si distingue da quello del saggio stoico per il fatto che i cristiani pregano, anche se non insistono per la soddisfazione della preghiera. Il saggio stoico non chiede di evitare un destino avverso. Egli in generale non prega. Egli ha superato l’angoscia. Non teme la morte e si sottrae a una morte dolorosa con il suicidio. Non rinuncia alla sua volontà a favore della volontà di un altro, ma la precede se questa è più potente, per il fatto che egli già da sempre l’ha accettata come propria in ragione dell’inutilità di resisterle. Per questo non occorre nessuna decisione, nessun amore, ma soltanto discernimento.
La ragione di questa differenza è evidente. Per gli stoici, in realtà, non è in questione una volontà divina, poiché il divino non viene pensato come personale e il mondo quindi non è contingente, in quanto opera di una volontà. Il tutto non può essere altrimenti da come è e io stesso sono una parte di questo tutto. Gli esseri razionali possono comprendere di essere parti di questo tutto, conoscono la rappresentazione nella quale devono giocare un ruolo e possono per questo interpretare tale ruolo in modo consapevole. Mentre fanno questo, sono qualcosa più di mere parti, sono una cosa sola con il logos del tutto.
Le cose stanno altrimenti, laddove questo tutto sia pensato come contingente e come prodotto di un libero atto creatore. Rispetto a questo non esiste qualcosa come un discernimento nella necessità. Qui diventano possibili atteggiamenti come la domanda, la preghiera, il ringraziamento, lo stupore, il lamento, l’ostinazione, l’amore o la fiducia. Non vi è qui un’universale oikeiosis, un’identificazione dell’io con la totalità del mondo, ma, invece, la relazione con un altro immodificabile. E per questa relazione esistono due possibilità irriducibili l’una all’altra: quella dell’autoaffermazione e quella dell’autotrascendenza. In un caso l’uomo afferma la sua posizione centrale, dalla quale si lasciano derivare funzionalisticamente tutte le strutture di significazione, nell’altro caso egli riconosce che esistono un altro o molti altri centri di significazione, che non si lasciano integrare l’uno nell’altro e con cui egli può relazionarsi affermativamente così come fa con se stesso.
Laddove venga accettato un centro di significazione «assoluto», il ch...
Indice dei contenuti
- La trascendenza, «luogo» dell’umano di Leonardo Allodi
- Introduzione
- Perché parliamo di persone
- Perché chiamiamo «persone» le persone
- L’identificazione delle persone
- Il negativo
- Intenzionalità
- Trascendenza
- Finzione
- Religione
- Tempo
- Morte e «futurum exactum»
- Indipendenza dal contesto
- L’essere dei soggetti
- Anime
- Coscienza
- Riconoscimento
- Libertà
- Promessa e perdono
- Tutti gli uomini sono persone?
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Persone di Leonardo Allodi,Robert Spaemann in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Filosofia etica e morale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.