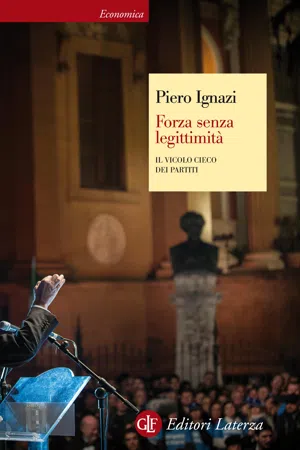III. Il «partito Stato-centrico»
Allora, perché l’innovazione più vivificante, il modello della basis demokratie introdotto dai partiti verdi, non ha «sfondato»? Per vari motivi, ma soprattutto perché le società contemporanee, nel loro complesso, non hanno seguito le sirene del post-materialismo e del suo latente narcisismo. Ne sono state attratte, tant’è che l’insieme degli atteggiamenti che ruotano attorno al desiderio/bisogno di una politica diversa si sono diffusi in tutta Europa. E in alcuni paesi i valori post-materialisti sono addirittura diventati maggioritari1. Ma questo non è bastato a modificare in profondità la politica delle democrazie avanzate, nonostante sia stata individuata anche una nuova categoria sociale in linea con i riferimenti politico-culturali post-materialisti: una categoria definita con un neologismo – i bobos, acronimo di bourgeois-bohémiens2 – che, per una volta, accomuna mondo francese e mondo anglosassone. In questo gruppo sociale si ritrovano 30-40enni con alta istruzione, con impieghi nell’amministrazione (in Francia) o nelle professioni liberali e nel management, con un buon reddito e con stili di vita disinvolti e aperti ad esperienze diverse e quindi favorevoli alla gentrification di quartieri un tempo marginali come l’11° arrondissement di Parigi, Harlem a New York, o Kreuzberg a Berlino; e infine tendenzialmente orientati a sinistra, con un occhio di riguardo per i nuovi partiti. Pur attraendo molta attenzione per la sua centralità socio-culturale, questa componente sociale non si riversa tutta su quei partiti che, in linea di principio, sarebbero più in sintonia con la loro costellazione di valori e il loro stile di vita. Non si è realizzato quell’incontro «virtuoso» che all’inizio del Novecento aveva portato le masse popolari a indirizzarsi verso i partiti socialisti, visti come unici e autentici interpreti dei loro bisogni e delle loro aspirazioni.
Nel nuovo millennio, in una epoca con articolazioni e differenziazioni socio-culturali incommensurabili rispetto agli anni Venti, era inevitabile che anche una nicchia della società come quella dei bobos non fosse tutta monopolizzabile da un partito, nemmeno dal suo più credibile interprete. Ne consegue che il serbatoio elettorale dei nuovi partiti verdi e di sinistra libertaria rimane di dimensioni ridotte. Se si prendono come riferimento le elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, le formazioni politiche verdi ottengono risultati superiori o vicini al 10% in 6 paesi su 27: in Francia, in Germania, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia e in Gran Bretagna. Ma tali consensi non si rinnovano quando si vota per i Parlamenti nazionali; in questa circostanza prevale, inevitabilmente, il voto utile, e allora la quota di elettori dei partiti verdi cala drasticamente. Solo in Germania, Belgio e Austria hanno superato il 10% dei voti nelle elezioni politiche.
Nel complesso i partiti europei hanno seguito un’altra strada, in buona parte coerente e conseguente con la loro configurazione di formazioni pigliatutti. Questa strada li ha condotti verso il «centro e lo Stato» abbandonando il territorio e rifugiandosi nelle sedi centrali nazionali e nelle assemblee rappresentative (e, al contempo, estraendo dallo Stato il massimo di risorse possibili). Già negli anni Ottanta i partiti denunciano una crescente difficoltà a reclutare nuovi membri e a mantenere avvinti quelli vecchi perché il ruolo riservato agli iscritti si è ormai ridotto a poca cosa. A questo isterilimento della funzione dell’iscritto e alla sua conseguente fuoriuscita in massa si affianca la riduzione della presenza organizzata dei partiti in termini di sedi e di strutture periferiche nel territorio. I partiti tendono a concentrare le attività e le loro risorse a livello centrale. In tal modo i dirigenti si svincolano ulteriormente dai condizionamenti della base. Inoltre si modificano i rapporti tra dirigenti di partito ed eletti: il rapporto di subordinazione degli eletti ai dirigenti di partito, un tempo ferreo, si allenta gradualmente, sia perché la separatezza è venuta meno – ed anzi seguendo l’impostazione britannica e scandinava il leader del partito è anche il capo del governo o del governo ombra –, sia perché i gruppi parlamentari (e scendendo nei livelli amministrativi, anche i gruppi consiliari a livello regionale o di grandi città) hanno acquisito risorse, e quindi autonomia, in misura tale da potersi «contrapporre» al quartier generale dei partiti. Proprio perché cambiano i rapporti tra base e vertice, con un indebolimento della base tanto in termini di presenza territoriale quanto di ruolo specifico esercitato all’interno dell’organizzazione partitica, e si registra un minore radicamento e riconoscimento del partito nella società, i partiti si sono rivolti allo Stato «sfruttandone» le risorse. Da ponti tra società e Stato i partiti sono «entrati» sempre più dentro lo Stato, diventandone quasi delle agenzie. I partiti si sono incistati nello Stato, sono diventati «Stato-centrici». Fanno parte dello Stato, lo usano e lo sfruttano. Per vivere e prosperare. Ma ad un costo, come vedremo.
Queste trasformazioni, tuttora in atto, sono meglio comprese se esaminiamo il partito scomponendolo in tre facce: il partito nel territorio, il partito nelle strutture centrali, e il partito nelle assemblee elettive3. La prima faccia, il partito nel territorio, esprime la presenza organizzata del partito in periferia attraverso le sue articolazioni di base e la membership, cioè gli iscritti; la seconda faccia, il partito nelle strutture centrali, riguarda gli organi nazionali (segreteria/direzione/comitato esecutivo et similia) e le strutture organizzative centrali, vale a dire gli uffici, il personale e le risorse che vengono utilizzate dalla leadership nazionale per far funzionare la macchina partito. La terza faccia, il partito nelle assemblee elettive, si riferisce alle rappresentanze elette ai vari livelli e a quelle strutture di servizio di cui usufruiscono i gruppi politici parlamentari, regionali e nelle grandi città.
Questa scomposizione del partito in tre facce è indispensabile per comprendere il vero stato di salute dei partiti. Infatti, i partiti hanno mostrato esiti evolutivi diversi nelle loro varie facce. Se in linea generale hanno perso iscritti e chiuso sezioni, hanno però incrementato a dismisura le loro strutture centrali e le risorse a favore dei gruppi parlamentari e consiliari. Sono cioè deperiti su un lato ma contemporaneamente si sono rafforzati sull’altro. La questione aperta è se questo travaso interno di risorse abbia mantenuto inalterate le caratteristiche e la fisionomia del partito oppure ne abbia modificato, e al limite sfregiato, l’immagine riducendone drasticamente l’appeal. O, addirittura, la legittimità. Anche le autotrasfusioni producono danni.
La faccia del territorio
Il partito nel territorio si compone di due elementi: la membership, cioè il suo bacino di tesserati e di militanti, e le strutture di base con le quali i partiti si sono impiantati localmente.
Gli iscritti
All’inizio degli anni Sessanta in tutti i paesi democratici dell’Europa occidentale più del 10% degli elettori era iscritto ad un partito4, ad eccezione della Germania e della Francia dove i membri erano meno del 3%; inoltre, in tre paesi – Svezia, Danimarca e Austria – gli iscritti superavano il 20%. Le variazioni nel tasso di adesione tra i diversi partiti erano considerevoli, e quelli di sinistra si rivelavano i più determinati nel reclutare ampie quote del loro seguito. La loro capacità di attrazione sfruttava la scia della intensa mobilitazione politica dei primi anni post-bellici, anche se già si affacciavano le prime difficoltà evidenziate dalla generale trasformazione in partiti pigliatutti. Gli effetti del mutamento si vedono negli anni Ottanta quando i tesserati scendono: appena quattro paesi superano il 10% degli iscritti in rapporto all’elettorato – e l’Italia si mantiene sulla soglia con il 9,7%. Nemmeno i paesi mediterranei giunti alla democrazia negli anni Settanta, Grecia, Portogallo e Spagna, arrivano a quella quota. Alla fine degli anni Novanta la crisi si accentua: la media degli iscritti ai partiti passa al 5%, e solo in Austria e in Finlandia i partiti reclutano più del 10% dell’elettorato. Ma la china discendente non si arresta: allargando lo sguardo a tutti i 27 paesi membri dell’Unione europea, alla fine del primo decennio del nuovo secolo soltanto Austria (ancora) e Cipro rimangono a livelli alti, a cifre a due numeri5. Tutti gli altri sono ben al di sotto, con due grandi nazioni come la Gran Bretagna e la Polonia i cui partiti attirano nelle loro fila appena l’1% dei cittadini. La media è scesa al 4,6% e, se si escludono i due casi limite di Austria e Cipro, crolla al 3,9%.
In questo quadro l’Italia ha seguito un percorso particolare. Negli anni Sessanta, benché vantassimo più di 4 milioni di iscritti non eravamo i più «politicizzati»: in molti altri paesi i partiti reclutavano una percentuale maggiore di cittadini. Nonostante una certa oleografia ci rimandi una Italia con piazze piene, con grandi manifestazioni di massa, e con una politicizzazione esasperata, in realtà viaggiavamo nel gruppo di coda.
Certo, i numeri assoluti fanno effetto perché nessun’altra nazione europea si avvicinava agli oltre 4 milioni denunciati dall’insieme dei partiti italiani: chi ci tallonava da vicino, la Gran Bretagna, arrivava a 3,2 milioni soprattutto grazie alle dimensioni ipertrofiche del partito conservatore, il più grande partito europeo degli anni Cinquanta-Sessanta con oltre 2 milioni di membri.
In Italia l’alto numero di iscritti derivava (anche) dalla competizione tra Dc e Pci per il primato nel reclutamento della membership. La Dc incomincia ad inseguire il Pci, nettamente in testa con più di 2 milioni, con la rivoluzione organizzativa introdotta dalla segreteria di Amintore Fanfani nel 1954. Non a caso già il suo mentore, Giuseppe Dossetti, aveva posto allo scudo crociato il problema della competizione con i comunisti per la conquista dell’elettorato popolare, sia attraverso politiche sociali più «avanzate» sia attraverso una più capillare ed efficiente organizzazione. Fanfani mette in pratica, seppure con diversi intendimenti, quei suggerimenti. La Dc si insedia con le proprie sezioni dovunque, crea piccole strutture di mobilitazione politica attraverso la costituzione dei «nuclei» a imitazione delle cellule comuniste, e incrementa la membership fino a toccare 1.602.929 di iscritti nel 1959. Questa cifra la avvicina al Pci, il quale tuttavia mantiene il primato benché non raggiunga più la barra dei 2 milioni dopo la crisi del 1956 (repressione della rivolta ungherese e XX Congresso del Pcus con la denuncia dei crimini di Stalin). I due maggiori partiti italiani erano in grado di raccogliere adesioni in gran numero, ma in rapporto alla popolazione, altri partiti europei si dimostravano più «efficaci» nella penetrazione presso i loro elettorati.
Alla fine degli anni Ottanta, i partiti italiani dichiarano ancora oltre 4 milioni di tessere e guadagnano qualche posizione nel confronto internazionale, ma sono ancora lontanissimi dai partiti austriaci o svedesi. Proprio alla fine della cosiddetta «Prima Repubblica» la Dc, come in una sorta di canto del cigno, arriva a superare il Pci: nel 1987 grazie ad un incremento spettacolare di quasi mezzo milione di iscritti in un anno (sic!) lo scudo crociato sorpassa il Pci e nel 1990 tocca la sua vetta massima con più di 2 milioni di tessere. Le ironie e le denunc...