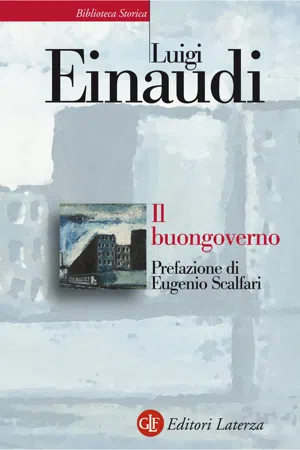II.
POLITICA ECONOMICA E SOCIALE
La parola di un settentrionale
Avevo promesso di discutere il libro del Nitti di cui ho parlato in un precedente numero de «La Stampa».
Ma la discussione richiederebbe un esame lungo e minuto delle varie argomentazioni contenute in Nord e Sud; esame poco adatto ad un giornale quotidiano.
Amo meglio esporre quale è la mia impressione di settentrionale di fronte a questo libro scritto da un meridionale, nella fede ancora che la esposizione del vero giovi alla causa della unità italiana.
Ecco pressappoco quanto potrebbe dire un settentrionale, immune da pregiudizi regionali e desideroso soltanto che la luce proveniente dall’esperienza del passato ci serva di guida per l’avvenire.
«Sì, è vero che noi settentrionali abbiamo contribuito qualcosa di meno ed abbiamo profittato di più delle spese fatte dallo stato italiano dopo la conquista dell’unità e dell’indipendenza nazionale.
«Ma se talvolta errammo per egoismo, in massima parte traemmo profitto da una serie di circostanze geografiche, storiche e sociali contro di cui sarebbe stato non solo vana ma dannosa per tutta l’Italia la resistenza.
«Peccammo, è vero, di egoismo quando il settentrione riuscì a cingere di una forte barriera doganale il territorio nazionale e ad assicurare così alle proprie industrie il monopolio del mercato meridionale. Noi riuscimmo così a fare affluire dal sud al nord una enorme quantità di ricchezza, nel momento appunto in cui la chiusura dei mercati esteri, conseguenza della nostra politica protezionista, impoveriva l’agricoltura, unica e progrediente industria del sud. Ma è giusto ricordare che noi settentrionali non saremmo riusciti a consumare il nostro peccato di egoismo protezionista se non fossimo stati aiutati dai grandi proprietari di terre a grano del mezzogiorno; i quali permisero agli industriali del nord di sfruttare i loro corregionali a patto di acquistare anch’essi il diritto di far loro pagare il pane un po’ più caro del normale.
«Le nostre città ed i nostri borghi traggono grande profitto dall’esistenza di forti guarnigioni; ma è questo un fatto strategico il quale deriva dalla conformazione geografica del nostro territorio e le cui cause debbono essere e sono infatti riconosciute giuste dagli stessi meridionali.
«Abbiamo avuto una percentuale di impiegati alti e bassi superiore al normale; ma ciò nei primi tempi era necessario per cementare l’unità nazionale con una burocrazia di stato imbevuta di spirito unitario e di devozione agli istituti governativi esistenti; ed allora questa burocrazia non si poteva trovare altrove che in Piemonte. Ora la sperequazione fra le varie regioni d’Italia va scemando a questo riguardo, per quanto ciò non sia ancora molto visibile negli alti gradi della burocrazia.
«Abbiamo spostata molta ricchezza dal sud al nord colla vendita dell’asse ecclesiastico e del demanio e coi prestiti pubblici; ma come si poteva fare altrimenti negli anni tragici che corsero dal 1860 al 1870?
«Abbiamo ottenute più costruzioni di ferrovie, di porti e di altri lavori pubblici, di scuole e di istituti governativi; ma possiamo dire con fiducia che quei denari furono spesi nel nord con maggior profitto che se fossero stati spesi nel sud. Non si può negare che, trent’anni fa, il nord d’Italia rappresentava la parte del territorio più civile e progredita. Dicendo questo noi non vogliamo muovere nessun rimprovero ai meridionali, quasi che essi fossero incapaci a raggiungere un grado di civiltà materiale e di progresso morale ed intellettuale simile al nostro. Soltanto una pseudo-sociologia ciarlatanesca può dilettarsi a distinguere due razze in Italia, l’una votata al progresso e l’altra destinata alla barbarie.
«Dicendo che il settentrione era più civile, noi vogliamo dire soltanto che per una serie di circostanze storiche (governi migliori, vicinanza alle nazioni economicamente più progredite, maggior fiducia in noi stessi, posizione geografica, atta ai rapidi e proficui scambi) noi ci trovavamo in una posizione in che la ricchezza poteva svolgersi più facilmente, si aveva maggior bisogno degli strumenti della civiltà moderna, come strade, ferrovie e si sentiva maggiore stimolo ad appropriarsi una cultura media sufficiente.
«Il fatto che qui dal Piemonte era partito l’impulso alla formazione dell’Italia nuova era causa per noi di un giustificato orgoglio e di ammirazione per i meridionali, i quali accorrevano ed accorrono ancora nel settentrione come alla sede di una civiltà più alta. Accadeva lo stesso nel mondo romano, ma in senso inverso, ed alcune fra le maggiori glorie latine venivano dai paesi del nord.
«Data questa serie di circostanze, storiche e di fatto, la applicazione dei capitali anche pubblici è riuscita nell’ultimo quarantennio più proficua nel nord che nel sud. Conveniva di più serrare le maglie della rete ferroviaria settentrionale ad intenso traffico internazionale ed interno che non fare un tronco nuovo in un paese meridionale privo di comunicazioni. Era e sarebbe ancora più utile profondere milioni nel porto di Genova, che è opera nazionale, che non spendere le migliaia di lire in un porto della costa adriatica o calabra visitato da poche navi a vela. Era più utile spendere denari per istituti di istruzione media nell’alta Italia a fine di non lasciar disperdere i frutti dell’istruzione elementare da lungo tempo iniziata, che non impiegarli nell’Italia meridionale dove mancava ancora la materia atta ad essere educata e dove la gioventù, non trovando sbocco nei commerci e nelle industrie, avrebbe languito nella burocrazia e nelle professioni liberali.
«Ma è noto altresì che le successive applicazioni di capitali non sono tutte egualmente produttive. Quando su un campo si sono già impiegati rilevanti capitali, torna più conveniente applicare i nuovi capitali non su di esso ma su nuovi campi, trascurati prima perché ritenuti troppo sterili.
«Sembra che qualcosa di simile accada già e debba accadere ancora maggiormente in avvenire riguardo alle spese di stato in Italia. Il libro del Nitti è forse l’indice che nella coscienza nazionale va maturando il convincimento che convenga rivolgere l’attenzione pubblica del settentrione al mezzogiorno. Non certo ce ne dorremo noi settentrionali. La nostra fortuna è unita con vincoli così stretti alla fortuna del mezzogiorno, che dobbiamo essere lieti che si cominci finalmente a diffondere un po’ di più il sentimento di giustizia e gli strumenti materiali ed ideali della civiltà presso i nostri fratelli del sud.
«Noi dobbiamo anzi unire i nostri sforzi agli sforzi dei meridionali per liberare l’intiero paese dalla cappa di piombo del fiscalismo e del protezionismo che, se è deleteria al mezzogiorno, è apportatrice altresì di gravi danni al settentrione.
«Anche i settentrionali cominciano a persuadersi che è durata troppo a lungo l’attuale politica doganale protezionista ed anelano al pane a buon mercato ed agli sbocchi per i loro prodotti agricoli ed industriali.
«Che i meridionali sappiano scuotere il giogo dei latifondisti gaudenti in virtù del dazio sul grano e noi saremo con loro a combattere le battaglie della libertà!
«Anche i settentrionali, quando più la loro vita economica si svolge, sentono i danni dell’attuale fiscalismo tributario opprimente ed asfissiante e sono pronti a dare la mano ai meridionali perché ad essi le imposte sui fabbricati, sulla ricchezza mobile e sugli affari non portino via i frutti, già tassati e gravemente tassati, dell’agricoltura.
«Anche i settentrionali sono stanchi di vedere accrescersi senza fine il numero degli istituti di istruzione puramente classica e sarebbero lieti di cooperare coi meridionali alla creazione di tipi svariati di istituti scolastici, diversi da regione a regione a seconda dei bisogni locali e adatti a fornire i veri duci del movimento economico italiano.
«Né è difficile persuadere le classi operaie del settentrione che esse hanno maggior interesse ad avere il pane ed il vino a buon mercato che non pensioni pagate da uno stato minacciato dalla bancarotta e clausole di salario minimo utili a pochi privilegiati, e che esse hanno interesse a favorire tutte quelle libertà economiche e tributarie che valgano a migliorare le sorti degli agricoltori meridionali ed a mettere in grado questi ultimi di consumare in maggior copia i prodotti delle industrie del nord.»
Nella lettera dedicatoria al senatore Luigi Roux, il Nitti scrive: «Tu sei nato nell’estremo nord della penisola ed io nell’estremo sud: poiché non sei sospetto, vuoi tu aiutarmi in un’opera di verità, che è diretta a mostrare un pericolo vero, ma anche a dimostrare che si deve aver fede nell’avvenire?».
Se sono riuscito in quest’articolo ad esprimere l’opinione dei settentrionali alieni da pregiudizi di regione, parmi poter conchiudere che l’invito del Nitti sarà ascoltato non solo dal direttore di questo giornale, ma da tutti i settentrionali, i quali abbiano la coscienza della necessità di mantenere l’unità nazionale diffondendo il bene con giustizia in tutte le parti del paese.
(«La Stampa», 23 giugno 1900.)
Il giusto prezzo
Un recente decreto ha risuscitato una vecchia idea che nel medio evo era diffusissima, esposta nei libri dei sapienti ecclesiastici, inculcata da papi e bandita da prìncipi; ma poi venne in discredito per merito o colpa degli economisti, i quali la posero in ridicolo in modo che parve non dovesse risuscitare mai più: l’idea del giusto prezzo. Oggi quella idea o quella parola risorge a vita legislativa e la vediamo introdotta nel testo di un decreto.
Naturalmente, la introduce senza definirla, perché egli ben sa che, se avesse dovuto definire l’idea del giusto prezzo, avrebbe incontrato difficoltà insuperabili. Perciò preferisce lavarsene le mani e lasciare il compito dell’applicazione a prefetti, sindaci, commissioni che, almeno, avranno quasi sempre il beneficio di ignorare le discussioni fattesi in passato sull’argomento e se faranno molte sciocchezze, le faranno nella più perfetta e candidissima buona fede.
Già i prezzi «giusti» sanciti negli innumerevoli calmieri pullulati improvvisamente di questi giorni in Italia stanno producendo i loro soliti inevitabili effetti. Ogni sindaco ha una sua propria idea di quello che sia il «giusto» prezzo delle uova: qua 2, là 3, altrove 4 lire la dozzina. E di nuovo si verifica il medesimo inevitabile fatto che s’era visto durante la guerra: che le uova tendono ad andare dove il prezzo è a 4 o forse a non andare in nessun posto, se i contadini non ritengono quel prezzo remunerativo. Per non far rimanere le città senza uova, si decretano requisizioni nei depositi esistenti, consumando le riserve per l’inverno; si stabiliscono divieti di esportazione da città a città, da provincia a provincia; si ricrea quella bardatura di guerra, che tanto fastidio aveva dato e tanti inconvenienti aveva prodotto, sicché s’era tirato un gran respiro quando appena avevamo cominciato a liberarcene.
In verità la storia non è davvero maestra della vita, se gli uomini si scordano dei suoi ammaestramenti a distanza appena di due anni, di tre anni! Chi non rabbrividiva, al ricordo delle code che appena ora andavano scomparendo? Ed ora le code torneranno, e più lunghe, più irritanti, più fastidiose di prima. Effetto inevitabile dell’idea del giusto prezzo, tanto difficile a definirsi, che nessuno vorrà interpretarla nello stesso modo del vicino.
Se si cerca di dare a quell’idea un contenuto, si possono avere parecchie soluzioni fondamentalmente diverse. Per molti, il «giusto» prezzo è quello che il consumatore «può» pagare, dati i suoi mezzi, senza essere ridotto a privazioni eccessive. Ma, cosi interpretata, l’idea è assurda; perché i mezzi dei consumatori sono diversissimi, e quello che l’uno può agevolmente pagare diventa un prezzo insopportabile per un altro. L’impiegato a 300 lire al mese, che deve mandare agli studi i figli, come può pagare il prezzo che agevolmente paga l’operaio con 20 lire al giorno e con il figlio che già lavora e porta denari in casa? Il professionista, con 20.000 lire all’anno come può pagare i prezzi che sono comodissimi all’arricchito di guerra? Considereremo come «giusto» il prezzo che può pagare il più povero dei consumatori, il lavoratore con 5 lire al giorno, supponendo che di queste arabe-fenici ce ne siano ancora, od il pensionato o la vedova con piccolo reddito di 100 lire al mese come, purtroppo, ce ne sono moltissime? Vorremo cioè dei prezzi giusti per la piccola-borghesia, questa ormai ultima tra le classi sociali, la quale ha dato tanti figli alla patria e non trova neppure la forza di attirare su di sé l’attenzione dei governi, ipnotizzati da quel proletariato industriale che dalla guerra non subì certo alcun danno economico? Andremo incontro, così facendo, a due inconvenienti: il primo, che quei prezzi giusti per la piccola borghesia saranno troppo bassi per gli operai e bassissimi per gli industriali, i commercianti, i professionisti agiati; il secondo, che per lo più quei prezzi saranno inferiori al costo di produzione e faranno sì che i produttori non avranno più convenienza prima a vendere e poi a produrre. Quei prezzi organizzeranno la carestia che è un malanno assai peggiore degli alti prezzi.
Altri riterrà che «giusto» prezzo sia quello che compensa le oneste fatiche del produttore, abolendo i profitti degli speculatori e dei commercianti; quel prezzo che dà al contadino un compenso equo per l’allevamento delle galline, la raccolta delle uova ed il trasporto al mercato, senza alcuna aggiunta, neppure del fitto della terra al proprietario fondiario. Anche questa interpretazione praticamente è assurda. Non vi sono due costi di produrre la medesima merce i quali sieno uguali l’uno all’altro. In un caso la terra è fertile, nell’altro è sterile; l’una è bene esposta, a mezzogiorno, l’altra, a mezzanotte, non vede quasi mai il sole; l’una è bassa, soggetta ad umidità, alla ruggine, all’allettamento dei cereali, l’altra è asciutta e ventosa; l’una patisce la siccità e l’altra gode di una regolare irrigazione. Peggio, se si guarda agli elementi personali della produzione. Vi è il contadino o la contadina intelligente, laboriosa, atta ad utilizzare tutti i sottoprodotti ed i residui, la quale ha tornaconto, anche oggi, a vendere le uova a 3 lire. La vicina sua tuttodì si lamenta di non riuscire a rifornire la tavola di sale, olio, condimenti – si sa che in campagna la vendita delle uova e dei prodotti della bassa corte deve servire a provvedere alle minori spese della tavola ed alle minute spese della massaia – anche se vende le uova a 5 lire. Le sue galline vengono su male, i pulcini muoiono, le uova sono deposte in luoghi inaccessibili, sono poche, non si trovano, la gallina se le mangia dopo averle fatte ecc. ecc. Quale sarà il prezzo giusto per il produttore? Saranno le 10 lire al metro che bastano a dare un profitto all’industriale abile, che sa organizzare bene la intrapresa, che compra bene la lana e colloca meglio i tessuti, che paga convenientemente gli operai e sa tenerseli affezionati o saranno le 20 lire le quali non sono neppure sufficienti a salvare dalla rovina il suo concorrente, incapace, presuntuoso, litigioso, i cui operai lavorano male perché non bene guidati, che sbaglia comprando la lana quando è al massimo e sbaglia vendendo quando è costretto a far fronte ad una scadenza imminente di cambiale? Se il prezzo giusto è di 10, non sarà ancora eccessivo, postoché esso lascia un «profitto» all’industriale intelligente? Se glielo toglieremo, che vantaggio avrà ancora costui ad essere intelligente, invece che stupido?
Sia che il «giusto» prezzo si voglia stabilire sulla base dei bisogni dei consumatori o su quella dei costi del produttore, esso dunque porta al caos, alla confusione delle lingue ed è affatto inapplicabile.
Per molti, l’idea del giusto prezzo si connette con la consuetudine. Gli uomini sono abitudinari; non amano le variazioni improvvise. Erano abituati a pagare le uova in media, tra la state ed il verno, 2 lire la dozzina e si inquietano vedendo le uova andare su e giù. Avrebbero anche, probabilmente, i consumatori, considerato ingiusto pagarle solo 50 centesimi; e reputano ingiustissimo pagarle oggi 5 o 6 o 7 lire. Circostanza interessante, gli economisti partecipano a questa aspirazione degli uomini. Anch’essi ritengono desiderabile che i prezzi in generale – non i singoli prezzi, che è cosa impossibile – subiscano poche variazioni. Ma gli economisti aggiungono – ciò che il popolo ed i prefetti ed i sindaci quasi sempre dimenticano – che per ottenere tale desiderabile risultato sarebbe necessario possedere una moneta la quale avesse una potenza d’acquisto costante. E da tempo gli economisti vanno alla cerca di questa moneta; né si può dire che i loro studi siano rimasti infruttuosi, sebbene per ora immaturi all’applicazione.
Oggi, però, non esiste in Italia, né altrove, una moneta avente una capacità di acquisto costante. Quando gli uomini parlano di 2 lire come di un prezzo «giusto» per la dozzina d’uova, intendono riferirsi alla unità monetaria lira, quale s’usava un tempo e con la quale sempre s’era usato comprare le dozzine d’uova. Ma la lira d’oggi è una cosa ben diversa dalla lira di prima della guerra. Da una interessante relazione dell’on. Alessio alla giunta generale del bilancio ricavasi che le lire, ossia i pezzi di carta circolanti con questo nome, erano 3593 milioni al 31 dicembre 1914 ed erano salite a 12.274 al 31 dicembre 1918. Probabilmente ora abbiamo superato i 13.000 milioni. Come è possibile che la lira, di cui ci sono ora 13.000 milioni di unità, sia la stessa cosa della lira di cui ce n’erano solo 3593 milioni di unità? Essa è una cosa tutt’affatto diversa. Essa è deprezzata, precisamente come lo sarebbero tutte le merci di cui si producesse una quantità strabocchevolmente più grande di prima. Non è evidente perciò che l’idea che il prezzo «giusto» delle uova sia di 2 lire la dozzina, è un’idea ragionevole finché le unità di moneta con cui le uova si cambiano rimangono suppergiù di 3593 milioni – centinaia di milioni più o meno non monta –; ma diventa un’idea priva di senso quando, non essendo cresciute nel frattempo né galline né uova, le unità di moneta quasi si quadruplicano, diventando 13.000 milioni? La lira, sia di carta o d’oro, non ha nessun valore fisso, immutabile. Come tutte le altre merci, vale più o meno a seconda che essa è meno o più abbondante. L’arte di governo sta nel farne variare lentamente e con accortezza la massa circola...