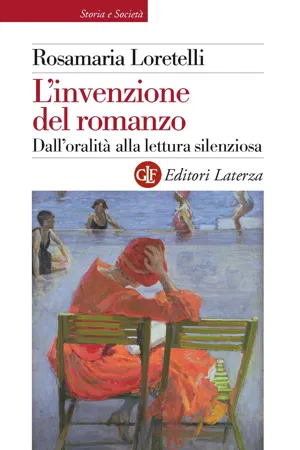
- 272 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento nasce una forma letteraria nuova che si impone come il canone contemporaneo: il romanzo. La sua invenzione coincide con il passaggio dalla lettura orale e collettiva a quella silenziosa e individuale. E trasforma il nostro modo di pensare la realtà: da quel momento il racconto diventa lo stesso universo mentale degli uomini occidentali. La storia di una trasformazione essenziale per la nostra civiltà che coinvolge tutti i lettori di romanzi ma non solo.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'invenzione del romanzo di Rosamaria Loretelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Critica letteraria. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
LetteraturaCategoria
Critica letterariaIII. I racconti e la voce
L’epica orale
Nel primo libro dell’Odissea, la dea Atena giunge a Itaca nelle vesti di Mente, il capo dei Tafi, e trova i pretendenti di Penelope che giocano davanti all’ingresso del palazzo in attesa del banchetto. Vedendo l’uomo sulla soglia, Telemaco gli muove incontro: non ha riconosciuto la dea, e tributa a colui che crede solo un viandante di rango gli onori dovuti agli ospiti. Lo invita a sedere su un seggio coperto da un panno di lino ricamato, con uno sgabello per i piedi; gli fa versare da una brocca d’oro l’acqua sulle mani e porre innanzi una mensa pulita con pane, vino e molte vivande.
Il figlio di Ulisse ha condotto l’ospite in un luogo appartato della sala, affinché egli «disgustato dal chiasso, / non s’annoiasse del pranzo, a stare tra gente villana, / e anche per chiedere del padre lontano». I pretendenti «superbi» (questo è l’epiteto che li accompagna nel testo omerico) infatti ora mangiano e schiamazzano. Poi, sazi, «altro piacque loro nel cuore, / musica e danza: essi sono ornamento del banchetto. / Pose l’araldo la cetra bellissima in mano / a Femio, il quale cantava per i pretendenti, costretto. / Dunque, tentando le corde, principiò bel cantare; / e intanto parlava Telemaco ad Atena occhio azzurro, / avvicinando la testa perché non sentissero gli altri»1. Mentre Telemaco parla con l’ospite, risuona nella sala il chiasso dei pretendenti e poi si leva la voce di Femio, l’aedo fedele a Ulisse costretto a cantare per loro.
Altri cantori sono presenti ai quattro banchetti nei primi otto libri dell’Odissea: durante uno di questi Telemaco è al palazzo di Menelao, dove trova un «divino» cantore che suona la cetra mentre due acrobati roteano nel mezzo della stanza; in un altro Ulisse è da Alcinóo presso i Feaci e il canto accompagna «giovani nel primo fiore», esperti di danza, che battono «coi piedi il ritmo divino»2.
Ma che cosa erano quei canti che non risuonavano nei teatri ma si intersecavano con la vita quotidiana, senza interromperla? Erano, si sa, racconti epici proprio come l’Odissea, creati all’atto stesso della loro esecuzione davanti a un pubblico.
Fu una pratica molto più diffusa e longeva di quanto non si pensi, tanto che l’antropologo John M. Foley poté assistere nel 1973 a uno di questi eventi a Tršić, un villaggio della Serbia con alti tassi di analfabetismo. Era stato avvertito che un determinato giorno lì sarebbe stato eseguito un canto e vi si era recato per registrarlo, trovando il guslar (cantore epico) seduto su un tavolo sotto un olmo. Attorniato da circa due dozzine di spettatori, egli cantava di una battaglia degli inizi del Ventesimo secolo combattuta dai Serbi con grande valore e si accompagnava con il gusle, strumento a una sola corda dalla melodia lamentosa, quasi urlando la sua poesia che narrava di gesta grandiose di eroi e di cavalli al ritmo del pentametro, con ripetizioni e formule.
La sua era una vera e propria recitazione, che impiegava al massimo l’espressività della voce e del corpo. Il pubblico assisteva comportandosi nei modi più diversi: c’era chi gironzolava senza apparentemente prestare attenzione, chi ascoltava intento, chi si mostrava addirittura rapito. Qualcuno proponeva versi in alternativa; qualcuno commentava i fatti; qualcuno, preso dall’entusiasmo, si faceva egli stesso attore della performance, come quel vecchio che a un certo punto del canto esibì con uno strattone il bavero della giacca, mostrando orgoglioso le medaglie al coraggio da lui guadagnate in guerra3.
I canti degli aedi nell’Odissea erano simili a questo e a quelli degli altri guslar di cui parla Foley4. Simili erano le modalità della loro composizione e trasmissione: racconti epici, tutti quanti, composti all’atto della comunicazione orale, proprio come l’Odissea appunto, che prima di venire fissata nella scrittura fu tramandata per secoli solo dai cantori.
La storia degli studi che hanno fatto conoscere i modi della composizione e della trasmissione orale inizia negli anni Venti del Novecento con le tesi di master e di dottorato del giovane classicista Milman Parry. L’argomento erano i poemi omerici, allora al centro di una ‘questione omerica’ giunta a un punto morto, con il campo diviso tra gli ‘analisti’, cioè quegli studiosi che affermavano che l’Iliade e l’Odissea erano opere di uno o più compilatori i quali avevano radunato e fuso parti composte da altri; e gli ‘unitari’, che sostenevano invece l’esistenza di un unico e geniale autore. Parry non accettò né l’una né l’altra tesi, convinto che i poemi omerici fossero in realtà creazioni stratificate, lascito collettivo di generazioni di poeti. Già a quello stadio della sua ricerca egli mostrava che in quei poemi erano presenti dei moduli fissi, dei sintagmi ripetuti, che definì «formule», senza però ancora metterle in relazione con la trasmissione orale dei poemi.
Questo fu solo l’inizio. Ben presto cominciò a parlare di oralità, e lo fece dopo aver messo a confronto le sue ricerche sui poemi omerici con i risultati di altre ricerche effettuate nell’Asia centrale e nei Balcani: proprio quelle caratteristiche strutturali che egli aveva notato nei testi omerici erano tipiche anche della poesia orale contemporanea di quelle zone. La nebbia attorno alla creazione dell’Iliade e dell’Odissea si cominciava così a diradare, e proprio grazie a quanto era stato osservato sulla composizione dei poemi orali dell’Est europeo.
Occorreva però una verifica, e Parry la fece tra il 1933 e il 1935, percorrendo con il suo allievo Albert Lord e con un guslar che serviva da interprete alcune zone di quella che allora era la Jugoslavia e registrando centinaia di canti epici, in base ai quali poté precisare la sua teoria. Questi canti costituiscono il nucleo originario della Milman Parry Collection of Oral Literature dell’Università di Harvard, su cui hanno lavorato e tuttora lavorano centinaia di studiosi.
Ne conseguì una precisa definizione dell’epica orale come di un «racconto in poesia che si è andato trasformando attraverso molte generazioni di cantori che non sapevano scrivere»5 e che si caratterizza per il ruolo fondamentale giocato dal contesto dell’enunciazione e dalla memoria del cantore, nonché per la concomitanza temporale tra composizione e trasmissione, che rende impossibile apportare correzioni tornando indietro. Questi sono i fattori che determinano la superficie linguistica e l’organizzazione narrativa dell’epica orale.
Il primo, il contesto dell’enunciazione, gioca un ruolo immenso. Mittente e destinatario sono compresenti in una situazione interattiva, partecipata e ‘calda’, che consente al cantore di modificare il racconto a seconda degli umori percepiti nell’uditorio, espandendolo o abbreviandolo per non perdere ascoltatori e per attirarne di nuovi.
Di fronte ha sempre individui reali, che interagiscono sia con lui che tra di loro: sono, insomma, attori essi stessi dell’evento. «Nella concreta realtà del canto, l’uditorio svolgeva in ogni successivo momento un ruolo molto più ampio e determinante di quanto non immaginassi prima»6, scopre Foley a Tršić, osservando il pubblico che interloquiva con il guslar, che lo incitava e ne indirizzava il canto. Una parte di questo pubblico, tuttavia, era distratta o ascoltava in modo intermittente, perché tali canti si inseriscono comunque nella vita quotidiana indaffarata, che non può essere sospesa del tutto e alla quale chi narra strappa il suo uditorio.
A differenza degli odierni spettacoli teatrali, l’epica orale raramente aveva spazi e tempi suoi propri. Mentre Femio canta, i Proci mangiano e Telemaco conversa con il suo ospite; gli ascoltatori vanno e vengono sotto l’albero a Tršić; la gente prende accordi e fa affari nella taverna in Jugoslavia che Albert Lord usa per una sua indagine7. Se i cantori sono bravi, riusciranno ad attirare l’attenzione di quel pubblico intermittente, lo sottrarranno, seppur temporaneamente, alle altre incombenze e lo tratterranno presso di sé, attento e partecipe. Ma non vige una regola del luogo, non c’è l’impegno tacito che ci si assume entrando in un teatro: tutto dipende dall’abilità di chi canta e dalla sua capacità di ammaliare.
D’altronde, attirare l’attenzione di un pubblico potenziale e incatenarlo alla propria opera non è forse quanto ogni artista desidera? E quanto anche i romanzieri ricercano? Solo che il cantore ha delle frecce al suo arco che non stanno nella faretra del romanziere: per comunicare, suscitare interesse e coinvolgere, egli non dispone unicamente del linguaggio verbale. Se fondamentali sono infatti il tipo di storia che racconta, la scelta dei termini, la presentazione dei personaggi, l’ordine degli episodi; essenziali forse ancor più sono i suoi gesti, le espressioni del volto, i toni della voce, il suono e i silenzi; eventualmente i costumi e la danza8. Conta pure il tipo di uditorio di quella particolare esecuzione, in sé unica come lo sono tutte, con l’atmosfera che vi si crea e con le emozioni che corrono tra i presenti. Insomma, a differenza del romanz...
Indice dei contenuti
- I. Leggere
- II. La lettura ha una storia
- III. I racconti e la voce
- IV. Il romanzo inventato
- V. Forma simbolica
- Ringraziamenti