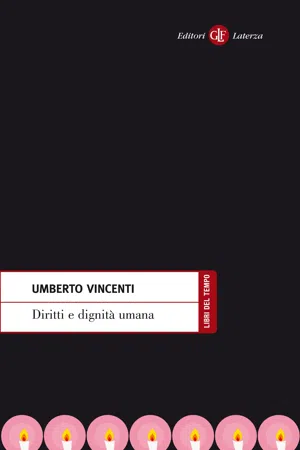
- 172 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Diritti e dignità umana
Informazioni su questo libro
Il legame tra diritti e dignità umana è un punto fermo nel pensiero giuridico corrente, fondato sul postulato che tutti gli uomini siano egualmente degni e si debbano reciproco rispetto per la comune umanità. Ma a questa accezione 'genetica' e ugualitaria della dignità umana, oggi prevalente, si sono contrapposte storicamente concezioni diverse, elitarie e subordinate all'esito dell'azione individuale. Umberto Vincenti risale alle origini classiche del concetto di dignitas hominis e ne ricostruisce il lungo percorso, fino alla odierna formulazione dei diritti: umani, inviolabili, fondamentali, della personalità.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
DirittoCategoria
Storia giuridicaII. Dalla dignità ai diritti
1. Genesi ed evoluzione del sistema dei diritti
a) Fondazione dei diritti in Hobbes, Locke, Rousseau: l’alternativa legge-natura
L’idea che il possesso giuridico possa avere a proprio oggetto non soltanto le cose materiali, quelle apprensibili con la mano, ma anche le res incorporales, le cose intangibili quali gli iura, i diritti, è un’idea ascrivibile al pensiero dei giuristi romani: nelle fonti ricorre in proposito l’espressione di possessio iuris1, possesso del diritto, dei diritti, altrimenti qualificato, in quanto avente a oggetto cose immateriali, come quasi possessio2, proprio perché il vero possesso è rigorosamente fattuale e risolventesi nella disponibilità di una cosa ‘che si può toccare’. Ma i diritti non si possono toccare; e tuttavia nel mondo creato dallo ius l’uomo non ha e tiene per sé solo le cose tangibili, ma pure i diritti, a cominciare da quelli relativi alle cose materiali, dalla proprietà alle servitù, all’usufrutto, all’uso.
È un modulo, questo, dell’avere o possedere (non res ma) diritti, che il pensiero giuridico moderno e contemporaneo ha esteso utilmente – dai diritti inerenti alle cose (i diritti reali appena menzionati) – alla titolarità, effettivamente goduta o, a seconda dei casi, (solo) rivendicata, dei diritti della persona, o dell’uomo, appunto dei diritti tout court, espressione generica o, addirittura, vaga con la quale si tende comunque a far riferimento a pretese di tutela afferenti beni non tanto (o esclusivamente) materiali, quanto relativi alla vita, alla sua integrità fisica e morale, alla dimensione di libertà e di eguaglianza in cui ogni esistenza deve oggi potersi esplicare e via di questo passo. Il che, si potrebbe aggiungere, coincide con la trasposizione dell’homo in sé nella dimensione giuridica che lo rende propriamente persona3 o, come qualcuno dice, homo iuridicus4.
Del modulo romano della possessio iuris o possesso dei diritti si appropria, per esempio, Kant che nella Metafisica dei costumi distingue appunto tra «possesso intellegibile (possessio noumenon)» e «possesso empirico (la possessione)»: se quest’ultimo ci rappresenta la disponibilità fisica di una cosa, il primo postula una conoscenza del suo oggetto mediante un atto esclusivamente intellettivo5. Il che è proprio quanto accade con i diritti a cominciare dal loro prototipo, il dominium o proprietà (che è altro, si è prima osservato, dalla cosa su cui esso insiste).
Ma l’homo in sé (l’uomo naturale, si potrebbe dire) e la sua duplicazione nell’artificialità giuridica, l’homo iuridicus, quali e quanti diritti è oggi giunto a possedere?
Da Grozio in avanti la ricerca e l’individuazione di questi diritti scaturiscono dalla dialettica tra ius naturale e ius civile, formazioni normative, il primo, dello stato di natura in cui gli uomini si sarebbero venuti primieramente a trovare, il secondo, dello stato o società civile a cui gli uomini sarebbero approdati in conseguenza di un patto o contratto comune stipulato per la protezione dei diritti naturali (quelli che gli uomini hanno innati nello stato di natura) e fonte, a sua volta, di possibili nuovi diritti (i diritti dell’uomo entrato in societate o in civitate). La dialettica diritti naturali-diritti civili è anch’essa di ascendenza classica e perfettamente sintetizzata in un manuale giuridico come le Istituzioni di Giustiniano, destinato a grande fortuna con la riscoperta del diritto romano avvenuta a partire dalla fine dell’XI secolo6:
Così è più opportuno prendere le mosse dal diritto più antico. È risaputo che il diritto naturale è il più antico, giacché la natura lo ha prodotto insieme allo stesso genere umano; mentre i diritti civili ebbero origine quando cominciarono a fondarsi le città, a crearsi i magistrati e a scriversi leggi7.
Lo stato di natura sarà assunto da Hobbes (al fine di consentire, prima, il passaggio allo stato civile o artificiale o Leviatano, poi la costruzione del medesimo) senza alcuna pretesa circa la sua collocazione storica, come struttura metafisica che avrebbe, però, temporalmente preceduto la convivenza civile8. Hobbes, anzi, esclude la storicità dello stato di natura la cui valenza, nella teorizzazione dello Stato assoluto da lui perseguita, è quella di una premessa ipotetica atta a fondare, appunto, lo stato civile: una fondazione razionalmente, deduttivamente, necessaria per porre fine all’irrazionalità della guerra universale, inevitabile conseguenza del diritto naturale di ogni uomo su tutte le cose (ius omnium in omnia), quali egli può conquistare e difendere con tutti i mezzi9. Per questo ciascuno e tutti insieme rinunciano a questo illimitato diritto naturale in omnia in favore di un uomo o un’assemblea così originando lo stato civile: «grazie a questa autorità datagli da ogni singolo uomo dello Stato» – precisa a proposito Hobbes – «egli [il Leviatano] dispone di tanta potenza e di tanta forza a lui conferite, che col terrore da esse suscitato è in grado di modellare le volontà di tutti i singoli in funzione della pace, in patria, e dell’aiuto reciproco contro i nemici di fuori»10.
In questo contesto di convivenza civile dominato dall’autorità pubblica i diritti dei cittadini sono tutti e soltanto quelli introdotti e modulati dalla legge civile: sicché in Hobbes, come sarà in Kant, i diritti sono solo quelli legali11, dovendosi però avvertire che per Hobbes la rigorosa funzionalizzazione dello Stato al mantenimento della pace e dell’ordine poteva esigere, a garanzia della vita dei cittadini, la negazione di qualunque diritto12. Anzi, la ferrea logica geometrica di Hobbes assegnava all’autorità pubblica il potere di disporre dello stesso bene della vita dei sudditi, per vero l’unico diritto naturale mantenuto da questi ultimi in societate e, tuttavia, condizionato alla volontà dell’autorità sovrana, interprete, anzi, arbitra delle circostanze13. La conseguenza non è, a ben vedere, per niente contraddittoria perché con il contratto sociale tutti hanno conferito alle medesime condizioni il sommo potere all’autorità pubblica e qualunque patto deve essere mantenuto e rispettato da tutti i contraenti in quanto così prescrive (tra l’altro) proprio la legge naturale.
Il rigore della costruzione hobbesiana non può, però, occultare il paradosso a cui nei fatti essa perviene: si esce dall’insostenibile stato di natura per garantirsi la sopravvivenza e tuttavia la sopravvivenza viene a dipendere, nello stato civile, dalla decisione del sovrano contro il quale non è assolutamente consentita la ribellione in ossequio alla già evocata legge di natura che esige la stretta osservanza del patto fondativo dello Stato14. È un paradosso a cui ancora corrisponde la struttura dello Stato contemporaneo ove la misura del giusto e dell’ingiusto, dei diritti come dei torti, è affidata alla legge espressione di una volontà comunque indiscutibile, seppur formatasi democraticamente.
Resta così confermato che, nel pensiero del maggior teorico della moderna statualità, la riduzione, o la costrizione, dei diritti nell’alveo della legge, si pone come un postulato irrinunciabile perché da esso dipende la tenuta dello Stato e la realizzazione della sua primaria funzione istituzionale (il mantenimento dell’ordine pubblico).
La dialettica diritti naturali-diritti civili agisce diversamente nel pensiero di Locke: come si è già osservato [cap. I, par. 4 b)], l’uomo si porta nello stato civile tutti i suoi diritti naturali, riducibili, peraltro, nell’unum della proprietà; e il passaggio è determinato solo dall’esigenza di tutelare al meglio quei diritti, affidando la soluzione delle inevitabili controversie alla valutazione di giudici imparziali15. La prospettiva lockiana è, dunque, alquanto diversa: esistono dei diritti precedenti lo Stato e le sue leggi ed essi non possono essere aggrediti o menomati da queste istituzioni civili in quanto una tale vicenda contraddirebbe insanabilmente la causa del contratto sociale liberando i cives da ogni impegno e legittimandoli, pertanto, alla resistenza e al sovvertimento dell’autorità oppressiva16.
Rousseau, invece, accetta il modulo hobbesiano dell’identificazione dei diritti nella legge17. Egli, a differenza di Hobbes, pensa che sia proprio la società civile, dominata dal desiderio infinito dell’appropriazione esclusiva alla base dell’istituto della proprietà, la causa dell’infelicità e dell’ineguaglianza fra gli uomini18. La constatazione rousseauiana prende così le mosse dalle miserie dello stato civile e propugna l’imitazione dello stato di natura che, se pur mai esistito, costituisce una m...
Indice dei contenuti
- Premessa
- Introduzione
- I. Dignità e valore
- II. Dalla dignità ai diritti
- III. Retorica dei diritti e della dignità
- IV. Quale dignità?
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Diritti e dignità umana di Umberto Vincenti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Diritto e Storia giuridica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.