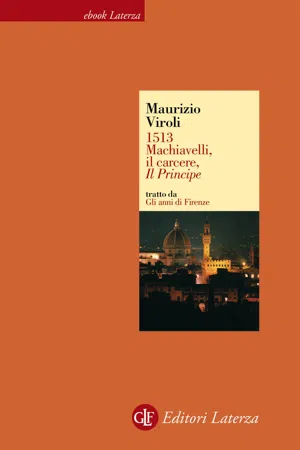1513. Machiavelli, il carcere, «Il Principe»
di Maurizio Viroli
Il 1513 è l’anno del consolidamento del regime mediceo su Firenze che porterà, tranne per la breve parentesi dell’ultimo governo repubblicano (1527-30), al principato di Cosimo I, granduca di Toscana, ed è anche l’anno in cui Machiavelli compone Il Principe, o almeno gran parte di esso, e mette mano ai Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. Dall’amara esperienza della morte della repubblica, che tagliò la sua vita in due, Machiavelli trasse lo stimolo, con la forza che è propria dei grandi, per scrivere pagine che affida a qualcuno che sappia riscattare la libertà repubblicana e la libertà e dignità dell’Italia. È una storia lontana nel tempo, ma vicina per il suo significato morale e politico. Essa racchiude infatti ammonimenti chiari come il sole su come e perché una repubblica muore, e ci rammenta i princìpi che devono vivere nell’animo dei cittadini per conquistare e difendere la libertà.
Prima di entrare nella narrazione vera e propria, è necessario porre la domanda se sia lecito parlare di transizione politica da una forma di governo a un’altra, dalla repubblica al principato, per ripetere il titolo del vecchio, ma ancora essenziale libro di Rudolf von Albertini. Nel 1513 una vera transizione politica, in senso istituzionale non c’è ancora stata. Per assistere alla nascita del principato mediceo bisogna attendere il 1537, quando Cosimo de’ Medici assume il titolo di granduca di Firenze, ma nel 1513 l’instaurazione del potere di fatto dei Medici sulla città, pianta solidamente le basi del nuovo regime politico. Invece di parlare di transizione dalla libertà repubblicana alla larvata o mascherata tirannide dei Medici, si deve allora parlare di un semplice passaggio di potere da un gruppo di famiglie a un altro capeggiato dai Medici? Di questa idea era ad esempio Mario Martelli, studioso insigne che voglio qui ricordare. Nell’Introduzione al Principe per l’Edizione Nazionale delle Opere di Machiavelli egli parla del governo repubblicano che resse Firenze dal 1494 al 1512 come del «feticcio [...] delle libertà repubblicane», «le libertà, per dirlo apertamente, della sessantina di famiglie ottimatizie, e, pertanto la coperta e dura intenzione di quelle famiglie di poter fare tutto a lor modo». Dall’altra parte, è sempre il giudizio di Martelli, stava «la determinazione dei Medici di essere in città molto più di quello che erano stati a tempo di Cosimo e di Lorenzo Vecchio, di vendicarsi, di recuperare le ricchezze perdute». Altro che scontro fra tiranni e popolo, si trattava, molto più prosaicamente, di un conflitto all’interno dei beneficiati, ossia una lotta all’interno di quella piccola parte del popolo – fatta di famiglie e consorterie strette da vincoli di affari – che tradizionalmente si spartiva gli utili e gli onori dello Stato. Dietro alle parole altisonanti di «popolo», «repubblica», «libertà», c’era solo, da una parte e dall’altra, la brama di ricchezze e di potere.
Anche alcuni fra i più avveduti scrittori politici fiorentini del tempo attenuarono il contrasto fra il regime repubblicano del 1494-1512 e il regime dei Medici. Francesco Guicciardini, nel Dialogo del reggimento di Firenze, che compone nel 1520, fa dire al suo «portavoce», Bernardo del Nero, che la libertà proclamata dai sostenitori del governo popolare non era nient’altro che un nome, di cui l’apparenza e l’immagine hanno il compito di illudere e di confondere circa le vere intenzioni dei governanti, perché «i potenti spesso usano il nome della libertà per ingannare gli altri», e «la maggioranza di coloro che predicano la libertà» si precipiterebbero ad unirsi ad un regime ristretto o elitario «se pensassero che ciò gli giovasse di più». Scrive anche, sempre a proposito della Repubblica del 1494-1512, che «sonvi di molti cittadini che arebbono a partecipare dello utile e vi sono pochi guadagni da distribuire. E però sempre una parte si è sforzata governare et avere li onori et utili e l’altra è stata da canto a vedere e dire il giuoco». Francesco Vettori arriva addirittura a scrivere che c’è «poca differenzia da quello stato che molti chiamano tirannico a questo che al presente chiamano populare o vero republica». Anche Machiavelli, del resto, ammette che Firenze ha sempre variato spesso nei suoi governi perché «in quella non è stato mai né republica né principato che abbi avute le debite qualità sue», e tutti i difetti nascevano dal fatto che «le riforme di quegli stati» erano fatte «non a satisfazione del bene comune, ma a corroborazione e securtà della parte: la quale securtà non si è anche trovata, per esservi sempre stata una parte malcontenta, la quale è stata un gagliardissimo instrumento a chi ha desiderato variare».
Sono giudizi da meditare con attenzione per non credere a cuor leggero alle raffigurazioni retoriche della lotta politica. Ma nelle parole di Guicciardini e Vettori riaffiora il luogo comune dei conservatori contro la libertà, quello che Albert Hirschman nel suo studio The Rhetoric of Reaction ha descritto come l’argomento della futilità: fra libertà e tirannide c’è poca differenz...