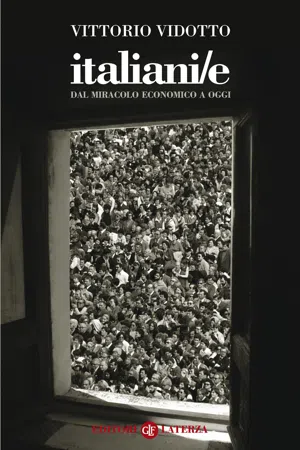
- 168 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Le battaglie, le conquiste, le trasformazioni, le permanenze: un racconto lucido e serrato della società italiana nella storia di questi ultimi quarant'anni.«Una sintetica panoramica delle profonde trasformazioni che in pochi decenni hanno modificato radicalmente il volto del nostro paese.» Paolo Mieli
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Italiani/e di Vittorio Vidotto in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia del XXI secolo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia del XXI secolo1. Uomini e donne, numeri e ruoli
Uno sguardo d’insieme alla società italiana dei primi anni del Duemila ci restituisce, nel confronto con gli anni del miracolo economico (1958-1963), alcuni caratteri immediatamente percepibili. Un’Italia meno prolifica e quindi meno giovane e anzi in progressivo invecchiamento, ma più ricca, più istruita, più uniforme. Segnata profondamente da una nuova presenza femminile. Quasi scomparsa la vecchia Italia rurale, profondamente modificata quella industriale, più articolato l’arcipelago delle attività intermedie o terziarie. Meno netti i segni di antagonistiche connotazioni sociali, meno istituzionalizzati e meno drastici i contrasti ideologici, sono riemersi con forza alcuni elementi permanenti del comportamento sociale degli italiani.
Il tentativo di dare un ordine, se non una spiegazione, a questi fenomeni si scontra con la difficoltà preliminare di individuare le scansioni del mutamento e quindi di riuscire a collocarle correttamente nel flusso temporale: in una parola a datarle. La ricchezza dei dati statistici disponibili non fornisce anche i criteri per separare nettamente fasi diverse, e la certezza dei numeri investe quasi esclusivamente gli andamenti generali della demografia. Ma i comportamenti demografici non costituiscono la causa prima di una serie di nuovi assetti sociali. Ne sono piuttosto il riflesso, anche se forniscono un primo saldo aggancio a quel che è meno afferrabile.
Proprio per questi motivi ritrovare negli anni 1962-1963, nella scansione dettata dalla svolta politica di centro-sinistra e dal culmine del miracolo economico, anche i segni e le coincidenze temporali dell’avvio di una profonda trasformazione demografica rafforza l’immagine di un passaggio cruciale, di una fase periodizzante. Nel 1963 si celebrarono 420.300 matrimoni (con un tasso di nuzialità dell’8,2 per mille), una cifra mai più toccata negli anni successivi1. Solo nel 1947-1948 i matrimoni erano stati più numerosi, ma si trattava della ripresa fisiologica dell’immediato dopoguerra. Nel 1964 i nuovi nati supereranno il milione (1.016.120) come non accadeva dal 1948 e come non sarebbe più accaduto in seguito. Il tasso di fecondità totale, che esprime il numero medio di figli per donna in età feconda e misura il livello di riproduzione della popolazione, in ripresa dal 1959, raggiunse il valore di 2,70 nel 1964. Da allora tutti i dati di una forte vitalità demografica cominciarono a scendere.
L’incremento dei matrimoni e il picco delle nascite (il baby boom degli anni Sessanta) rappresentarono non più di un’onda anomala nella riduzione della natalità in atto dal 1890 circa. La popolazione italiana si trovava ormai nella fase terminale di quel lungo processo di transizione demografica che in ogni paese sviluppato aveva segnato il passaggio da una demografia naturale a una demografia controllata. Un passaggio caratterizzato dalla riduzione della mortalità e da una contemporanea, ma meno accentuata, diminuzione della natalità alle quali si aggiungeva la fortissima crescita della speranza di vita. Dal 1881-1890 al 1951-1960 il tasso di mortalità diminuì del 65%, quello di natalità del 53%; la speranza di vita alla nascita raddoppiò, passando da 35 anni nel 1880 a poco meno di 70 nel 1960. L’Italia non deviò da questo percorso ancora per una dozzina di anni. Ma dal 1977 cominciò a essere misurabile una tendenza ormai in atto in molti altri paesi sviluppati, quella che i demografi chiamano «seconda transizione demografica»: il tasso di fecondità totale scese al di sotto di 2, la soglia che consente il rimpiazzo della popolazione2. L’Italia era entrata in una fase di stagnazione caratterizzata dalla graduale diminuzione del saldo fra nascite e morti fino a quando tale saldo, a partire dal 1993, non diventò negativo3. Negli anni successivi la crescita della popolazione complessiva, peraltro bassissima, era affidata sempre più all’immigrazione e ai rimpatri. Fra il 1981 e il 2001 la popolazione italiana cresceva appena dello 0,77%, mentre nel ventennio precedente era aumentata dell’11,7%; il tasso di incremento dal 1991 al 2001 è stato inferiore a quello di tutti gli altri quindici membri dell’Unione Europea.
Non si trattava dunque di una semplice omologazione al comportamento demografico degli altri paesi europei. Il primato negativo nel tasso di fecondità totale dai primi anni Novanta (giunto all’1,17 nel 1996) – un primato mantenuto nonostante l’incremento registrato nei primi anni del Duemila (1,26 nel 2001, 1,27 nel 2002) – e il conseguente minimo nella percentuale di popolazione sotto i 15 anni (14,2 nel 2004) segnalano qualcosa di più. Nel consegnare definitivamente a un passato ormai lontano l’immagine tradizionale di nazione giovane e prolifica, l’Italia ha compiuto negli ultimi venticinque anni una vera e propria accelerazione malthusiana sospinta da un profondo cambiamento delle mentalità, e della mentalità femminile in primo luogo. Non pare dubbio infatti che nel settore così intimo e privato delle scelte procreative (e soprattutto di quelle relative alle gravidanze successive al primo figlio) il ruolo determinante della donna e delle relazioni femminili sia decisivo.
Nella caduta della natalità avvenuta negli anni Settanta, e in particolare nella marcata intensificazione di questo processo fra il 1975 e il 19804, si possono individuare i primi risultati di una vera e propria rivoluzione dei comportamenti. Nel campo dei rapporti fra i sessi la rivolta giovanile del Sessantotto, amplificando aspirazioni maturate negli anni precedenti, aveva sperimentato su larga scala e successivamente diffuso libertà un tempo solo astrattamente rivendicate, e pochissimo praticate5. Non si trattava semplicemente del rifiuto della tradizionale dimensione monogamica o del diffondersi di rapporti prematrimoniali, ma della nascita di una nuova autonoma connotazione femminile impressa alle relazioni sessuali.
Nello stesso periodo la vittoria delle posizioni divorziste nel referendum abrogativo del maggio 1974, nonostante l’elevata politicizzazione dello scontro e l’ampia mobilitazione delle organizzazioni cattoliche, aveva misurato l’ampiezza e la diffusione di una mentalità ormai largamente secolarizzata. Il matrimonio perdeva anche ufficialmente ogni residuo di sacralità. In alcuni settori della società si modellava come progetto di vita fuori dai vincoli della tradizione e dagli obblighi procreativi. Altri valori si collocavano al centro della vita privata: la difesa di un benessere raggiunto o raggiungibile per la coppia e la realizzazione di sé nel lavoro e nell’istruzione per la donna. E così «la regolazione della fecondità appare sempre più non solo un progetto di coppia, ma un progetto individuale, delle donne»6. Un progetto confermato dal progressivo innalzamento dell’età media di procreazione del primo figlio: dopo essere scesa sotto i 25 anni alla metà degli anni Settanta cresceva ai 27,5 anni del 1980 e ai 30,4 del 2002. Ne risultava un evidente, anche se non necessariamente esplicito, rifiuto del modello femminile incarnato dalle generazioni precedenti, da quelle madri che «apparivano timide nei confronti del mondo esterno, e sottomesse tra le pareti domestiche; custodi di un’immagine di femminilità come ‘corpo’, ‘natura’, avulsa dalla storia [...] al tempo stesso autoritarie e socialmente deboli, complici e custodi della propria esclusione, ostili al cambiamento»7.
Questi nuovi comportamenti non avevano bisogno, per manifestarsi, di una verbalizzazione, di un’enunciazione esplicita: si venivano affermando soprattutto nella pratica, sospinti dai nuovi ruoli assunti dalle donne. I movimenti femministi rappresentarono, nel corso degli anni Settanta, la coscienza critica di questo passaggio, fornendo peso teorico e mobilitazione organizzativa alla dimensione conflittuale di un processo ormai in atto. Del resto in quegli anni si era manifestata una crescita significativa dell’occupazione femminile. Fra il 1971 e il 1981, se l’occupazione complessiva nell’industria rimase stagnante, si ebbe tuttavia un incremento del 7,4% di quella femminile a fronte di una diminuzione dell’1,7% di quella maschile. Nel terziario, che era invece in forte espansione con un incremento complessivo di oltre il 30%, l’occupazione femminile aumentò del 60%, quella maschile solo del 18,9%8. In molti casi erano collocazioni nuove o innovative per la donna, ma contava soprattutto la rilevanza numerica del processo. Se nelle élites colte e politicizzate e nei piccoli gruppi minoritari delle femministe si faceva strada una riflessione articolata e complessa sul ruolo di madre, e sul significato politico e sociale della procreazione, con il risultato di una maternità sospesa o posticipata, per la maggioranza delle donne era in atto un grande rifiuto9. Così si mantenne elevata, per quasi tutti gli anni Settanta, la risposta consueta alla gravidanza imprevista e indesiderata: il ricorso all’aborto clandestino con le sue umiliazioni e sofferenze (tollerate anche perché considerate inevitabilmente normali) testimoniava l’insufficiente diffusione di sistemi anticoncezionali sicuri, il cui impiego stentava ad affermarsi in questa fase in quanto continuava ad apparire come un rivelatore troppo manifesto di comportamenti trasgressivi.
La battaglia per la legalizzazione dell’aborto ad opera delle organizzazioni di sinistra e dei gruppi femministi, che si concluse con il varo della legge 194 del maggio 197810, contribuì a far uscire allo scoperto le dimensioni di una pratica e di un sistema in cui si intrecciavano sfruttamento, doppia moralità e illeciti arricchimenti secondo le consuetudini di tollerata illegalità caratteristiche di tanti altri aspetti del vivere in società nel nostro paese. Si può ritenere che, al momento del varo della legge per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, gli aborti, clandestini e illegali, fossero in Italia non meno di 350.00011, una cifra pari al 45-47% del totale dei nati vivi. Una volta instauratosi, il sistema pubblico non riuscì comunque a rispondere a tutta la domanda che rimase in alcune regioni prevalentemente clandestina, facilitata dalla obiezione di coscienza (consentita dalla legge) di una parte dei medici. E tuttavia la traduzione in pubblico di una scelta radicale e profondamente privata testimoniava un passaggio cruciale della consapevolezza femminile e del ruolo centrale ormai assunto dai circuiti femminili di sostegno. In seguito, la diminuzione delle interruzioni volontarie della gravidanza, passate dalle 230.000 circa del 1982-1983 alle 140.000 del 1997 e alle circa 132.000 del 200112, e del tasso di abortività dal 17 al 9,3 per mille donne in età feconda, ha confermato con il suo andamento un evidente processo di graduale acculturazione contraccettiva. L’abortività era originariamente più alta dove la scelta del servizio pubblico testimoniava forme di maggiore emancipazione e insieme una più alta disponibilità delle strutture sanitarie. Si abortiva di più in ospedale nel Nord e nel Centro dove era meno avvertito il controllo sociale; di meno nel Meridione che invece alla metà d...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. Uomini e donne, numeri e ruoli
- 2. Nuove tipologie familiari
- 3. La fine della vecchia Italia rurale
- 4. Città e metropoli
- 5. Classi, ceti e stratificazioni sociali
- 6. Consumi e stili di vita, disuguaglianza e mobilità
- 7. Gli anni della conflittualità
- 8. Comportamenti sociali ed etiche separate
- 9. Caratteri e identità
- Bibliografia