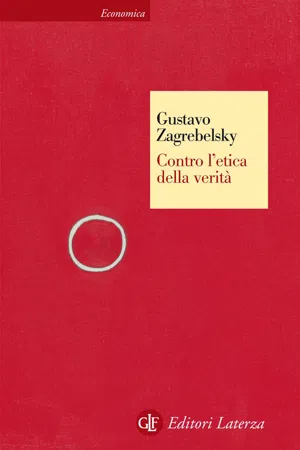2. Stato e Chiesa. Cittadini e cattolici
1. L’epoca della secolarizzazione, si dice, è giunta al termine. Saremmo ormai nel «post-secolarismo». Che cosa ciò positivamente significhi, non è chiaro. Ma, per chi adotta questa espressione e aderisce a ciò cui, con essa, si vuol alludere è chiaro che, nell’epoca post-secolare, prestare ancora fede alla profezia di un Émile Durkheim (la vittoria una «morale sociale», integralmente funzionale alle esigenze della società industriale) o di un Max Weber (il «disincanto» come carattere della «modernità») sulla sconfitta della religione a opera della ragione dell’Occidente, razionalista, economicista, materialista, edonista ecc., significa passare per retrogrado. L’agire sociale, nelle sue tante manifestazioni economiche, tecniche, politiche, culturali, affettive e sessuali, si è bensì reso progressivamente autonomo dalle premesse metafisiche di un tempo, ma questo processo, durato secoli, lungi dall’aver definitivamente sconfitto le concezioni oggettive della realtà umana teologicamente orientate, e lungi dall’averle relegate – allorquando residuino pur tuttavia atteggiamenti religiosi nei confronti del mondo – nel campo del privato irrilevante per la sfera pubblica, ha suscitato un contro-movimento: il post-secolarismo sarebbe questo movimento contrario, determinato dalla crisi della soggettività raziocinante che segna il tempo in cui i soggetti della vita secolari si rivolgono di nuovo costitutivamente, e non per semplice nostalgia o conforto interiore, alla religione e alle prestazioni sociali di cui essa è capace.
Le profezie di Durkheim e Weber avevano molto di sinistro e ributtante. Ma su molti di noi ha esercitato grande fascino il testamento di Dietrich Bonhöffer, indirizzato al mondo nella sua «maggior età», il mondo che può e deve fare a meno del deus ex machina cui per millenni l’essere umano ha fatto ricorso per trovare in lui la potenza che supplisce alla propria pochezza. Anche questo fascino – dice il post-secolarismo – è un abbaglio, è stato solo l’illusoria fascinazione d’un momento. Dio e le religioni sono di nuovo invocati e, parallelamente, le loro chiese-ministre avanzano la loro pretesa di valere come forza sociale unificante di senso, contro la disgregazione relativista o, più precisamente, nichilista in cui la ragione soggettiva avrebbe precipitato il mondo contemporaneo. Non nella maggior età il nostro mondo si troverebbe a vivere, ma in un’età senile in cui le forze si decompongono. Così oggi, come tante altre volte nella storia dell’Occidente, la religione e le sue istituzioni sarebbero ancora una volta chiamate dalle circostanze a distogliersi dal culto della parola di Dio, per offrirsi come puntelli etici per reggere le sorti di società disorientate e incapaci di uscire dalle loro stesse contraddizioni.
2. In questo contesto spirituale è stato pronunciato ed è stato accolto come il «verbo» la «formula pregnante» (Habermas) enunciata a metà degli anni Sessanta dall’eminente costituzionalista cattolico Ernst-Wolfgang Böckenförde, una piccola frase, scritta con rilievo in un saggio del 1964 su La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione1: «lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che esso stesso non può garantire. Questo è il grande rischio che si è assunto per amore della libertà». La contraddizione principale, con la conseguente candidatura religiosa e chiesastica a risolverla, concerne la vita politica delle nostre società, in quanto esse aspirano a governarsi in libertà e democrazia, cioè attraverso il sistema politico costituzionale che assume come proprio elemento fondante la capacità ordinante della ragione individuale, cioè un presupposto immanente alle società stesse. Queste società credono di poter vivere senza ricorrere a fondamenti, a premesse che precedono la loro stessa libertà. Il focus della formula di Böckenförde sta dunque negli aggettivi «liberale» e «secolarizzato». Lì si troverebbe condensata la ragione di quel deficit di «forze che tengono unito il mondo», che «creano vincolo» (Bindungskräfte) sociale, senza le quali lo Stato si troverebbe come appoggiato sul niente.
In quella proposizione c’è la risposta disperante a una serie di domande retoriche:
Di che cosa vive lo Stato e dove trova la forza che lo regge e gli garantisce omogeneità, dopo che la forza vincolante proveniente dalla religione non è e non può più essere essenziale per lui? Fino al XIX secolo, in un mondo interpretato dapprima in modo sacrale, poi in modo religioso, la religione era sempre stata la forza vincolante più profonda per l’ordinamento politico e per la vita dello Stato. Ma è possibile fondare e conservare l’eticità in maniera tutta terrena, secolare? Fondare lo Stato su una «morale naturale»? E se ciò non fosse possibile, lo Stato potrebbe vivere sulla sola base della soddisfazione delle aspettative eudemonistiche dei suoi cittadini? Tutte queste domande ci riportano a una domanda più profonda, di principio: fino a che punto i popoli uniti in Stati possono vivere sulla base della sola garanzia della libertà, senza avere cioè un legame unificante che preceda [corsivo mio] tale libertà?
Certo, non si può pensare di imporre autoritariamente i legami sociali, sotto forma di ideologie o sistemi di valore stabiliti dall’alto, perché così lo Stato liberale distruggerebbe se stesso e la libertà dei suoi cittadini. Ma lo Stato basato sulla libertà, che non possa confidare in forze vincolanti interiori dei suoi membri, sarà indotto, per garantire la propria base di legittimità, ad accrescere utopisticamente e illusoriamente le promesse di benessere, con ciò avvolgendosi con le sue stesse mani in una spirale di aspettative d’ogni genere che, oltre un certo limite, non potrà più mantenere e che lo strangolerà.
La diagnosi non è originalissima e appartiene alla polemica ottocentesca anti-liberale, anti-individualista e anti-ugualitaria. Sul terreno letterario, per esempio, la troviamo anticipata in un passo dei Fratelli Karamazov2, dove Fëdor Dostoevskij mette in bocca allo starec Zosima queste parole testamentarie, che hanno solo bisogno d’essere un poco adattate ai tempi nostri:
Dice il mondo: «Tu hai dei bisogni, e dunque soddisfali pure, giacché hai gli stessi diritti che hanno gli uomini più potenti e più ricchi. Non temere di soddisfarli, anzi moltiplicali». Ecco qual è l’insegnamento attuale del mondo; e in questo appunto si ravvisa la libertà. Ora, che cosa viene fuori da questo diritto a moltiplicare i bisogni? Presso i ricchi l’isolamento e il suicidio spirituale, e presso i poveri, l’invidia e l’omicidio: giacché i diritti sì, sono stati concessi, ma i mezzi di soddisfare i bisogni non sono ancora stati indicati. Ci si assicura che più innanzi si va, più il mondo si unifica, si organizza in una società fraterna, per il fatto che raccorcia le distanze, trasmette attraverso l’aria i pensieri, ecc. Ahimè, non credete a una simile unificazione degli uomini. Concependo la libertà come una moltiplicazione e una rapida soddisfazione dei bisogni, stravolgono la propria natura, giacché ingenerano in loro stessi una moltitudine d’insensati e stupidi desideri, insulsissime abitudini e fantasie. Non vivono se non per l’invidia che si portano l’un l’altro, per la sensualità e la millanteria: pranzi, viaggi, carrozze, alti gradi e servitori ai propri ordini, si considerano una necessità tale, da sacrificare per essi anche la vita, l’onore e l’umanità, purché sia soddisfatta; e se non può venir soddisfatta, giungono a uccidersi. Presso quelli che ricchi non sono, vediamo la medesima cosa: sennonché, qui tra i poveri, l’impossibilità di soddisfare ai bisogni, e l’invidia, vengono per ora soffocate nell’ubriachezza. Ma ben presto, invece che di vino, s’ubriacheranno di sangue: a questo li vanno conducendo. Io vi domando: «è libero, forse, un uomo così?».
In termini più attuali, questa diagnosi costituisce una generalizzazione a tutti gli aspetti della vita sociale, fino a coinvolgere quelli etici, della critica già contenuta nella teoria della «crisi fiscale dello Stato», venuta alla luce negli anni Sessanta. Essa si basa, in primo luogo, su una connessione sottintesa, data per inevitabile, tra la libertà, da un lato, e le pretese di benessere individuale, dall’altro; in secondo luogo, su una sorta di reciproco effetto moltiplicatore: la libertà moltiplica le pretese e le pretese soddisfatte moltiplicano la libertà.
Dati questa connessione e questo effetto moltiplicatore, la prognosi appare senz’altro senza speranza, quasi una condanna a morte a effetto ritardato. Più che della «formazione» (Entstehung) dello Stato moderno secolarizzato, sarebbe giustificato parlare della sua «dissoluzione» (Auflösung). Un sistema di convivenza basato esclusivamente sui diritti immanenti dei suoi membri, rivolti come pretese individualistiche ed egoistiche nei confronti dello Stato e come armi offensive nei confronti dei con-cittadini, infatti, non solo non garantisce le sue basi di legittimità, ma le distrugge, consumando progressivamente le proprie risorse etiche. Questa erosione corrisponde al venir meno della forza dell’obbligazione politica, verticalmente, e all’affievolirsi del vincolo di solidarietà sociale, orizzontalmente, senza di che lo Stato stesso, nella sua versione democratica, non avrebbe su che cosa poggiare la propria funzione di garanzia della vita sociale.
Portando avanti questa proposizione, facilmente si arriva a concludere che lo Stato democratico basato esclusivamente su diritti e libertà, privo della capacità d’appellarsi a principi etici comuni trascendenti e, in loro nome, di pretendere dai suoi cittadini limiti, moderazione e rinunce, è destinato alla catastrofe o a trasformarsi in qualcosa di diverso, magari dietro la nuda facciata di istituzioni democratiche in apparenza, ma non (più) nella sostanza.
Noi, qui, non abbiamo da prendere posizione, in linea di principio, sul contenuto di verità della proposizione, enunciata come «legge», di Böckenförde. Non abbiamo cioè da pronunciarci sull’incapacità strutturale dello Stato basato sulla libertà di autoalimentare le proprie basi di legittimità. Possiamo limitarci a sfiorare l’argomento, osservando ch...