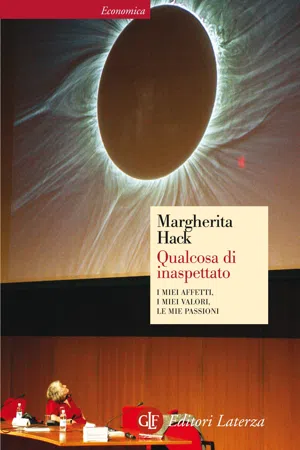Capitolo primo
1. La città che amo
Sono molto legata a Firenze. È la città dove sono nata, dove ho studiato e vissuto per trentadue anni. Là ogni angolo di strada, ogni pietra mi ricorda qualcosa della mia infanzia, dello sport, dei giochi ai giardini pubblici, del mio incontro col bambino Aldo, dell’inizio della carriera scientifica. Forse è proprio per questo affetto per Firenze che non ho mai cercato di attenuare il mio forte accento toscano. Ho conservato pure un pizzico del tipico carattere dei fiorentini, ribelli e strafottenti al limite della cattiveria e sempre pronti a criticare i forestieri. Adesso, dopo tanti anni, le cose sono cambiate e si sono abituati a trattare con i turisti, ma una volta non facevano altro che punzecchiare chi veniva da fuori, anche in maniera pesante.
Quando ritorno a Firenze provo sentimenti diversi, contrastanti: da una parte mi faccio coinvolgere dall’emozione, dall’altra non riesco a evitare di sentirmi decrepita, solo immaginando quanti anni siano trascorsi da quando giocavo a nascondino in quei vicoli e nei giardini. Ora la città senza dubbio è molto diversa da come la ricordavo. Negli ultimi cinquant’anni è cambiata soprattutto per far fronte all’incredibile numero di visitatori che vogliono ammirare il suo patrimonio artistico. I turisti c’erano anche prima, di solito ricchi signori provenienti da Inghilterra, Germania e Stati Uniti, ma erano pochissimi, niente a che vedere con i milioni che oggi la invadono ogni anno. Grazie al turismo di massa, infatti, anche le persone con un reddito normale possono permettersi di viaggiare. Di certo una grande conquista, che però influisce su coloro che devono vivere in una città ormai trasformata in un museo: a causa dell’affollamento nel centro si ha difficoltà a camminare per strada e non è raro che siano migliaia le persone in fila per entrare agli Uffizi o in Duomo, dove spesso la coda si avvolge tutta intorno alla cattedrale, lunga come quella che feci intorno al Cremlino, a Mosca, per vedere le mummie di Lenin e Stalin. Eppure questa confusione, questo spirito, fanno parte dell’animo di chi è vissuto a Firenze. Per me e la mia famiglia, ad esempio, non era strano avere a che fare con i turisti. Mia nonna materna aveva una pensione per stranieri e, grazie a questa esperienza, la mamma sin da piccola aveva imparato molto bene il francese e l’inglese. Ciò le tornò utile in seguito quando, per campare, si mise a fare la copista agli Uffizi vendendo le miniature ai turisti stranieri e a quei pochi italiani che ancora andavano in giro durante la guerra.
Quando ero molto piccola vivevo in via Caselli, dove sono nata, vicino al Campo di Marte, un tempo un’immensa distesa d’erba che arrivava fino quasi ai viali che circondano la periferia nord della città. Era il campo d’aviazione: c’erano gli hangar e da lì partivano e atterravano quei piccoli aerei con le ali di tela. I miei mi ci portavano a giocare col cerchio: lo mettevo a terra, ci saltavo dentro e facevo finta di essere in un aereo. Sono ricordi molto nitidi nonostante avessi solo due anni, come dimostrano alcune foto datate settembre 1924.
Adesso il Campo di Marte è irriconoscibile: c’è lo stadio, la cui costruzione cominciò, se ben ricordo, all’inizio degli anni Trenta, campi da tennis, piscine e, proprio recentemente, è stato inaugurato il nuovo campo per l’atletica. Una volta la pista e le pedane per l’atletica erano attorno al campo di calcio poi, in occasione dei mondiali del 1990, l’atletica fu sacrificata al Dio del pallone per fare spazio a nuove tribune.
Fra i ricordi di quegli anni sono ancora molto vivi quelli della casa dove abitavo: era un appartamento in una casa a tre piani, di cui noi occupavamo il primo. Ricordo molto bene un grande salotto tutto buio dove non s’entrava mai con un tappeto a strisce verdi e grigie che copriva tutto il pavimento, il letto dei miei genitori e un panno giallo con dei leoni rossi appeso al muro accanto al mio lettino. E poi un salottino col pianoforte che la mamma suonava la sera prima di cena mentre aspettava che il babbo tornasse dall’ufficio. Era quasi completamente priva di orecchio musicale, così come me del resto, che sono incapace di cantare anche le canzonette più orecchiabili senza stonare. Quando si esercitava a fare le scale e altri esercizi io mi accucciavo sotto il piano e immediatamente venivo assalita dal sonno. Ancora oggi, quando sento un pianoforte in lontananza, mi prende una grande sonnolenza: forse questo suono mi è entrato nel cervello in maniera subcosciente quando la mamma cercava d’insegnarmi a suonare. Per un po’ mi cimentai con gli esercizi, ma mi sembravano davvero una barba incredibile. Fortunatamente non ha insistito, rendendosi conto di quanto fossi negata per la musica.
Per tutto il resto della mia vita fiorentina ho vissuto alla periferia sud di Firenze, vicino al Poggio Imperiale, in una zona chiamata Il Gelsomino, a due passi dalle Due Strade dove comincia la strada per il Galluzzo e la Certosa. Ci trasferimmo lì quando avevo più o meno cinque anni in seguito al licenziamento del babbo, visto che la casa di via Caselli era in affitto ed era molto costosa, situata com’era in un quartiere residenziale. Quella al Gelsomino era una vecchia casa di campagna che la mamma aveva ereditato dai nonni. Siccome era quasi fuori città, il babbo mi faceva fare lunghe passeggiate fra i campi: conoscevamo tutti i contadini, i cui poderi erano a un tiro di schioppo dalla nostra casa, e questo ci fu utile parecchi anni dopo, durante la guerra, per poter comprare un po’ di patate, uova e ortaggi, dato che il cibo assegnatoci con la tessera non bastava mai. A quei tempi la fame si faceva sentire ed era normale cercare d’arrangiarsi in tutti i modi. Una volta ebbi la fortuna di trovare addirittura venti chili di patate a Genova, dove ero andata per disputare una gara d’atletica: quando arrivai a Firenze, dovetti trascinarle a piedi per quasi quattro chilometri, dalla stazione di Santa Maria Novella fino al Poggio Imperiale. Era mezzanotte e c’era il coprifuoco, la ronda dei soldati intimava l’alt e io dovevo mostrare ogni volta documento e biglietto, a riprova che ero appena arrivata dalla stazione. Fortunatamente mi lasciarono passare senza problemi e così riuscii a mettere al sicuro il mio piccolo tesoro.
Una delle cose che mi entusiasmò maggiormente del trasferimento nella nuova casa era la vicinanza al Bobolino, un giardino pubblico situato a circa dieci minuti di strada. Allora andavamo a piedi dappertutto, anche quando si trattava di raggiungere posti lontani come il ginnasio-liceo in via Martelli, in pieno centro, e solo raramente si prendeva il tram. Il nome del Bobolino non va confuso con quello di un altro famoso parco di Firenze, quello di Boboli, un giardino monumentale, annesso a Palazzo Pitti, che certo non è adatto ai giochi. Il Bobolino è diviso in tre parti, di cui quella più in basso e vicina a Porta Romana è pianeggiante e poco attraente per i bambini per via delle aiuole ben curate, le panchine, e la mancanza di spazi per giocare. Fino a quando avevo sei o sette anni si andava nella parte più alta, più vicina a casa mia, che è molto scoscesa e poco adatta per giocare a palla; poi cominciammo ad andare in quella di mezzo, il giardino più grande, dove si poteva dare massimo sfogo alla fantasia, grazie agli alberi su cui arrampicarsi e ai tanti rifugi per giocare a nascondino o a «guardie e ladri».
Durante tutte le estati non ho mancato un solo giorno di scorribande al Bobolino: mi ci accompagnava il babbo ogni mattina e ci stavamo dalle nove a mezzogiorno. Lui si portava da leggere e prendeva il fresco, vista la sua condizione di disoccupato e casalingo forzato. Fu lì che, in una mattina dell’estate seguente alla prima ginnasio – oggi si direbbe la prima media –, incontrai un gruppetto di bambini. Il più grande si chiamava Aldo e mi chiese se volevo giocare con loro, dato che io avevo la palla. L’altro era suo fratello Athos; la bambina, Betti, e il più piccolo del gruppo erano dei loro amici. Con Aldo giocammo accanitamente tutta l’estate: eravamo affiatatissimi, malgrado io tifassi per Binda e lui per Guerra, i due grandi campioni del ciclismo degli anni Trenta. Oggi dopo sessant’anni siamo ancora insieme.
Attorno ai quattordici o quindici anni, cominciai a rendermi indipendente e ad andare da sola al Bobolino: facevo «orario d’ufficio», dalle nove a mezzogiorno e dalle tre alle sei del pomeriggio, tornando a casa solo per mangiare. Avevamo una compagnia fissa e i nostri giochi preferiti erano palla prigioniera, nascondino e tutto ciò che si potesse fare con un pallone.
Ho sempre avuto una grande passione per la bicicletta. Per poterci fare un giretto la chiedevo in prestito agli amici dei miei che capitavano a casa. Per i miei, infatti, sarebbe stata una grossa spesa, dato che a quei tempi la bici era paragonabile per valore e importanza a un motorino di oggi. Un’estate conobbi un giovane meccanico di circa vent’anni che trascorreva le ferie al Bobolino ed era entrato a far parte del nostro gruppo. Si fidava di me e fu così gentile da prestarmi la sua tutte le volte che gliela chiedevo per poter scorrazzare felice per i Viali dei Colli. Purtroppo, una volta cascai, facendomi anche male a un braccio. Quando mi rialzai la mia unica preoccupazione fu quella di aver rovinato la bicicletta che, invece, per fortuna era rimasta intatta. Nonostante l’incidente il ragazzo continuò a prestarmela e per questo ricordo ancora la sua generosità.
Poi, finalmente, quando fui promossa a giugno in prima liceo, i miei me la regalarono e potei soddisfare quella mia passione che è tuttora molto viva. Cominciai così ad andare a scuola in bici, fra gli sfottimenti delle mie compagne che già si atteggiavano a signorine e parlavano solo di balli e di ragazzi.
Qualche volta sono tornata a rivedere i giardini pubblici dove giocavo allora, ma sono rimasta molto delusa. Il Bobolino è quasi deserto e mi ha dato l’impressione di essere in completo abbandono, decisamente diverso da quando era affollato di bambini, a cui sembrava il «Paese dei Balocchi»: un luogo magico per giochi e avventure, dove una fitta siepe poteva sembrare una giungla selvaggia.
Da quando non ci sono più i miei genitori, le visite a Firenze si sono ridotte a quelle legate al lavoro e durano solo poche ore. Ciononostante i ricordi si affollano e mi fanno sentire vecchia. Non essendo mai stata legata al passato, non ho nostalgia di tornare a vivere lì, per quanto continui a sentirla profondamente ancora come la mia città.
Le cose sono cambiate in particolare dal 1971, l’anno in cui morì il babbo, a undici anni dalla scomparsa della mamma. Da allora, io e Aldo ci siamo tornati solo per brevi periodi. L’unico parente che ci è rimasto è Athos, che ogni tanto andiamo a trovare.
D’altra parte la vecchia casa di via Ximenes al Gelsomino è stata venduta, dopo un periodo in cui avevamo affittato il primo piano a un vicino che conoscevo fin da bambina, tenendo per noi il pianterreno. Per noi era comodo perché, grazie a questa amicizia, quando avevamo voglia di tornare a Firenze ci bastava fare una telefonata per essere accolti a braccia aperte. Da principio tutto funzionò bene. Poi cominciarono i problemi: trovavamo regolarmente la casa in un disordine incredibile, con cicche dappertutto, il nostro letto chiaramente usato da altri, i lenzuoli sporchi e spiegazzati. Per giunta alcuni mobili erano stati venduti e sostituiti con altri senza che ci avessero nemmeno informati. Anche se la cosa ci meravigliò e seccò abbastanza, lasciammo correre, non avendo mai avuto grande attaccamento ai nostri beni in generale. Comunque cominciammo a pensare di vender la casa nel 1984, perché dovevamo comprarne una a Trieste. Infatti l’alloggio di servizio, di cui avevo usufruito fino ad allora come direttore dell’Osservatorio, sarebbe stato utilizzato per ospitare alcuni uffici e studi, di cui c’era grande bisogno per il rapido aumento di ricercatori e impiegati. Ma la decisione di venderla fu accelerata in seguito al consiglio di un nostro conoscente triestino, che ci aveva chiesto di essere ospitato qualche giorno per poter visitare Firenze. Venne accolto malissimo e quasi cacciato dalla nostra casa, che ormai era stata trasformata senza alcun ritegno dal nostro inquilino in una specie di ufficio. Oltre a riferirci dello spiacevole episodio, il nostro amico triestino ci mise in guardia dall’eventualità che venisse messa in pratica l’usucapione, una clausola secondo cui chi abita una casa per vent’anni ne diventa legittimo proprietario. Così, malgrado le opposizioni e i cavilli, che ci portarono fino in pretura, riuscimmo a venderla, chiudendo definitivamente la pagina che ci ha legato a Firenze per gran parte della nostra vita.
2. Babbo, mamma, giustizia e libertà
Con i miei genitori ho sempre avuto un rapporto aperto e non ho mai avuto preferenze per uno dei due in particolare, perché sin da piccola sono stata seguita molto da entrambi. Dal babbo ho imparato l’amore per la giustizia e la libertà, e a non raccontare bugie, anche quando marinavo la scuola. La mamma non è stata da meno e mi ha trasmesso la forza per affrontare la vita sempre con grande dignità. Il babbo, a differenza della mamma, era molto ottimista, mentre lei si distingueva per fantasia e creatività, tanto da essere l’autrice di ognuna delle piccole invenzioni utili in casa. Aveva poi un grande spirito di sacrificio, e ha sempre lavorato accanitamente, malgrado avesse tanti problemi di salute e il lavoro di miniaturista non le fosse molto congeniale.
Il loro rapporto era molto buono, egualitario e di continua collaborazione. Devo dire che non ricordo litigi in casa, a parte qualche capriccio che ogni tanto li rendeva simili ai bambini. Ne ricordo uno accaduto durante la guerra, quando tutto era limitato dalla tessera e il cibo era sempre insufficiente. In casa eravamo tutti vegetariani e di solito c’era un solo uovo per fare una frittata da dividere in tre. Anche se si cercava di dividerla nel modo più equo possibile, capitava qualche volta che le fette non fossero perfettamente uguali. Quando al babbo toccava quella apparentemente più piccina, s’imbronciava e nonostante cercassimo di convincerlo che le fette fossero tutte uguali fra loro, scoppiavano lunghe discussioni. Allora avevo quasi vent’anni e non potevo fare a meno di riderci sopra, rendendomi conto di quanto buffo fosse il motivo del litigio. Avevano una diversa estrazione sociale: la mamma, infatti, era cresciuta in una famiglia piccolo borghese, mentre il babbo proveniva da una famiglia operaia. Questa differenza non ostacolò il loro rapporto perché li univa una gran voglia di darsi da fare per migliorare insieme e imparare ad affrontare le avversità.
L’infanzia della mamma fu tristemente solitaria. Il padre era morto quando lei era molto piccola e la stessa sorte toccò a un fratello minore e a una sorella più grande, alla quale era molto affezionata. Come ho già detto, sua madre gestiva con altri parenti una pensione per stranieri, che le permise da giovane d’imparare l’inglese e il francese. Aveva anche lavorato come ragazza alla pari, spesso millantando di avere vent’anni invece di diciassette, per poter accompagnare le ragazzine più piccole. I suoi le avevano dato la possibilità di avere una buona istruzione: si diplomò come maestra e successivamente all’Accademia delle Belle Arti. Era abbastanza portata per dipingere, ma non credo che fosse la sua aspirazione e che avesse una vera sensibilità artistica. Forse le sarebbe piaciuto più scrivere, ma non ho mai avuto l’occasione di chiederglielo. Tralasciando completamente ciò che aveva studiato, per qualche anno fu impiegata al telegrafo, ma lo lasciò quando nacqui io per via degli orari scomodi e dei turni anche di notte. Quando il babbo fu licenziato, riprese a lavorare e fu costretta a mettere a frutto la sua abilità di pittrice, facendo riproduzioni in miniatura dei quadri degli Uffizi, nelle cui sale passava gran parte della giornata. Era chiaramente un lavoro di ripiego e molto precario, perché rendeva esclusivamente in presenza di turisti e diventava poco redditizio se questi mancavano, come accadde durante la guerra.
Il babbo, invece, era stato allevato in una famiglia abbastanza povera. Il nonno, d’origine svizzera, lavorava in una pasticceria, ma ne so pochissimo, perché non ne parlava mai. Solo in seguito la mamma mi disse che questo silenzio era dovuto alle cattive abitudini del nonno, che era alcolizzato e causava grosse preoccupazioni alla moglie. Il babbo ha sempre vissuto a Firenze dove aveva un fratello minore, di carattere molto diverso da lui, tanto che durante tutta la vita lo ha incontrato molto raramente. Aveva altre due sorelle più grandi, di cui una si era sposata in Polonia e l’altra a Torino. Anche a causa del problema di suo padre, strinse un fortissimo legame con la mamma, la cui morte, quando lui aveva venticinque anni, lo lasciò molto depresso. Aveva fatto le scuole elementari di là d’Arno, in San Frediano, una scuola molto popolare vicino a Porta Romana, la stessa scuola che ha frequentato anche Aldo trentun’anni dopo. Dopo le elementari prese il titolo di contabile, che corrispondeva ai tre anni della scuola media, un gradino al di sotto di quello di ragioniere. Ciò gli permise di lavorare per qualche tempo come contabile e in seguito di trovare un buon impiego presso la società toscana fornitrice di energia elettrica.
Era una persona a cui piaceva molto leggere e studiare e fece di tutto per farsi da solo una cultura più estesa di quella ricevuta a scuola. Visto che non aveva avuto la possibilità di studiare le lingue fu la mamma a insegnargliele. Si interessava molto di scienza e leggeva molti libri di divulgazione astronomica, soprattutto quelli del francese Nicolas Camille Flammarion, che nell’Ottocento scrisse parecchie opere sull’universo e la vita nel sistema solare. Erano libri famosi allora, e ne conservo ancora qualcuno.
Durante il fascismo, attorno al 1927 o 1928, fu licenziato, ufficialmente per motivi di salute: sapendo che aveva avuto problemi ai polmoni, dissero che era tisico e disinfettarono anche la sua scrivania. In realtà la vera motivazione era legata a ragioni politiche, al suo antifascismo e alla vicinanza al sindacato. Ciò fu confermato dal contemporaneo licenziamento di tutti i dipendenti non iscritti al Partito fascista e di tendenze socialisteggianti. Il babbo non era mai stato iscritto ad alcun partito, ma simpatizzava per quello socialista e, pur non essendo formalmente un rappresentante sindacale, nelle situazioni di conflitto si era sempre schierato dalla parte dei sindacati e degli operai. Quindi era inviso alla dirigenza e per questo motivo non ha mai più trovato lavoro. Allora non potei capire che il licenziamento e il conseguente cambiamento del nostro tenore di vita fossero frutto della dittatura fascista: cosa fosse veramente il fascismo lo realizzai a sedici anni, e precisamente nel 1938, quando in Italia vennero promulgate le vergognose leggi razziali. In casa se ne parlava tanto, ma ciò che sconvolse il mio sentimento di giustizia fu il vedere professori e compagni ebrei cacciati da scuola da un giorno all’altro per l’unica colpa di essere ebrei. E nessuno allora poteva immaginare l’atroce sorte a cui sarebbero andati incontro molti di loro.
Ma i miei genitori seppero trasmettermi un esempio ben più importante delle semplici parole: per qualche mese nascosero in casa nostra una signora ebrea. Era la mamma di Sergio De Benedetti, un fisico abbastanza noto, di qualche anno più vecchio di me, che in seguito alla fuga dall’Italia ha sempre lavorato negli Stati Uniti. Rimase nascosta fino a quando dei vicini, e in particolare due impiegate di banca fasciste, cominciarono a insospettirsi, nonostante questa signora non uscisse mai. Forse avevano visto aprire e chiudere le finestre di una stanza che di solito veniva utilizzata poco. Visti i precedenti del babbo, temevamo una denuncia, e così dopo qualche tempo, la nostra ospite trovò il modo di scappare altrove.
Conoscemmo anche altri ebrei meno fortunati, che in quegli anni si nascosero in campagna e che da un momento all’altro scomparvero nel nulla. Per esempio, il proprietario di una famosa tipografia fiorentina, che malgrado fosse un fascista della prim’ora, avesse partecipato alla marcia su Roma e per questo fosse stato insignito della «Sciarpa Littorio», perse proprietà, ditta e forse anche la vita. Non ho mai saputo quale sia stata la sua fine.
Il licenziamento del babbo rappresentò un grosso problema perché da una condizione di discreta agiatezza ci fece piombare in uno stato al limite dell’indigenza. Lasciammo una bella casa con fornelli elettrici e tante lampadine da 100 watt – l’energia veniva fornita a basso costo dalla ditta dove lavorava il babbo – per trasferirci al Gelsomino, in una vecchia casa ereditata ...