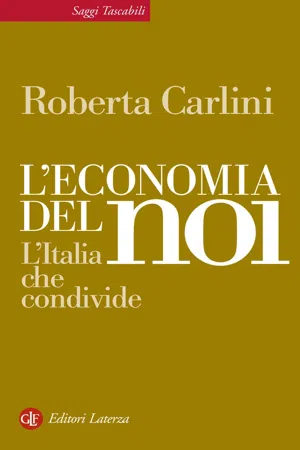1. Consumo
1. Arance allegre
La chiamano la tristezza delle arance. A un certo punto gli alberi cominciano a perdere le foglie, gli aranceti si spogliano e muoiono. «È un virus degli agrumi. Noi in Sicilia non ce l’abbiamo, in altre parti d’Italia invece si sta diffondendo», dice Michele. E rassicura i suoi interlocutori, soci di un gruppo d’acquisto romano dai quali è stato invitato per discutere del prossimo raccolto: «Non ci mettiamo niente sui nostri alberi. Non ci abbiamo messo niente neanche quando abbiamo avuto il problema delle formiche». Un problema serio. «Si infilavano nei buchetti degli irrigatori e li tappavano. Pensate quanto tempo ci voleva ad andare a stappare tutte le sere centinaia di augelli, uno per albero». E via con una spiegazione tecnica sull’augello dell’irrigatore degli aranci, e del nuovo dispositivo che è stato messo in commercio che si tappa da solo quando non butta fuori acqua e così le formiche non entrano più: problema risolto, senza veleni chimici.
Michele Riggio è un produttore di arance di Agrofonte, provincia di Siracusa, area Igp. Che vuol dire: indicazione geografica protetta, il che dà un marchio di qualità ai suoi agrumi. Marchio che però non gli basta per vendere le sue arance al mercato senza rovinarsi. Per questo è qui, in una cena romana a casa di Adele, con quelli del gruppo Gasper: uno dei tanti gruppi d’acquisto di Roma e d’Italia, ai quali moltissimi produttori agricoli si stanno legando come a un’ancora di salvezza. Gruppi di consumatori che per i produttori come Riggio valgono più del marchio Igp: gli permettono di vendere le arance a un prezzo decente, sufficiente per vivere, e non essere strozzato da quelli che lui chiama i «commercianti»; di parlare del lavoro che fa, metterci la faccia e mostrare in piazza i suoi conti e le sue virtù; e sono anche un buon motivo per girare l’Italia, per incontrare anche fisicamente i suoi gruppi di clienti arrivati alla sua azienda via internet o con il passaparola, far girare foto e dati o assaggi; e intanto chiacchierare un po’ sul mondo.
Tra le novità emergenti dal mondo della società civile e dell’altra economia, quella dei gruppi d’acquisto è stata la più duratura e popolare. I soli gruppi registrati alla rete nazionale superano quota 700, e crescono a un ritmo del 50-60% all’anno. Se ne trovano nelle scuole e negli uffici, sono fatti da vicini di casa o da nuclei di amici sparsi. Sono nati all’epoca del telefono o della convocazione verbale, cresciuti con scambi di mail collettive e con le piattaforme internet. Se capita di vedere agli angoli delle piazze o nei garage condominiali gente che scarica e scambia cassette o buste con merci d’ogni tipo; se gente come Michele macina centinaia di chilometri per incontrare i suoi clienti quasi uno per uno; se, più in generale, centinaia di migliaia di persone dedicano alla propria spesa dieci o venti volte il tempo che ci vuole per riempire il carrello di un supermercato; se tutto questo succede, qualche buon motivo ci sarà. E, come tutta la ormai ricca letteratura sui gruppi d’acquisto racconta e l’esperienza diretta conferma, si tratta di motivi che travalicano la sfera dell’economico per entrare nel campo dell’etica, della salute, anche della politica. Non quella con la P maiuscola, che doveva o dovrebbe intervenire per indirizzare, correggere, regolare il mercato; ma quella che, attraverso il consumo critico, una parte di società civile pretende di portare direttamente dentro il mercato. Quella parte di società civile che utilizza «il mercato come arena politica e la spesa quotidiana come un voto a favore dell’ambiente e dei diritti umani», per usare le parole di Michele Micheletti, scienziata politica svedese, esperta di consumerismo politico.
A casa di Adele, mentre si parla di arance, soldi, formiche, camion e piattaforme, vediamo un pezzo di questo mercato trasformato in arena politica, o della politica che scende al mercato. La padrona di casa di mestiere fa modelli econometrici, e non è molto entusiasta dell’uso che i suoi committenti fanno dei numeri che lei fornisce. Gli altri membri del gruppo sono professionisti, studenti, bancari, insegnanti, dirigenti. Molti hanno figli piccoli, ma non tutti. Qualcuno viene da esperienze politiche – a sinistra –, altri no. Sono interessati a tutto il percorso di quello che comprano e mangiano. Sono più o meno giovani (qualcuno che va per i quarantacinque c’è), e illustrano la loro organizzazione logistica militante, messa su nel caos di San Lorenzo, quartiere romano un tempo popolare, schiacciato tra il via vai dell’università di giorno e il brulichio dei locali di notte, il grigio della tangenziale e l’oasi del cimitero del Verano. C’è un referente del gruppo per ogni produttore, che analizza e garantisce il prodotto; c’è un giorno e un luogo di consegna; c’è, a turno, la persona incaricata di ricevere la merce, poi smistarla e raccogliere i soldi; c’è un cassiere, che riceve i soldi e fa i bonifici ai produttori. Comprano di tutto, non solo alimentare e non solo biologico; purché sia garantita la provenienza, la salubrità, il rispetto dell’ambiente e delle condizioni di lavoro. I vari bollini delle certificazioni non sono né necessari né sufficienti: il più delle volte, in questo come in quasi tutti i gruppi, si va direttamente a visitare il luogo della produzione, si fanno domande, prove, a volte anche test a campione successivi. Ma soprattutto, come dice Valeria Manna, fondatrice di un altro gruppo romano, chiamato Modus vivendi, «vogliamo guardare negli occhi il produttore, quello che fa le cose che mangiamo o indossiamo». E così facendo va a finire che non si parla solo di pesticidi da evitare o biologico da garantire; ma anche dei semplici conti del contadino, dell’impossibilità di farli quadrare nel settore agricolo tradizionale; e dei problemi di tutta la filiera produttiva alimentare, dal campo al piatto.
Ritorniamo alla tristezza delle arance di Michele Riggio, che racconta così lo stato delle cose per un giovane agricoltore italiano oggi: «Mio nonno con un agrumeto di un ettaro viveva benissimo, e ad agosto aveva già tutti i raccolti prenotati. Io l’ultima volta che ho venduto le arance ai commercianti ho preso 2.050 euro per una raccolta di 400 quintali, sull’albero». Vale a dire, «i commercianti» – ossia gli intermediari che a loro volta vendono le arance alla grande distribuzione – gli davano 5 centesimi al chilo, stimando più o meno quanti chili faceva ogni albero, poi pensavano loro a raccolta, stoccaggio e tutto il resto. Adesso non va molto meglio, si arriva a 7, massimo 8 centesimi al chilo. L’alternativa, per un agricoltore, è raccogliere le arance, metterle nelle cassette e andarle a vendere all’ingrosso: «Ma il prezzo si fa ogni giorno, non sai mai quale sarà e comunque non ti pagano subito. I grossi acquirenti si spartiscono il mercato e, poiché la merce è deperibile, è chiaro che a un certo punto fanno scendere il prezzo e sei costretto a svendere». È la legge del mercato: da un lato produttori piccoli e frammentati, anche se con certificazioni di qualità o biologiche; dall’altro la grande distribuzione organizzata, che di fatto riesce a imporre i prezzi; nel mezzo, una filiera particolarmente costosa e inefficiente, che fa sì che comunque alla fine i prezzi sugli scaffali risalgano, e che dell’impoverimento del contadino non benefici il consumatore. Saltando tutti questi passaggi, ci guadagnano sia Michele che i suoi commensali: al gruppo romano le arance biologiche finiranno per costare 1 euro e 10 centesimi al chilo, un prezzo che non è superiore, anzi a volte è inferiore, a quello che pagherebbero al supermercato per arance non biologiche e di non certa provenienza. È vero che il produttore, Michele in questo caso, non le vende «sull’albero», ma deve metterci raccolta, cassette, trasporto. «Ma comunque, lo dichiaro apertamente a tutti i gruppi con cui vado a parlare, con questo prezzo a me restano 30 centesimi al chilo. Mi sembra un incasso onesto».
2. Dal gruppo al distretto
Il primo gruppo d’acquisto solidale (Gas) in Italia è nato a Fidenza nell’86, l’anno di Chernobyl. La volontà di controllare direttamente quel che arrivava nel piatto e il legame con l’impegno politico ecologista erano fin dall’inizio molto forti. Ma è degli anni Novanta il loro forte incremento, e l’inizio di un’evoluzione che man mano ha fatto loro cambiar pelle. Da un fenomeno di nicchia di consumo critico a una rete molto vasta che, crescendo, si è trovata alle prese con tutti i nodi che l’economia italiana e globale man mano poneva di fronte: la preoccupazione sulla salubrità dei cibi, alimentata dalle emergenze che si sono succedute l’una dopo l’altra; ma anche l’ondata della globalizzazione e dei consumi low cost, la problematica della grande e della piccola distribuzione, l’agonia del settore agricolo italiano, e – negli ultimi anni – l’impatto della crisi sui bilanci delle famiglie e delle piccole imprese. E, in positivo: l’aumento della consapevolezza diffusa sui temi ambientali; lo sviluppo del biologico, al quale i gruppi in Italia hanno contribuito in maniera decisiva; la maggiore facilità del mettersi in rete con gli strumenti della tecnologia dell’informazione; il sodalizio culturale e pratico con organizzazioni di produttori; lo sbarco nel campo delle energie alternative, per le quali la motivazione ambientalista (in larga misura scontata, per i partecipanti ai Gas) si è incontrata con una fortissima convenienza economica all’acquisto in gruppo, legata al meccanismo legislativo degli incentivi.
In linea generale, i Gas più che crescere si moltiplicano, perché un singolo gruppo diventa di difficile gestione se sale oltre una certa soglia di partecipanti. Esiste una rete nazionale di gruppi d’acquisto che sul finire del 2010 contava 720 gruppi. Iscriversi alla rete Gas non è un obbligo, e dunque si può presumere che esistano molti altri gruppi oltre a quelli registrati: gruppi più informali, che si formano tra colleghi di lavoro o genitori delle scuole o in condomini, magari in relazione a una fornitura specifica e motivati soprattutto dalla voglia di risparmiare. I gruppi che aderiscono a Retegas sono invece solitamente quelli più stabili e anche più sensibili a motivazioni che vanno al di là del semplice fatto che mettendosi insieme si risparmia. I loro numeri ci danno qualche indizio sulla diffusione del fenomeno: crescono annualmente a ritmi molto elevati – il 60% nell’ultimo anno –, e sono una realtà molto settentrionale. Nelle regioni del Nord opera il 56% dei Gas iscritti in rete, e quasi 200 sono in Lombardia, dove, secondo una ricerca realizzata nel 2009, quasi il 10% della popolazione ha partecipato o partecipa a un gruppo d’acquisto.
Una crescita del genere dà anche qualche problema. Come quello di mantenere la particolare declinazione di «piccolo è bello» propria dei gruppi d’acquisto: le relazioni dirette e non mediate tra i membri e con i produttori, il lavoro volontario. Finora la soluzione è stata cercata nella strategia delle reti. Sono nate 11 reti di Gas locali, ed è stata costituita una rete nazionale di economia solidale. Si sono inventati i distretti di economia solidale, che, alludendo nel loro stesso nome ai fortunati distretti industriali italiani, vogliono mettere insieme tutti i soggetti della filiera solidale: dunque i gruppi di acquisto, ma anche quelli che si occupano di finanza, le botteghe del commercio equo, le cooperative sociali, fino alle associazioni e ai comitati che si muovono sul territorio. Si è teorizzata la necessità di una «piccola distribuzione organizzata», in opposizione alla grande distribuzione organizzata che è capace di farti viaggiare un carciofo dalla Puglia all’Emilia Romagna per impacchettarlo e poi rimandartelo nei supermercati pugliesi. Sono nate forme di integrazione tra produttori e consumatori, che in alcuni casi sono formalizzate nei Godo, gruppi di offerta e domanda organizzata (la ricerca di nomi-bandiera in questo mondo è particolarmente curata). I Godo sono attivi soprattutto in Umbria, e vedono il mercato così: un tavolo di lavoro e discussione tra consumatori e produttori, nel quale, come è scritto in uno studio dell’Aiab, «i cittadini non sono trattati come semplici clienti ma come persone titolari di un diritto alla alimentazione alle quali comunicare la storia, la fatica e la qualità che stanno alla base dei cibi prodotti e venduti». Qualcosa di un po’ diverso dalla curva della domanda e dell’offerta che si studia al primo esame di Economia: da quel tavolo si cerca di far venir fuori un prezzo considerato giusto, da chi lo paga e da chi lo riceve. Tra la funzione dell’utilità individuale di qua, e la ricerca del profitto di là, c’è un fitto intreccio di relazioni e di motivazioni anche extraeconomiche che, nelle intenzioni dei Godo e del loro mondo, dovrebbe fare la differenza.
In altre esperienze, i consumatori solidali sono entrati direttamente in produzione. Ha fatto scuola il caso di successo della fabbrica «rilocalizzata» della Astorflex, calzaturificio veneto, che dopo aver portato all’estero per anni la sua produzione ha trovato conveniente aprire una linea tutta italiana, ecocompatibile, commissionata dal Gas del Nord-Est: all’inizio la nuova linea era poco più di una nicchia, accanto alle scarpe prodotte con materiali di bassa qualità e dove la manodopera costa di meno. Poi però gli stessi produttori si sono accorti che potevano essere convenienti, quelle scarpe ecologiche comprate dai gruppi, rispetto a scarpe prodotte all’estero che la grande distribuzione o i grandi marchi pagavano in fabbrica al massimo 20 euro al paio – per poi venderle nei negozi a 150 euro. Come nel caso dell’agricoltura, anche qui i Gas hanno spezzato la catena dell’intermediazione. Ancor di più hanno fatto per il caseificio Tomasoni, nel bresciano, che è stato letteralmente salvato dall’ingresso nel capitale dei suoi gasisti, che in questo caso si sono infilati nella accidentata filiera del credito. Il tutto è successo a cavallo della grande crisi dell’economia. Per una emergenza finanziaria dovuta al rincaro del prezzo del latte, il caseificio rischiava di chiudere: mancavano i liquidi, il necessario per acquistare il latte da cui fare i latticini. La cifra era minima: 150.000 euro. Ma nessuna banca, in particolare dopo la crisi del 2008 che ha fatto stringere i criteri del credito soprattutto a danno dei piccoli, era disponibile a coprirla. Massimo Tomasoni, uno dei titolari, ha chiesto aiuto ai Gas di cui era fornitore da qualche anno, dopo aver varato la conversione dalla monoproduzione del grana a una gran varietà di formaggi, tutti biologici. Nella lettera si spiegava quel che non andava, e il concreto rischio di fine delle produzioni. Ne è nato il primo salvataggio di un’azienda da parte dei suoi clienti: «A inizio 2009 nel giro di un mese un migliaio di famiglie di 90 Gas raccoglie i soldi che servono per il prestito, in parte sottoscritti come pagamento anticipato sul prodotto, in parte gestiti come finanziamento attraverso la cooperativa di finanza etica Mag2 Finance di Milano, che partecipa all’iniziativa con una parte del prestito – racconta un libro della Rete italiana di economia solidale dedicato al «capitale delle relazioni» –. Ora l’azienda si è ripresa».
3. Al mercato del sole
Storie come quelle del caseificio nel Bresciano o della fabbrica di scarpe veneta mostrano anche un altro aspetto della realtà dei gruppi d’acquisto: una volta che la rete c’è, il suo capitale di conoscenze, relazioni, socialità diventa una risorsa che si può spendere anche per altri problemi, altri temi che si impongano nella vita pubblica. Mettendo in rilievo il valore dei beni non monetizzabili e del capitale relazionale, e spostando così continuamente i confini del mercato, o meglio potenziando lo spazio che in esso hanno comportamenti non strettamente riconducibili a una logica di scambio basato sul tornaconto economico individuale. Allo stesso tempo, l’aggregazione dei consumatori è uno strumento potente anche sotto il profilo strettamente economico. Ne è un esempio evidente lo sbarco dei gruppi d’acquisto nel settore delle energie rinnovabili, nel quale alla predisposizione «naturale» dei partecipanti ai gruppi si sono aggiunti gli incentivi governativi: considerevoli, a patto di saperli usare, organizzarsi bene, fare i conti con una burocrazia pesante, e in più orientarsi in un’offerta molto diversificata sulla quale il consumatore medio aveva e ha poche informazioni. La situazione ideale per un approccio comunitario.
«Qui a Padova avevamo uno sportello energia, con il quale Legambiente voleva dare consulenze e aiutare la diffusione delle energie alternative, in particolare il solare – racconta Davide Sabbadin, ambientalista veneto –. Ma la gente veniva, prendeva informazioni e poi, travolta da mille intoppi e problemi, o da ostacoli economici, non ne faceva quasi mai niente. Un po’ frustrati da questo andazzo, abbiamo preso a modello alcuni gruppi che già in altri posti erano nati, e abbiamo inventato un sistema per facilitare la formazione delle comunità e l’accesso al solare: sistema che adesso è su internet, disponibile per tutti, chi vuole può prenderlo e rifarlo nella sua città». Il problema di base, direbbero gli economisti, è nell’asimmetria delle informazioni. Prendiamo i pannelli per il fotovoltaico da mettere sui tetti, all’apparenza un’operazione semplice. Spiega Sabbadin: «In un settore che era all’inizio del suo sviluppo, l’offerta sul mercato era – ed è tuttora – molto diversificata. Non basta mettere a confronto diversi preventivi: ce n’è di tutti i tipi, con prezzi diversissimi e soprattutto non fatti con criteri confrontabili. Così un singolo, o un condominio, che si trova di fronte a varie offerte di imprese non sa come regolarsi. E sul mercato ci sono moltissime marche, alcune ottime altre inventate per cavalcare l’onda del business. In più, c’è il fatto che chi fa una scelta di questo tipo è particolarmente attento anche ad altri aspetti del prodotto che compra: ad esempio, come è stato fatto, dove, quanto ha viaggiato per arrivare qui...». Per affrontare questo ginepraio, Sabbadin ha messo su un sistema basato sui gruppi. «Legambiente si pone come intermediario, come garante. Mette insieme le persone interessate all’acquisto dei pannelli, di solito sono 20 o 30 per ogni gruppo. C’è un capitolato tecnico di base, che viene mandato alle aziende del territorio. E dall’altro lato c’è una commissione fatta con i cittadini, i partecipanti ai gruppi, nella quale si valuta quale peso dare alle varie componenti del capitolato». Per esempio, un gruppo può dare più punti a un’impresa con finalità sociali (una cooperativa sociale, per esempio), oppure a quella più vicina sul territorio; può voler escludere dai soggetti finanziatori determinate banche oppure basarsi solo sul tasso di interesse che fanno; può chiedere di escludere materiali importati dall’estero, o da uno specifico paese. È questa la fase più partecipativa dell’intera procedura, nella quale le persone che comprano i pannelli devono mettersi d’accordo sulle motivazioni e le volontà da trasformare poi in capitolati e contratti. «Ma in linea generale, la motivazione più forte è quella economica: mettendosi insieme si risparmia, perché il produttore ha la garanzia di un ordinativo importante, c’è spesso anche una forma di garanzia sui pagamenti, e le banche finanziano l’operazione con prodotti specifici». L’intervento delle banche è importante: in sostanza, si tratta di anticipare guadagni futuri, quelli che le famiglie avranno con i contributi in conto energia e con i risparmi in bolletta – o rivendendo la loro energia solare sul mercato, se ne producono in eccesso. Con un buon accordo con i produttori e con le banche – quasi sempre banche popolari, a volte la Banca Etica o le mutue di autogestione, nei casi dei gruppi d’acquisto più attenti a tutti i passaggi del loro denaro – si può riuscire ad avere l’impianto solare anche senza sborsare un euro. Per questo la diffusione dei gruppi d’acquisto solare è stata molto rapida. A Padova, sono stati comprati e installati con il metodo qui descritto da Sabbadin ben 150 dei quasi 300 impianti esistenti; grande traffico anche sui tetti di Treviso, che ha importato lo stesso metodo dei gruppi e vanta ben 400 impianti allacciati; a livello nazionale, in pochi mesi il sistema dei Gas solari di Legambiente ha coinvolto 22 gruppi per circa 800 impianti. Con una diffusione quasi tutta concentrata al Nord – è il solito paradosso dell’energia solare, nel quale il nostro paese è arrivato molto dopo paesi dal clima piovoso e partendo proprio con le zone meno assolate –, ma anche con qualche benaugurante puntatina al Sud: «Possiamo vantare adesso di avere gruppi sia in Sicilia, nel comune con maggiore insolazione d’Italia, che è Modica, che in quello con minore insolazione, Gemona nel Friuli».
Un successo in gran parte legato agli incentivi e alla convenienza economica; ma che, coinvolgendo comunque gruppi provenienti da altre esperienze di azione collettiva, e temi fortemente sentiti dai consumatori «etici», permette di vedere qualche novità nell’evoluzione degli stessi gruppi, e del loro rapporto con i territori. «Questi gruppi sono un po’ diversi dal classico gruppo d’acquisto. Qui la motivazione prevalente è il risparmio, il mettersi insieme per avere un prodotto di qualità a un prezzo buono», continua Sabbadin. Ma nella piattaforma di base ciascuno può aggiungere o togliere motivazioni: lo stesso modello, importato in altri gruppi nati per obiettivi solidali e di giustizia sociale, può assumere connotati più forti. A Como per esempio la rete dell’Isola che c’è ha messo su un modello che propone, oltre al gruppo d’acquisto nel fotovoltaico, anche l’autocostruzione del solare termico e il finanziamento del progetto attraverso forme di finanza solidale. L’osservatorio padovano di Sabbadin, che si è fatto centinaia di assemblee di futuri acquirenti, permette invece di vedere quali sono le richieste prevalenti che vengono dai gruppi di acquisto meno politicizzati, con minore esperienza comunitaria alle spalle: «Noi chiediamo comunque alle imprese garanzie sul rispetto della legalità, sicurezza sul lavoro, correttezza fiscale. Poi, i singoli gruppi possono inserire i requisiti che vogliono. A volte...