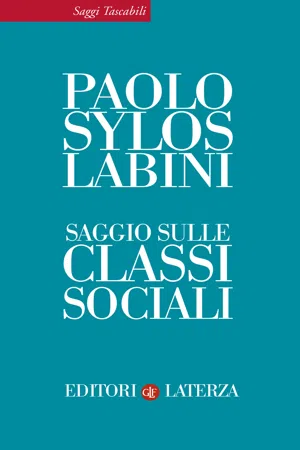
- 216 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Saggio sulle classi sociali
Informazioni su questo libro
Qual era lo scopo di Sylos Labini nel distinguere diverse classi sociali? Era uno scopo politico: capire come le persone si sarebbero comportate politicamente, non tanto nel voto, quanto nella costruzione di una società moderna. Innocenzo Cipolletta
A trent'anni di distanza è sempre bene rileggere il Saggio sulle classi sociali di Paolo Sylos Labini. Perché è rigoroso e al tempo stesso innovativo. Perché affronta la questione della 'struttura sociale' in modo stimolante e profondo. Perché il tempo non ne ha limitato l'attualità. Al contrario. Ilvo Diamanti
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Saggio sulle classi sociali di Innocenzo Cipolletta,Paolo Sylos Labini,Ilvo Diamanti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Économie e Histoire économique. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
ÉconomieCategoria
Histoire économique1.
Distribuzione del reddito
e classi sociali
La distribuzione del reddito nazionale costituisce il problema centrale degli economisti classici, particolarmente di Adam Smith e David Ricardo, i quali considerano essenzialmente tre grandi categorie di redditi, ossia tre grandi classi sociali: i proprietari fondiari (rendita fondiaria), i capitalisti agrari, industriali e commerciali (profitto) e i lavoratori dipendenti (salario). Per gli economisti classici la rendita urbana costituisce una sottocategoria della rendita fondiaria e l’interesse è – usando l’espressione di Smith – un «reddito derivato»: dal profitto nel caso di prestiti alla produzione, da uno degli altri due redditi nel caso di prestiti al consumo; generalmente, sono i mercanti che fanno prestiti allo Stato o a privati – Marx parlerà poi di «capitalisti monetari». I classici sono ben consapevoli che esistono i lavoratori indipendenti, al loro tempo molto numerosi: coltivatori diretti (farmers) e artigiani (independent manufacturers): costoro ottengono redditi che sono una combinazione di due o tre dei redditi originari sopra indicati; oggi parliamo di redditi «misti». Infine, ci sono tutti coloro che percepiscono stipendi o altri compensi dallo Stato o da istituzioni o da «ricchi»: sono tutti lavoratori «improduttivi», che ottengono redditi derivati (Smith, Ricchezza delle nazioni, ed. Cannan, Methuen, Londra, 1961, vol. I, p. 352, trad. dell’autore):
Il lavoro di alcuni dei più rispettabili ordini della società è, come quello dei servitori, improduttivo di ogni valore, e non si fissa o si realizza in alcun oggetto durevole o in alcuna merce vendibile... Il sovrano, per esempio, e tutti gli impiegati civili e militari che servono sotto di lui, l’intero esercito e l’intera marina sono lavoratori improduttivi. Essi sono servitori del pubblico e sono mantenuti con una parte del prodotto annuo dell’operosità degli altri... Alla stessa classe appartengono gli ecclesiastici, gli avvocati, i letterati di ogni genere, i medici, come pure i commedianti, i buffoni, i musicisti, i cantanti, le ballerine, ecc.
Mentre il concetto smithiano di lavoratori improduttivi è stato vivacemente attaccato dai successori degli economisti classici, la tripartizione smithiana dei redditi (e delle classi) è stata sostanzialmente accettata e tuttora si ritrova nei libri di testo di economia, anche se in questi libri si parla solo di redditi e non di classi; l’unico emendamento, per così dire, riguarda l’interesse, che è stato elevato al grado di reddito originario, imputabile al capitale e quindi al proprietario del capitale stesso, distinguendolo dal profitto, imputabile all’imprenditore. (L’emendamento è importante e si ricollega ad una certa evoluzione della teoria economica, che oggi è soggetta a critiche sempre più stringenti; ma su tale questione non mi soffermo). Un altro emendamento, che pochi economisti fanno ma che comunque deve essere fatto, riguarda la rendita urbana e i connessi guadagni speculativi: mentre al tempo dei classici era giusto considerare la rendita fondiaria come la categoria principale e la rendita urbana come una sottocategoria di secondaria importanza, oggi, col tumultuoso sviluppo delle città e, in certi casi, delle megalopoli, occorre rovesciare il giudizio sull’importanza relativa delle due rendite: oggi gli stessi spostamenti di ricchezza e la rapida formazione di cospicui patrimoni provengono spesso da speculazioni connesse con la rendita urbana, speculazioni nelle quali, oltre il mercato, entra il potere politico, al livello centrale o al livello locale; di più, quel che avviene in questo campo deturpa molte nostre città, ne rende penosa la vita e concorre grandemente a creare quella carenza di case a basso prezzo e quelle congestioni che, fra l’altro, facendo salire il costo della vita e sterilizzando una parte del potere di acquisto dei salari, contribuiscono a distorcere e a frenare il processo di sviluppo economico. (Tuttavia, non va soltanto rivisto il giudizio sull’importanza relativa sui due tipi di rendite: va rivista la stessa concezione degli economisti classici, anche sulla traccia delle analisi di Marx e di Engels, poiché la natura della rendita urbana è profondamente diversa da quella della rendita fondiaria).
Come eredità dei classici, è rimasto anche il concetto di reddito misto che, per definizione, costituirebbe una combinazione dei redditi originari. Gli stipendi degli impiegati pubblici continuano ad essere considerati quali redditi derivati, ciò che del resto è ovvio, essendo tali redditi pagati col gettito di tributi o contributi.
Già Marx aveva avvertito (Capitale, libro III, Editori Riuniti, Roma, 1965, p. 993) che quelli che oggi chiamiamo redditi «misti» (principalmente quelli dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei piccoli commercianti) avevano carattere pre-capitalistico e «solo fino ad un certo punto» potevano essere considerati come una combinazione dei tre redditi originari di Adam Smith. In verità, la teoria tradizionale, che accoglie acriticamente e senza qualificazioni una tale concezione, va riconsiderata a fondo: se fra i redditi «misti» e i tre redditi originari vi sono importanti elementi comuni, vi sono anche differenze profonde: perfino dal punto di vista quantitativo in pratica accade spesso (e non solo in Italia) che l’intero reddito di un piccolo coltivatore diretto, per esempio, che in astratto dovrebbe conglobare rendita, profitto e salario, è inferiore al solo salario medio pagato nel settore industriale moderno.
Per una tale revisione critica della teoria dei redditi misti che sono ottenuti dai così detti lavoratori indipendenti (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti, professionisti indipendenti), è necessario partire dalla distinzione fra beni che entrano e beni che non entrano in concorrenza con quelli prodotti da unità produttive moderne. Nel primo caso, vi sarà una tendenza alla graduale emarginazione e, a lungo andare, eliminazione dei produttori indipendenti, che appunto soccombono nella concorrenza con le unità moderne: su questa base Marx formulava la sua previsione della tendenziale scomparsa di quei gruppi sociali. Una tale tendenza, che è debole quando è lento lo sviluppo dell’industria moderna, forte quando questo sviluppo è rapido, può essere deliberatamente frenata dalla classe dominante, per mezzo di leggi e di altri interventi, proprio con l’obiettivo di una stabilizzazione sociale e politica. Così, in Italia è stato frenato il declino numerico ed economico dei coltivatori diretti, con successo fino alla seconda guerra mondiale, anche per il relativamente lento sviluppo industriale; in seguito, sia per il processo d’integrazione economica internazionale, sia per l’accelerazione dello sviluppo dell’industria moderna, i freni non hanno più funzionato o, meglio, sono solo serviti a rendere forse meno precipitoso il processo; in ogni modo, la flessione della massa dei coltivatori è stata non meno rilevante di quella dei salariati in agricoltura – essendo queste le due componenti dell’enorme esodo agrario che si è verificato nel dopoguerra (v. la tabella 1.1). Molto più efficaci sono stati e continuano ad essere gl’interventi a favore dei piccoli commercianti, il cui numero è andato crescendo e continua a crescere praticamente senza interruzione.
Riguardo ai coltivatori diretti, il processo di espulsione va studiato, da un lato, con riferimento ai prezzi e ai costi dei prodotti agricoli e, dall’altro, con riferimento alle possibilità di occupazione ed ai redditi (particolarmente ai salari) ottenibili nel settore moderno. Riguardo ai piccoli commercianti, occorre osservare che la concorrenza potenziale non proviene da merci ma da servizi, che potrebbero essere – e in misura nel nostro paese molto modesta sono – forniti da unità commerciali grandi ed efficienti. La legge e, sulla base della legge, gl’interventi amministrativi spesso semplicemente impediscono a queste unità di sorgere. Inoltre, in queste condizioni – a differenza di quanto accade per le merci – la concorrenza internazionale manca del tutto. Questa è una delle principali ragioni che spiegano il successo degli interventi pubblici a favore dei piccoli commercianti.
Nel caso di merci o servizi prodotti da lavoratori indipendenti che non concorrono ma anzi sono complementari rispetto alle merci o ai servizi offerti dalle unità moderne, non c’è quella tendenza al declino, ma anzi la tendenza opposta: ciò appunto si verifica per gli artigiani e i piccoli produttori che forniscono merci o servizi alle grandi unità, le quali cercano di utilizzare questi produttori per il proprio vantaggio. Un fenomeno analogo si verifica anche per le officine per la riparazione di automobili o di elettrodomestici o di altri oggetti o attrezzature domestiche. In ultima analisi, le unità artigianali di tipo moderno sono sempre direttamente o indirettamente satelliti delle grandi o grandissime imprese. In una situazione particolare si trovano i professionisti indipendenti (specialmente medici, avvocati, ingegneri, architetti): molti di questi professionisti sono oramai indipendenti solo di nome, poiché sempre più frequenti sono i casi di rapporti organici con grandi società e con istituzioni pubbliche; altri, tuttavia, sono effettivamente indipendenti, almeno entro certi limiti. Per questi professionisti, specialmente per quelli che riescono a raggiungere posizioni di rilievo, conviene usare come punto di partenza l’analisi del monopolio o del quasi monopolio, tenendo conto che i prezzi dei loro servizi – come anche, sostanzialmente, i prezzi dei servizi commerciali – non sono propriamente regolati dal mercato ma sono prezzi «amministrati» sulla base di intese tacite o espresse o di regolamenti di ordini professionali.
Vi sono infine gli stipendi degli impiegati, che l’analisi economica tradizionale assimila ai salari, cosicché la teoria del salario viene ad includere la teoria dello stipendio. Questo punto di vista va radicalmente riconsiderato.
Gli stipendi degli impiegati che operano in imprese o aziende pubbliche o private che producono merci o servizi nel mercato aperto rientrano nelle spese generali e sono in qualche modo collegati con l’attività produttiva, con i costi ed i prezzi, anche se il collegamento è diverso da quello dei salari, che di regola, almeno finora, rientrano nelle spese dirette e variano immediatamente al variare della produzione. Per gli stipendi di questi impiegati valgono, ma solo fino ad un certo punto, le analisi che si possono elaborare per i salari degli operai.
In una posizione particolare si trovano gli alti dirigenti delle società per azioni private e pubbliche, i quali ottengono emolumenti che solo per una parte hanno la natura di stipendi: per un’altra parte – la parte variabile – rappresentano una sorta di partecipazione ai profitti. Inoltre, fra gl’impiegati conviene distinguere gl’impiegati amministrativi dai tecnici, che sovraintendono agli impianti, alle macchine e ai laboratori. Per gli stipendi degli impiegati che lavorano in imprese o aziende che non producono merci o servizi per il mercato o che lavorano in pubbliche amministrazioni, i punti di contatto con la logica che regola i salari sono molto indiretti e limitati.
Perché il livello degli stipendi degli impiegati pubblici è quello che è? Perché varia?
Per rispondere a queste domande, occorre certamente considerare, come punto di partenza, il livello e le variazioni degli stipendi degli impiegati privati, così come, per comprendere il livello e le variazioni di questi stipendi, occorre partire dalla considerazione dei salari. Ma è solo il primo passo: analogamente ai lavoratori salariati, che nel periodo moderno non sono affatto costretti al livello di sussistenza, sia pure inteso in senso sociale o storico, anche i lavoratori stipendiati si battono per partecipare nella massima misura possibile al sovrappiù, o reddito nazionale netto, e al suo incremento. Sia i salariati che gli impiegati non si battono solo con l’arma dello sciopero, ma anche con mezzi più ampiamente politici, principalmente influendo sull’azione dei partiti che ne rappresentano gl’interessi per ottenere leggi e interventi amministrativi ad essi favorevoli. L’azione degli impiegati, tuttavia, è caratterizzata da almeno due importanti elementi differenziali rispetto all’azione dei salariati, uno a loro vantaggio, l’altro a loro danno.
L’elemento a loro vantaggio sta nel fatto che la gestione della cosa pubblica, come anche la gestione dei partiti, è in grandissima parte nelle mani di membri della stessa classe alla quale appartengono, la piccola borghesia, particolarmente della piccola borghesia impiegatizia, così che essi trovano i loro punti di forza, più che negli scioperi, nel campo degli interventi legislativi e amministrativi. Sia pure con un significato alquanto diverso, si può ripetere quanto Smith scriveva quasi due secoli fa (Ricchezza delle nazioni, cit., II, p. 395, trad. dell’autore):
Gli emolumenti dei funzionari sono forse, nella maggior parte dei paesi, più elevati di quanto occorrerebbe, poiché coloro che amministrano la cosa pubblica sono in generale inclini a remunerare se stessi e i loro immediati dipendenti piuttosto troppo che troppo poco.
Questa osservazione tuttavia, se vogliamo prendere Smith alla lettera, vale per gl’impiegati che dipendono immediatamente dai capi politici e amministrativi, i quali, oltre lo stipendio, hanno anche altri canali per attingere al «sovrappiù» – compensi speciali di vario genere, liquidazioni principesche e pensioni speciali. Vale anche per tutti quei funzionari e impiegati che riescono a conquistare posizioni di quasi monopolio e a difenderle con appropriate barriere istituzionali e legislative; ciò avviene, nel nostro paese, in certi settori della burocrazia, negli istituti di credito, negli istituti di assistenza e previdenza – prima charitas mea charitas –, in numerosi enti pubblici e in aziende municipalizzate. (Una particolareggiata analisi quantitativa degli stipendi e dei compensi dei gradi più elevati della burocrazia pubblica e degli enti di tipo pubblico sarebbe molto istruttiva; ma, per ovvie ragioni, è difficilissima da fare).
Il risultato delle spinte molteplici e d’intensità molto differenziata messe in atto dalle diverse categorie di dipendenti pubblici (in senso lato) è una impressionante varietà di retribuzioni, che di recente è stata illustrata con tanta efficacia da Ermanno Gorrieri. Questa varietà, a sua volta, costituisce una fonte inesauribile di agitazioni, poiché i gruppi che restano indietro compiono ogni sforzo per avvicinarsi, economicamente, a quelli che sono riusciti ad andare avanti; in queste agitazioni tutti i gruppi imitano la strategia e le parole d’ordine dei sindacati operai e qualche volta adottano perfino una fraseologia rivoluzionaria.
In queste agitazioni – che si aggravano nei periodi d’inflazione – prevalgono i gruppi che sono più compatti e più forti, per motivi economici (posizione di tipo monopolistico nel mercato) o istituzionali, o politici, o, spesso, per una combinazione di questi motivi. Restano indietro i gruppi più deboli, che generalmente si trovano negli strati intermedi o inferiori degli impiegati pubblici o parastatali. E qui compare l’altro elemento, quello sfavorevole, che differenzia gl’impiegati dai salariati: data la minore penosità del lavoro e data la garanzia della stabilità, la pressione dei candidati ai posti del pubblico impiego è forse perfino proporzionalmente maggiore dell’analoga pressione esercitata da coloro che vogliono diventare salariati – s’intende, nel settore moderno; comunque, le resistenze sono minori, perché nell’amministrazione pubblica sono ben più incerte e indefinite che nelle imprese di produzione le esigenze organizzative e amministrative. Il limite, a rigore, è dato dalla capa...
Indice dei contenuti
- Classi sociali e dinamica politica di Innocenzo Cipolletta
- L’intellettuale come riformatore di Ilvo Diamanti
- Prefazione
- Introduzione
- I. Tendenze di lungo periodo
- 1. Distribuzione del reddito e classi sociali
- 2. Cause della diseguaglianza nella distribuzione del reddito
- 3. Tendenze delle classi sociali
- 4. Nord, Centro e Sud
- 5. Marx e la piccola borghesia
- 6. La rapida espansionedella burocrazia privata e pubblica
- 7. L’ubiquità della piccola borghesia
- 8. Confronti internazionali
- 9. Piccola borghesia e fascismo
- II. Lo stato attuale e le prospettive
- 1. La questione delle riforme
- 2. Intellettuali e tecnici
- 3. I condizionamenti internazionali e le tensioni di origine interna
- 4. La sinistra tradizionale e i ceti medi
- 5. Sindacati operai e sindacati dei ceti medi
- 6. L’attuale crisi politica e la borghesia finanziaria
- 7. Un popolo di semianalfabeti
- 8. Contrasti economici e contrasti sociali
- 9. Il grande tiro alla fune
- Appendice Tabelle statistiche commentate
- 1. Le grandi classi sociali in Italia
- 2. Confronti internazionali
- 3. La distribuzione del reddito
- 4. Gruppi sociali particolari, occupazione nell’industriae occupazione precaria
- 5. Sindacati operai e sindacati dei ceti medi
- 6. Dati sull’istruzione
- 7. Stime e ipotesi sul comportamento elettorale